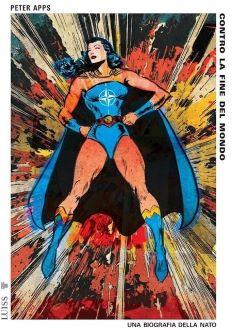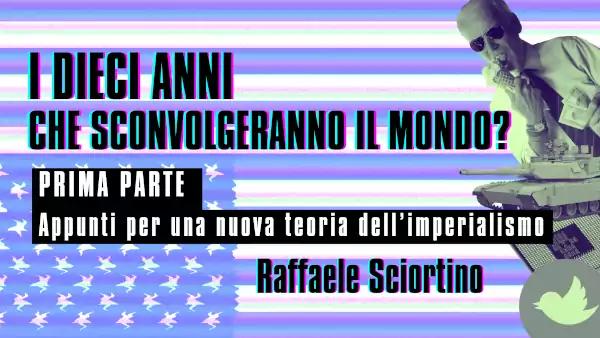
I dieci anni che sconvolgeranno il mondo? – Prima parte
Appunti per una nuova teoria dell’imperialismo
Sullo sfondo della guerra in Ucraina e della recessione economica globale, l’urto possente che segnerà il prossimo futuro e sta già rimodellando il nostro presente: lo scontro tra Stati Uniti e Cina.
È su questo cambiamento di fase che, sabato 3 dicembre, abbiamo voluto ragionare con Raffaele Sciortino a Modena, per costruire un punto di vista e un’analisi approfondita che non si trovano nelle aule universitarie, sui podcast di Dario Fabbri o tra le infografiche di Instagram. Allargando il campo sull’epoca dei torbidi e di caos crescente che avevamo già cominciato a decifrare nel Mondo di domani, nella precedente iniziativa con Raf e Silvano Cacciari, di cui avevamo già riportato gli interventi su questo blog.
È questo scontro, oggi, il nodo cruciale del sistema-mondo capitalistico, imperniato su una globalizzazione giunta a un punto di non ritorno, tra equazioni impossibili e necessità di rilancio. Un conflitto che non si limit_a alle sfere alte della politica e dell’economia, ma inciderà sempre di più nella vita quotidiana di milioni di persone, e non in modo secondario a queste latitudini.
Che forma prenderà il caos internazionale da un punto di vista di classe? Da quali contraddizioni strutturali si darà il senso di marcia dello scontro? Quali scenari si apriranno per il ritorno del conflitto sociale?
«Gli dèi della fortuna favoriscono solo chi si prepara…», si chiude così il libro che abbiamo voluto presentare. Pertanto, partendo da queste domande, ma soprattutto da questa indicazione di metodo, pubblichiamo in tre puntate il ricco intervento e il proficuo dibattito della presentazione di Stati Uniti e Cina allo scontro globale. Strutture, strategie, contingenza, ultima, preziosa e non semplice fatica di Raffaele Sciortino. In questo prima tranche, un’introduzione alla crisi della globalizzazione capitalistica a trazione americana, sviluppata sul dollaro e sul ruolo di ordine/disordine di Washington nel sistema-mondo, che traccia fin da ora qualche appunto per una nuova, e necessaria, teoria dell’imperialismo ancora da scrivere.
Per chi non si accontenta di quello che vede e sente intorno a sé. La posta in palio, le lotte di classe a venire, forse meno lontane di quanto si creda…
da Kamo Modena
* * * *
di Raffaele Sciortino
Grazie ai compagni per l’accoglienza qui a Modena, è sempre un piacere tornare. Non preoccupatevi, è sabato e cercherò di non ammazzarvi con la mia relazione. Vorrei fare giusto un’introduzione che disegni il quadro generale e lascerei piuttosto alla discussione i punti più controversi o comunque di maggiore interesse.
Se dovessi dirla tutta, il nocciolo segreto di questo libro è un invito a ritematizzare il concetto di imperialismo, inteso come struttura. Ovviamente non lo fa ritornando indietro a uno sguardo ideologico da anni Sessanta; e tuttavia resto convinto che su questo cardine si avvierà una discussione negli anni a venire, poiché ormai lo stato di cose lo impone, la situazione lo esige. Giustamente i compagni dicevano che ho tentato di affrontare questo problema assumendo un punto di vista di parte, che nel libro traspare al livello dell’inquadramento analitico.
Se dovessimo fotografare lucidamente, fino in fondo, al momento, le attuali dinamiche di classe e di movimento, dovremmo essere pessimisti. Questo non ci esime però dal delineare alcune tendenze che in futuro si incroceranno, che contrasteranno tra di loro, e che potrebbero – a date condizioni – aprire delle prospettive a oggi effettivamente molto remote. Per dare sostanza e concretezza all’elaborazione teorica e analitica, partirei dall’avere ben presente questo obiettivo.
Fotografiamo quindi la situazione da un punto di vista geopolitico iniziando da una premessa metodologica fondamentale. Mi riallaccio a quanto correttamente anticipavano i compagni: contrariamente a quanto si legge per la maggiore, quando parlo di geopolitica cerco di non limitarmi e di non ridurlo al conflitto di potenza tra grandi Stati, alla “tragedia delle grandi potenze”. Per quel che ci riguarda, “geopolitica” è un altro termine per dire “imperialismo”, ovvero economia concentrata la quale, quando le contraddizioni non sono più gestibili altrimenti, diventa sì scontro di potenza, ma al cui centro rimangono delle dinamiche profonde di accumulazione capitalistica, e dunque di rapporti di classe.
Ora, sotto questo aspetto noi notiamo un cambiamento cruciale, o perlomeno un inizio di un cambiamento di fase. Esattamente cinquant’anni fa, Nixon e Mao si incontravano per siglare un punto di svolta nel quadro della Guerra fredda. Eravamo ancora in piena Guerra del Vietnam, sebbene gli Stati Uniti cercassero di uscirne in tutti i modi (si noti, durante una presidenza repubblicana…). Si crea così il cosiddetto rapprochement, il riavvicinamento – diplomatico, prima, ed economico, poi – che apre il mercato mondiale alla Cina, presente e ancor vivo Mao.
Com’è noto, per definire la struttura geopolitica di allora, gli studiosi e i manuali di storia parlano di “bipolarismo” tra Usa e Urss. A ben vedere, però, proprio a partire dai processi antimperialisti e anticoloniali – detti oggi in una maniera politicamente neutra, se non ipocrita, “decolonizzazione” – in realtà la Cina si era già ritagliata un suo ruolo di spicco, che non la vedeva tanto come una potenza in senso militare e in senso classico, quanto come il vettore fondamentale, il motore pulsante di queste dinamiche anticoloniali. In ciò forte, ovviamente, del potenziale generato dalla sua popolazione, dalla sua antica civiltà, e dalla sua storia.
A uno sguardo più attento, quindi, si può osservare come già allora il bipolarismo si stesse in un qualche modo incrinando, andando a costituire quel riavvicinamento geopolitico-diplomatico che gli analisti oggi chiamano il “triangolo strategico”. Con questo termine si schematizza una situazione internazionale gravitante sulla superpotenza statunitense, sull’Unione Sovietica (allora considerata superpotenza, sebbene poi si vide che così non era), ma anche da un altro grande polo: la Cina, che da un punto di vista militare è una media potenza, e ciononostante inizia ad acquisire una rilevanza politica (in parte acquisita, in parte “concessa” dagli Stati Uniti) tale per cui può cambiare gli equilibri mondiali. Ecco il triangolo strategico.
E allora, cosa è veramente successo nel 1972? Ritorniamo al triangolo: il cateto che lega Washington a Pechino si accorcia, mentre va ad allungarsi sicuramente quello tra Pechino e Mosca (per ragioni che adesso non possiamo investigare qui; ma basti dire che c’era stata una rottura iniziale già dieci anni prima) e passo passo, da Reagan in poi, con la “nuova Guerra fredda” degli anni Ottanta, tra Washington e Mosca.
Certo, questa situazione non è l’unica causa dei rapporti internazionali a venire, che hanno sviluppi complessi; e tuttavia ha contribuito a disegnarne la linea principale. Si aggiunga che pochi allora la colsero, specialmente nel campo marxista, abbacinato o meno che fosse dal maoismo e dalla Rivoluzione culturale (che formalmente era ancora in piedi, per quanto in declino). Cinquant’anni dopo noi possiamo dare come tendenziale questo triangolo strategico; e tuttavia intravediamo già dei cambiamenti importanti che potrebbero persino andare a costituire una struttura nuova.
In primo luogo, non c’è più l’Unione Sovietica: c’è la Russia, che ora è senza dubbio il polo minore dei tre. Il grosso però di quello che sta emergendo è il riavvicinamento tra Mosca e Pechino, contemporaneamente all’allontanamento degli Stati Uniti dagli altri due. Queste trasformazioni lavoravano già nel sottosuolo, ma adesso, specialmente dall’Ucraina in poi, sono palesi.
Un secondo punto di cruciale importanza è che la globalizzazione non è finita, ma sicuramente si sta incrinando, dirigendosi al momento verso un rallentamento degli indici fondamentali (vi risparmio un’analisi tecnica). Non a caso, l’«Economist» parla di slowbalization – una globalizzazione che rallenta e che comunque corre incontro a delle contraddizioni che potrebbero anche aprire a una deglobalizzazione, la quale, ovviamente, non sarebbe un processo puramente economico.
Insomma, molti elementi ci fanno ipotizzare l’apertura di una nuova fase, che potrà durare anche decenni e i cui caratteri contribuiranno a definire come se ne uscirà, così come è avvenuto con il “lungo Sessantotto”. La grossa, ovvia, differenza sta nel fatto che oggi l’innesco del cambio di fase non è dato dalle lotte, né anticoloniali né operaie. Questo certo è una complicazione su cui riflettere; e però le dinamiche sociali ci sono. Una sorta di lotta di classe invisibile, comunque, rimane.
Di qui il piano inclinato dello scontro internazionale che – attenzione – non viene sollevato dagli analisti di professione. Emerge piuttosto dalle percezioni degli stessi due grandi attori, Pechino e Washington, se uno avesse la briga di analizzare la mole di letteratura e dichiarazioni ufficiali. Quantomeno per i cinesi è chiarissimo che si è chiusa definitivamente la fase iniziata con il riavvicinamento e se n’è aperta un’altra qualitativamente differente, rispetto alla quale occorre cambiare strategia.
A questo punto vorrei essere il più sintetico possibile, anche se i temi, come dicevano giustamente i compagni, sono complessi anche per me, e figuriamoci sintetizzarli in una relazione. A ogni modo, il punto mi pare questo: noi arriviamo sempre un po’ in ritardo. Ci stiamo chiedendo soltanto adesso cos’è stata la globalizzazione. E non mi riferisco qui a quella rappresentazione (apologetica o critica poco importa) che grossomodo riportava tutto al “neoliberismo” e così via: ci chiediamo cosa sia stata nel profondo per capire cosa si sta rompendo e che cosa potrebbe uscirne.
Dunque, non essendoci il tempo per una genealogia minuziosa, mettiamo almeno sinteticamente a fuoco i due aspetti fondamentali degli ultimi trenta-quarant’anni, centrali sia nella globalizzazione ascendente sia a partire dalla crisi del 2008-2009: il ruolo ordinativo degli Stati Uniti e l’inserimento della Cina nel mercato mondiale.
Letta attraverso il primo punto, la globalizzazione si disegna come il risultato di un insieme di assemblaggi. La maggior parte non preparati a tavolino, altri frutto di strategie. Per gli Stati Uniti il problema era molteplice: come uscire senza troppi danni dal pantano vietnamita; come reagire al “lungo Sessantotto” (ai movimenti dei neri, alle lotte operaie, eccetera); e come rispondere a un “Terzo Mondo” che aveva alzato la testa sull’onda delle lotte antimperialiste e anticoloniali, il quale ancora trovava una sponda (lasciamo perdere di che tipo) nell’Unione Sovietica. Quindi estreme difficoltà. Tant’è che negli anni Settanta il dibattito politico, sia negli ambienti borghesi che nei nostri, ruotava sul declino degli Stati Uniti.
In realtà non c’è stato nessun declino. Perché gli Stati Uniti sono rimasti gli egemoni mondiali? Non perché “sono una potenza” e quindi impongono una guida; al contrario, guidano perché hanno intrepretato al meglio il capitalismo nella sua complessità e individuato al meglio ciò che urgeva disperatamente all’accumulazione capitalistica per fuoriuscire dalla crisi degli anni Settanta, affrontandola a tutti i livelli (di conflitto di classe, di conflitto intercapitalistico e geopolitico, eccetera).
Che tipo di struttura ne è scaturita? Il punto di svolta emblematico – che fa il paio con il 1972, l’incontro Mao-Nixon di cui parlavo prima – è ormai universalmente individuato nello sganciamento del dollaro dall’oro, nel 1971. Come è noto, ciò conduce alla fine del sistema monetario di Bretton Woods istituito all’uscita dalla Seconda guerra mondiale, a sostituire in larga misura l’egemonia del dollaro a quella della sterlina, fino a elevare il dollaro a moneta mondiale (tenuto pur sempre conto della divisione del mondo in due blocchi).
Questo sganciamento, con le sue origini per certi versi contingenti – la globalizzazione è anche un assemblaggio di contingenze che poi si fa struttura –, si coniuga con delle strategie tutto sommato intelligenti da parte dell’amministrazione americana, si consolida, dura nel tempo e appunto si rilancia in avanti, rivitalizzando l’egemonia statunitense. Sostanzialmente si era partiti dal fatto che, per vari motivi, gli Stati Uniti avevano ormai una bilancia di pagamenti in deficit cronico (soprattutto per quanto riguarda le spese militari), la quale poi è andata ad assommarsi con una bilancia in deficit commerciale cronico (ovvero il rapporto import-export).
Detto in estrema sintesi: gli Stati Uniti escono dalla Seconda guerra mondiale come i banchieri del mondo. Prestanocapitali, investono all’estero e impongono la propria moneta. In parte questo era già successo dopo la Prima guerra mondiale ma, per motivi che adesso non possiamo tematizzare, non si era creata una struttura stabile. Ebbene, a partire dagli anni Settanta questi tendono a diventare il Paese debitore numero uno, con il più grande deficit della bilancia commerciale (quindi i più grandi importatori al mondo: ormai siamo a livello di 800-900 miliardi di dollari l’anno) e della bilancia dei pagamenti (che indica, lo ripeto, il flusso in entrata e in uscita di capitali).
La capacità, la grandezza e perché no, il colpo di genio (se vogliamo metterci al livello degli attori personali, per quanto la questione sia sul piano delle strutture) della dirigenza statunitense è stata nell’idea di usare l’indebitamento come leva per rilanciare l’egemonia. In tutta franchezza, sul fronte marxista dell’epoca praticamente nessuno lo aveva colto, perché si riteneva – con una lettura economica ortodossa e che di per sé sarebbe anche valida, ma non importa – che il deficit indicasse la perdita di terreno della produttività del sistema industriale relativamente alla concorrenza interna al campo occidentale (nella fattispecie, rispetto a Germania e Giappone); ciò significa che sei in declino, e dunque che scatterà presto o tardi una rivalità interimperialistica (appunto con Giappone e Germania, le sconfitte della Seconda guerra mondiale che si sarebbero risollevate e avrebbero rivaleggiato).
Con varie sfumature, la nostra lettura negli anni Settanta era sostanzialmente questa. Non è andata così.
Infatti, il dollaro sganciato dall’oro e trasformato in una moneta con cambi fluttuanti, legato a una bilancia dei pagamenti in deficit cronico, ha permesso di monetizzare i debiti. In una parola: da allora gli Stati Uniti si indebitano ininterrottamente nella propria moneta. È come se emettessero in continuazione un assegno in bianco o chiedessero dei prestiti a conti fatti irredimibili, dove tu praticamente ti indebiti e al contempo sei tu che emetti la moneta con cui quel debito dovrebbe essere ripagato. Non è forse questa una funzione parassitaria, da classico “sfruttamento parassitario della leva del debito”? Ebbene, non è esattamente così.
Non è esattamente così, per il semplice fatto che questo meccanismo ha permesso di avviare quella futura globalizzazione, che non è stata soltanto una congiuntura politica, ma un passaggio, uno stadio dello sviluppo del capitalismo che per la prima volta si è reso pienamente mondiale, costituendo quel mercato mondiale ipotizzato da Marx centocinquant’anni prima.
Gli Stati Uniti inondano di dollari il mercato mondiale (a maggior ragione quando imploderà il socialismo reale) e intanto inseriscono la Cina. In virtù della forza militare statunitense alle sue spalle, questo dollaro funge da liquidità internazionale sempre disponibile, allo scopo di “lubrificare” i circuiti di capitale e di merci che si globalizzano. La produzione si internazionalizza e nascono quelle che oggi si chiamano comunemente le “catene globali del valore” (o “catene di fornitura”, supply chains, e così via). Inoltre, grazie anche alla Guerra del Vietnam, gli anni Settanta sono anche gli anni in cui si inventa il container: si apre così la storia della logistica ipermoderna.
Occorre rilevare, infine, che questi circuiti di debito e credito su cui corre il dollaro inflazionato determinano la creazione di corridoi finanziari enormi, nonché delle relative bolle (che periodicamente esplodono). La finanza – ed è un punto di estrema importanza, da sottolineare con la massima chiarezza – ha quindi alla base l’internazionalizzazione della produzione. Di questo passo in breve la finanza (per dirlo un po’ metaforicamente) diventa costitutivamente un’anticipatrice del ciclo produttivo, spingendolo parossisticamente a mercificare, a “capitalistizzare” tutto il globo terracqueo. Al tempo stesso la finanza diviene una primaria regolatrice degli standard di valore.
È in tale contesto che il dollaro assurge effettivamente a moneta mondiale. Riassumendo, la situazione internazionale generatasi dalle trasformazioni del dollaro risulta chiaramente funzionale, in primo luogo, agli Stati Uniti per rilanciare l’egemonia economica – una traiettoria talvolta sintetizzata come “l’imperialismo finanziario del dollaro”. Di pari passo, infatti, questi complessi circuiti produttivi e di credito-debito consentono di stringere in un’unica maglia il mercato mondiale, anche tutte le altre borghesie e le altre economie e non più soltanto quelle imperialiste europee, facilitando così la fuoriuscita dalla crisi politica degli anni Settanta.
In questa mutazione dei rapporti economici internazionali, cosa conservano gli Stati Uniti? I livelli alti della produzione. È da lì che parte la rivoluzione informatica e digitale, mentre gran parte dell’industria a medio (e soprattutto basso) livello tecnologico e ad alta intensità di lavoro inizia ad essere delocalizzata. Si darà così il varo ai famosi processi di downsizing e di deindustrializzazione, prima negli Stati Uniti e poi estesi via via anche all’Europa, che spingono le manifatture verso la Cina con forza lavoro a basso costo (ne parlerò a breve). Si trasforma così la funzione ordinativa degli Stati Uniti rispetto alla Guerra fredda, già dieci-quindici anni prima che l’Urss crollasse, gettando i semi di quello che conosceremo come il capitale neoliberale. Ripeto, con una rendita di posizione chiarissima degli Stati Uniti. Perché?
Perché chiaramente il dollaro è una struttura, ma è anche una strategia, una leva della strategia statunitense. Al punto tale che da allora è possibile ricostruire i cicli economici anche seguendo l’uso “a fisarmonica” che gli Stati Uniti hanno fatto del dollaro (non è un’analisi originale mia, è una lettura che sta venendo fuori da parecchie parti). In taluni contesti si è trattato di riversare il dollaro sui vari mercati inflazionandolo inizialmente (sul lungo percorso, il prezzo del denaro inflazionato tende a svalutarsi) oppure, a date condizioni e quando se ne sentiva l’esigenza, rialzando i tassi attraverso la Banca centrale statunitense, la Federal Reserve, riattirando così i capitali.
A che fine? I più disparati: per ristrutturare la produzione industriale; per finanziare l’apparato militare mastodontico, che va ben oltre gli 800 miliardi di bilancio (pensate ai rapporti tra la “rivoluzione digitale”, la Silicon Valley e il Pentagono); per eventuali pacchetti di stimolo, come è avvenuto negli ultimi anni per il Covid sia con Trump che con Biden (somme che non hanno pari nemmeno rispetto al Next Generation EU); e permettere, soprattutto, la creazione di bolle finanziarie che vanno a razziare valore su tutto il globo terracqueo. Bolle che poi di volta in volta scoppiano e, quando scoppiano, si tratta di fare ricadere i costi sugli altri.
Per esempio, in Europa questo lo abbiamo visto nel 2010-2011 con la crisi dei cosiddetti “debiti sovrani”, nata dopo la catastrofe del 2008-2009 in cui chiaramente (o almeno, nella mia lettura) ancora una volta parte dei costi di questa crisi è stata riversata sul Vecchio continente. Oggi, con la guerra in Ucraina, siamo al secondo tempo dello scarico degli oneri. Aggiungo poi che negli ultimi mesi la Federal Reserve sta di nuovo alzando i tassi, sebbene ancora sia poco chiaro quale possano essere le conseguenze.
Torniamo quindi alla storia, se vogliamo comprendere bene il funzionamento di questo meccanismo.
Come si sa, a fine anni Settanta scatta la cosiddetta stagflazione, stagnazione + inflazione. Lotte operaie, la rendita petrolifera che sale (poiché, giustamente, i Paesi produttori di petrolio esigono una fetta maggiore dei profitti) e via discorrendo. Nell 1981 arriviamo al 19% di inflazione negli Stati Uniti. La Federal Reserve, guidata allora da Volker (da cui l’espressione Volker Shock), alza tantissimo i tassi di interesse, stroncando rapidamente, con una recessione durissima, tanto l’inflazione quanto le lotte operaie e le pretese del cosiddetto Terzo Mondo a un ordine internazionale più equo. Da lì procederà la controrivoluzione reaganiana, thatcheriana, eccetera, fino ad oggi.
Vi è poi un altro tema, che accenno soltanto: oltre alla strategia del dollaro a fisarmonica, gli Stati Uniti usano sempre più spesso il regime sanzionatorio. Dovendo tutti usare il dollaro, direttamente o indirettamente rientri nell’arbitraggio giudiziario degli Stati Uniti. Quindi o ti sanziono direttamente (tipo l’Iran o la Russia) oppure con le cosiddette sanzioni secondarie, cosa forse ancora più grave. Non so se state seguendo Priolo e la Lukoil… Insomma, perché le banche italiane (secondo me anche la stessa Eni, ma vedremo come va a finire) non erogano lettere di credito per acquistare il petrolio? Perché temono che gli Stati Uniti possano rivalersi con le sanzioni secondarie, vuoi mettendo multe, vuoi tagliandoti fuori. Negli ultimi anni ha dato delle multe pazzesche alla Deutsche Bank, alla Bnp Paribas e così via; e inoltre non è mai decollato il sistema di pagamenti internazionali alternativo europeo per poter commerciare il petrolio iraniano. Perché? Perché anche se l’Europa l’ha varato, le banche se ne guardano bene dall’adottarlo. Su questo discorso ci stanno ben attenti anche i cinesi.
Quindi, vedete, si è andato costituendo una struttura, un dispositivo, chiamiamolo come vogliamo, con una rendita di posizione statunitense – ma, durante la globalizzazione ascendente, a beneficio di tutti. Dico “vantaggio” ovviamente tra virgolette, poiché già allora la situazione era diversa a seconda della propria collocazione nella divisione internazionale del lavoro e a seconda del rapporto geopolitico intrattenuto con gli Stati Uniti: è ben diverso se sei un nemico, un rivale, uno Stato canaglia, o un alleato, un vassallo, un tributario. Ma attenzione (e su questo torneremo): questa struttura sta diventando sempre più onerosa. Questa rendita di posizione, questa funzione ordinativa in qualche modo si sta incrinando anche per gli alleati.
Il punto da evidenziare è che non siamo di fronte a un “declino” degli Stati Uniti (se non in termini molto relativi), quanto piuttosto alla difficoltà del sistema di cui gli Stati Uniti sono il perno. È una precisazione fondamentale, se non vogliamo ricadere in certe discussioni che non hanno portato a nulla, e trarre invece delle lezioni anche dagli anni Settanta.
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.