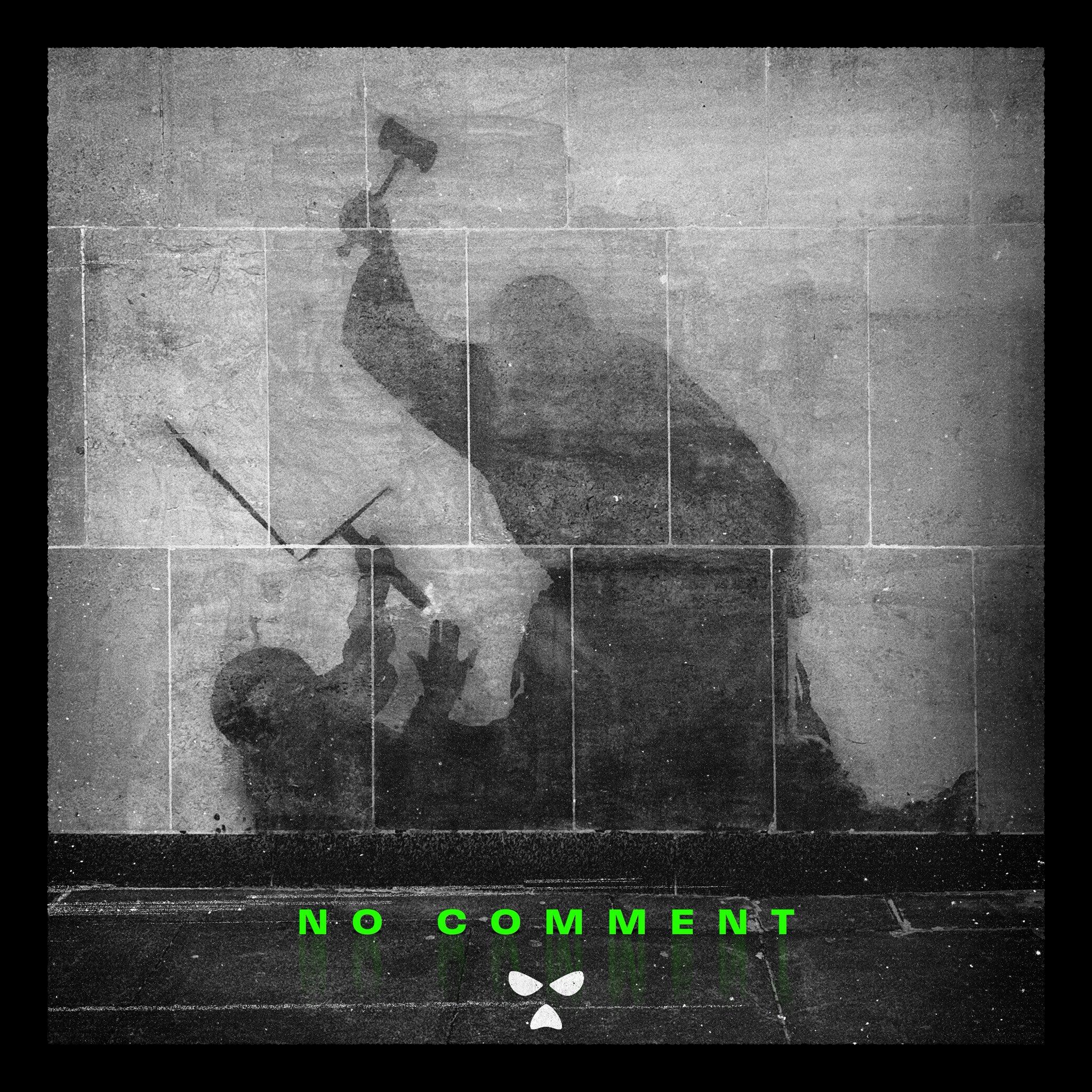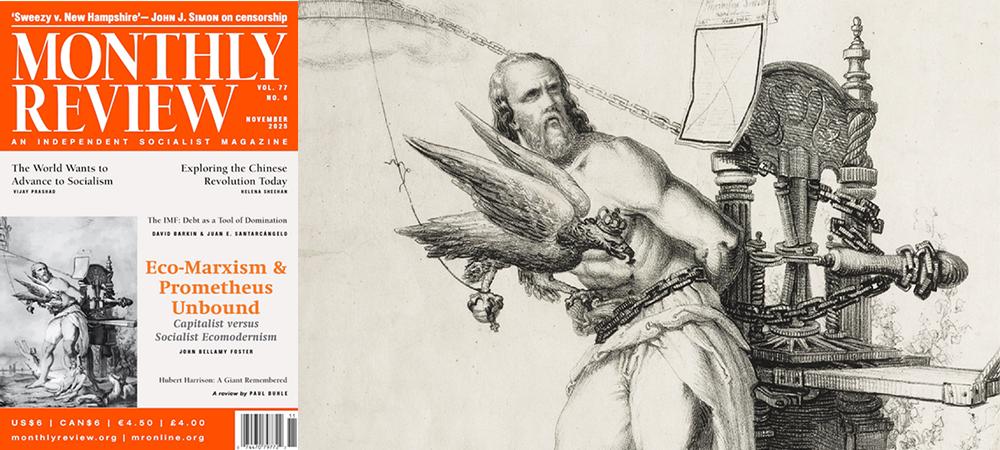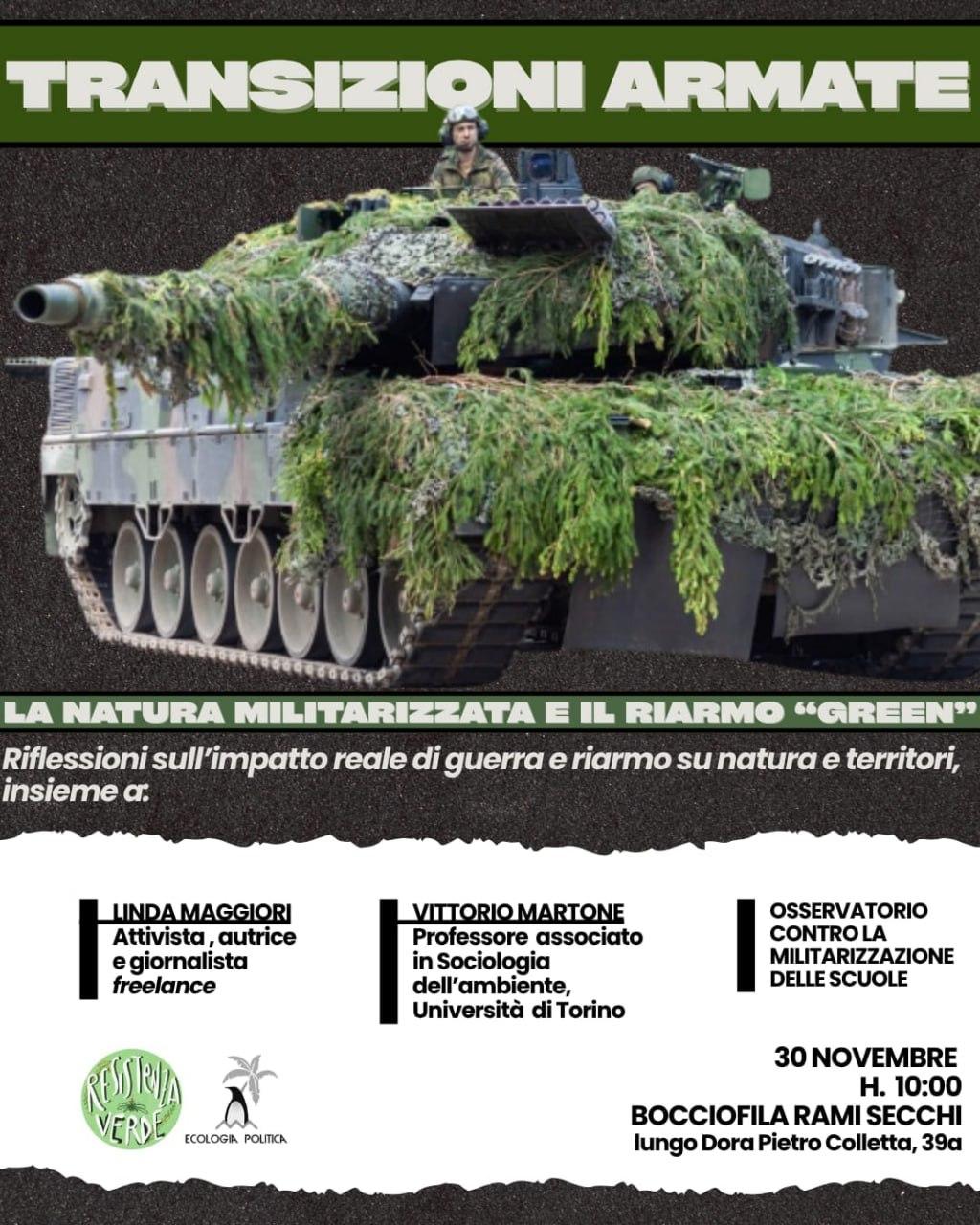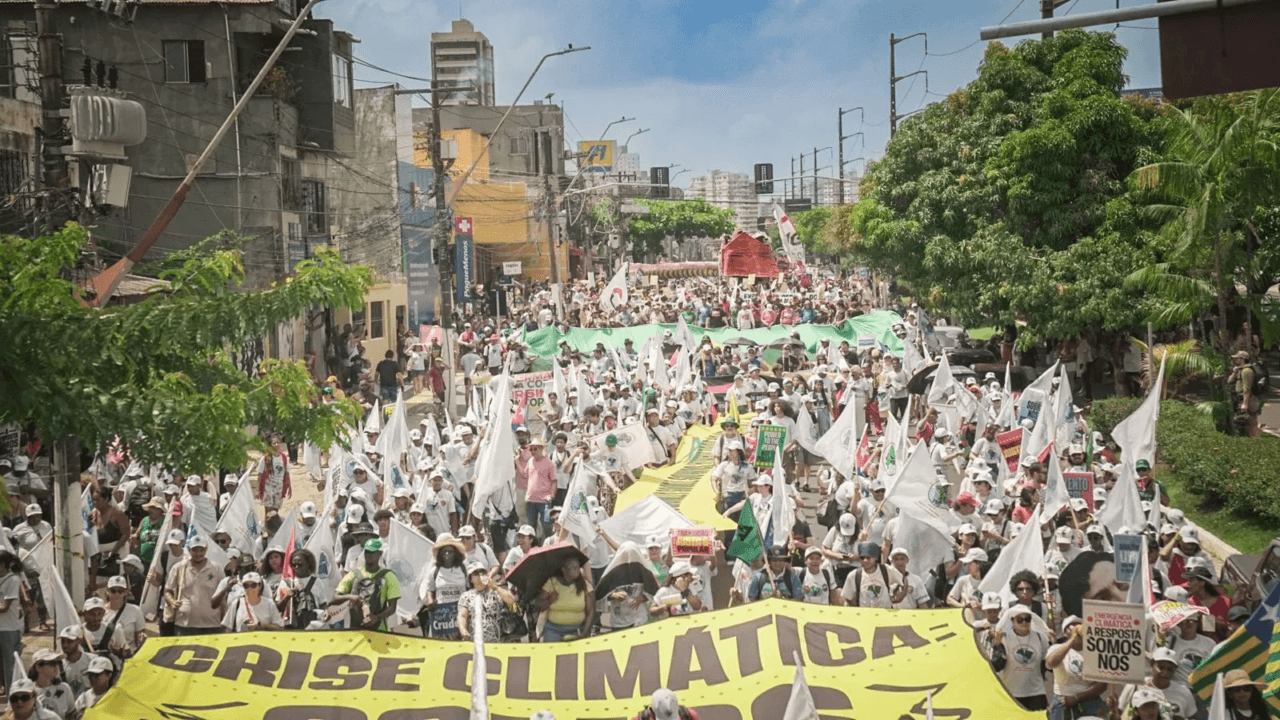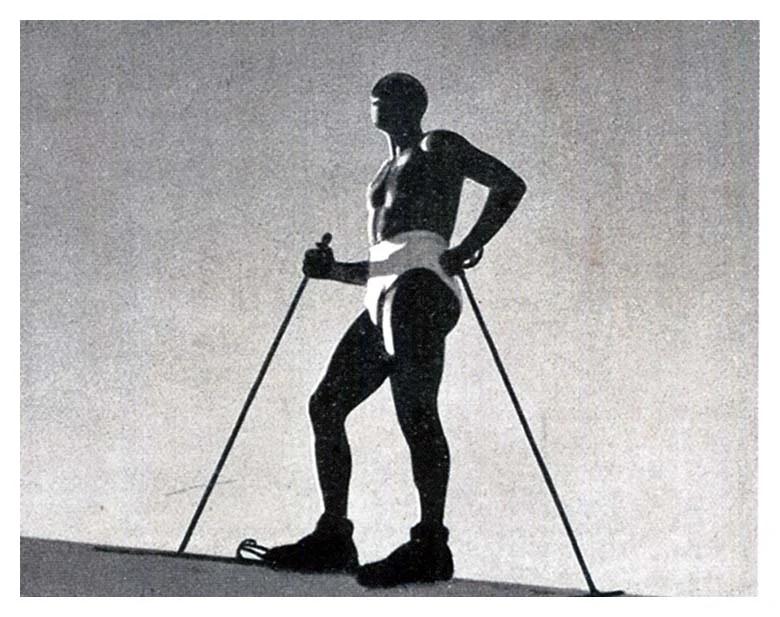
La messa a profitto della montagna. Intervista agli autori di «Inverno liquido»
Pubblichiamo un’intervista a Maurizio Dematteis e Michele Nardelli, autori del libro Inverno liquido. La crisi climatica, le terre alte e la fine della stagione dello sci di massa (DeriveApprodi, 2023), originariamente apparsa sulla rivista La nuova ecologia con il titolo «Non ci si salva da soli».
da Machina
L’intervista tocca alcuni dei temi trattati nel libro, come la nascita, lo sviluppo e la gestione dell’industria della neve e le ricadute sui territori.
* * *
C’è un momento in cui capisci che qualcosa è cambiato. Sei nato e cresciuto in montagna pensando che sarebbe sempre stato così. Poi un giorno ti svegli e gli impianti sono fermi. E capisci che quel mondo è scomparso. L’emergenza dettata dal Covid-19 ha messo a nudo tutta la debolezza del modello economico legato allo sci. In un’epoca nella quale il cambiamento climatico ne accorcia le stagioni e ne aumenta i costi di gestione, in cui la crisi economica lo rende uno sport elitario e il cambiamento culturale fa emergere un’altra domanda di svago, quale riconversione mettere in pista? Quali risorse attivare? E quali gli attori che possono entrare in gioco? In uno straordinario reportage, che dalle Alpi porta il lettore fino alle Madonie, in Sicilia, imprenditori, operatori e testimoni del mondo dello sci analizzano i fallimenti, spiegano i percorsi di riconversione e immaginano una rinascita. Ne abbiamo parlato con i due autori, Michele Nardelli e Maurizio Dematteis.
Nel vostro libro sostenete che stiamo attraversando una terra di mezzo fra il «non più» e il «non ancora». Potete spiegare ai nostri lettori cosa intendete?
Potremmo estendere il concetto al nostro tempo nel suo insieme, stretto fra un passato che incombe sul presente e un futuro sempre più incerto. Una transizione infinita che richiede il ripensamento di un modello di sviluppo che sta mostrando la propria insostenibilità e l’urgenza di un cambiamento del paradigma che ha segnato la modernità. In questo la montagna, nella sua fragilità, rappresenta l’ecosistema che più di altri segna una linea di confine tra quel che non possiamo più permetterci e quel che potremmo responsabilmente desiderare. Nel nostro lavoro abbiamo cercato di fotografare questa transizione.
Paragonate industria dello sci e fordismo. Che cosa hanno in comune?
L’industria della neve è stata un modello economico e culturale che ha portato prima a considerare la montagna come luogo in cui dirottare parte dei profitti dell’industrializzazione. Poi, con l’affermarsi del turismo di massa, alla creazione di un indotto e di un’attività manifatturiera per la produzione di attrezzature, abbigliamento, accessori… E ancora alla proliferazione delle seconde case come insana idea di inurbamento della montagna. L’industria dello sci ha cambiato nell’arco di qualche decennio il volto delle nostre montagne. Pur nella diversità di ciascun territorio, si è affermato un modello che ha fatto prevalere l’aspetto quantitativo alla qualità dell’offerta, con l’effetto di trasferire la dimensione urbana in contesti fragili, alterandone gli equilibri. L’industria dello sci, e l’arricchimento che ha portato con sé, ha avuto un carattere pervasivo, soppiantando l’economia tradizionale. Le grandi strutture alberghiere hanno marginalizzato quelle familiari imponendo filiere extraterritoriali e prezzi che a lungo andare hanno impoverito i territori. Una monocultura della neve che ha reso la montagna dipendente da un modello che mostra tutti i suoi limiti. Un po’ quello che è accaduto nelle città industriali come Torino, ancora alla ricerca di nuove identità.
A leggervi sembra che la gran parte delle stazioni sciistiche siano in perdita, tranne le più grandi… In tutto questo, Milano e Cortina ospiteranno le Olimpiadi Invernali del 2026. «Torino 2006» non è servita a nulla?
Imparare dal passato è come chiedere la luna. Ma i dati che riportiamo sono inequivocabili e la vicenda della realizzazione di nuovi impianti per il bob – quando quelli realizzati per le Olimpiadi 2006 sono in abbandono – è esemplare per comprendere ciò che non va fatto. È la logica dei grandi eventi che va ripensata, affinché possano divenire opportunità per ricadute sul territorio sul piano della vivibilità della montagna e di chi la abita dodici mesi all’anno.
Crisi climatica, scarsità delle risorse e aumento dei costi energetici fanno il resto. Si stima che il costo di un metro cubo di neve artificiale nel corso del 2022 sia triplicato. Ecco, se pensiamo che il 90% degli impianti dipende dalla «neve programmata» si può comprenderne l’insostenibilità e la continua richiesta di denari pubblici.
Come si esce dal circolo vizioso di aiuti pubblici da una parte e consenso elettorale dall’altra?
È questa la ragione che rende urgente un ripensamento. Non si possono rincorrere quelle che
chiamiamo emergenze ma che in realtà sono crisi che richiedono cambiamenti radicali. Bisogna dire le cose come stanno: siamo andati oltre. Purtroppo, gli effetti del Pnrr, con il finanziamento di progetti tirati fuori dai cassetti dove l’insostenibilità li aveva chiusi, non aiutano. Per dirlo con Laura Conti, «il momento in cui fermarsi è più facile è ora. Ora è più difficile di ieri, ma è più facile di domani». Sono trascorsi quarant’anni: non ci siamo ancora fermati.
Immaginando di dar voce a un responsabile della sicurezza dopo la caduta di una slavina, scrivete: «Chi è rimasto sotto era convinto di andare a Disneyland e sei tu ad averglielo fatto pensare». La questione sicurezza darà il colpo di grazia all’economia della neve?
Legambiente ha monitorato nei primi 7 mesi del 2022 ben 132 eventi estremi. Abbiamo ancora negli occhi quel che è accaduto sulla Marmolada e i mesi successivi non sono andati in controtendenza, da ultima la tragedia che ha colpito Ischia. La montagna va vissuta con rispetto, precauzione e senso del limite. Se diventa «divertimentificio» anche una normale slavina può avere conseguenze tragiche. Non sarà però il tema della sicurezza a indurci a modificare scelte e comportamenti. È la monocultura dello sci il nemico dell’economia della neve.
Dopo le Alpi, siete passati agli Appennini. Qual è la differenza più grande fra le due spine dorsali del Paese?
Le resistenze al cambiamento sono più forti dove è più artificiale l’ambiente costruito dall’uomo. Vale per le Alpi come per la dorsale appenninica. Può sembrare paradossale ma in quest’ultima, dove le precipitazioni nevose sono più rarefatte e le temperature più alte condizionano l’innevamento artificiale, l’accanimento terapeutico verso il vecchio modello continua a perseverare, dal Corno alle Scale alle Madonie. E più si insiste sulla vecchia strada, più il processo di abbandono delle terre alte fatica a trovare risposta. Qui misuriamo la distanza maggiore fra la politica e le istanze di rinascita dei territori. Perché malgrado il «non più» continui a generare i suoi effetti velenosi, la sfida del ritorno si arricchisce ogni giorno di nuove esperienze che solo in piccola parte abbiamo potuto raccontare.
L’alternativa, scrivete, non è tra il pieno dello sci di massa e il vuoto dell’abbandono ma un nuovo modo di abitare e vivere la montagna.
Inverno liquido racconta una serie di esperienze che stanno sperimentando un diverso approccio con la montagna e le unicità che la monocultura industriale ha a lungo soffocato: dalle esperienze di Prali alla Valpelline nelle Alpi Occidentali, dalla Val di Funes in Sud Tirolo alla Conca di Smeraldo nelle Piccole Dolomiti, dalle cooperative di comunità della Valle dei Cavalieri alla comunità Custodi del Monte Mutria nell’Appenino Meridiano. Vorremmo qui invece riferirci all’elaborazione seguita al ciclone Vaia, che nel 2018 ha devastato i boschi delle Dolomiti. Stiamo parlando di un lavoro che ha visto convergere nella riflessione sul «dopo» e nella realizzazione di un tavolo di lavoro oltre trenta realtà che mai si erano incontrate, rappresentando semmai istanze tra loro confliggenti. Mondi dell’ambientalismo e forestali, organizzazioni sindacali e Confindustria, cooperazione e biodistretti, università e luoghi formativi e di ricerca applicata, associazionismo e realtà culturali… insieme hanno elaborato un comune approccio sulle risposte da dare per diversificare e riqualificare l’intera economia dolomitica.
Descrivete il vostro lavoro come la genesi di una comunità di pensiero al lavoro su nuove piste.
È così. Mentre realizzavamo questo viaggio, reso possibile grazie a una fitta trama di relazioni costruite negli anni, sono emerse nuove piste di lavoro che richiedono uno spazio dedicato di approfondimento. E un patrimonio di idee e di esperienze che non potevano certo esaurirsi in Inverno liquido. E così, prima di inoltrarci nei 19 capitoli, abbiamo scritto una sorta di appello: «Non ci si salva da soli. Occorre incrociare gli sguardi, condividere le conoscenze, tessere le trame di alleanze ampie e plurali, dando vita a sempre più strutturate comunità di pensiero e azione. Per essere interpreti di un cambio di paradigma non più rimandabile. Per pensare insieme il mondo a venire. Questo libro va inteso come un numero zero, il primo passo di un collettivo di scrittura attorno ai nodi del passaggio epocale che stiamo attraversando». Ne abbiamo parlato con l’editore, immaginando una collana dedicata. E al posto dei ringraziamenti abbiamo postato un arrivederci al prossimo lavoro.
* * *
Maurizio Dematteis, si è laureato in Scienze politiche presso l’Università di Torino. Giornalista, scrittore e videomaker, si occupa di temi sociali e ambientali e di tematiche legate ai territori alpini. Dal 2009 è direttore responsabile del webmagazine Dislivelli.eu.
Michele Nardelli,formatore e saggista, è autore con Mauro Cereghini di Darsi il tempo (2008) e di Sicurezza (2018). Con Diego Cason ha pubblicato Il monito della ninfea. Vaia, la montagna, il limite (2020). È stato presidente del Forum trentino per la Pace e i Diritti Umani e co-fondatore di Osservatorio Balcani Caucaso. È stato consigliere regionale del Trentino Alto Adige/Südtirol
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.