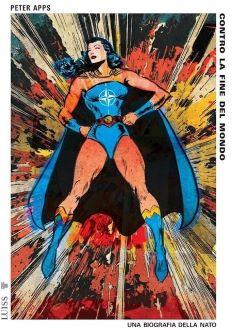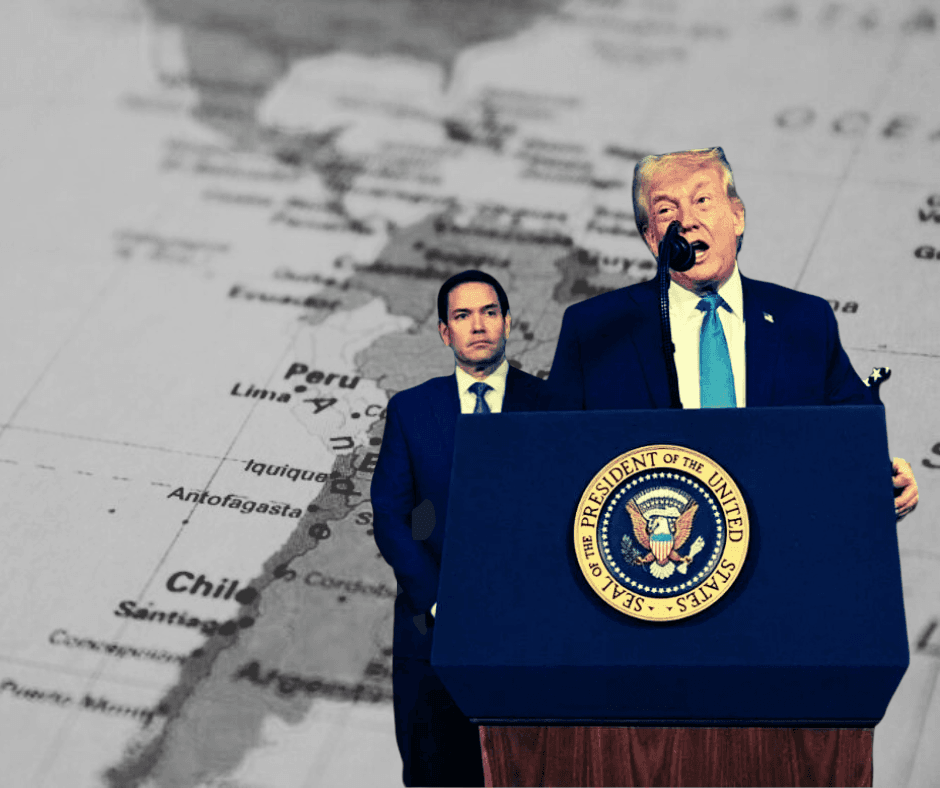Note preliminari sul «sistema degli Stati»
Pubblicato originariamente sulla rivista britannica «endnotes.org.uk» con il titolo di «Prologomena on the “System of States”», il saggio di Raffaele Sciortino e Robert Ferro, di cui qui presentiamo la traduzione a cura di Kamo Modena rivista dagli autori, offre alcune coordinate teoriche, a partire dai testi marxiani e da alcuni dibattiti successivi, per comprendere che cosa sono gli Stati e come funziona la loro articolazione in un sistema all’interno del «mercato mondiale», altra importante categoria marxiana. In tempi di sconquasso dell’ordine globale, il dibattito su questi nodi e il possesso di una griglia interpretativa teorica sono requisiti indispensabili se si vogliono comprendere e afferrare politicamente le trasformazioni in atto.
da Machina
***
Introduzione
È generalmente noto che Karl Marx, nel piano del Capitale, prevedesse una sezione dedicata allo Stato – sezione di cui non scrisse nemmeno una bozza. Dopo di lui, numerosi autori hanno insistito sull’incompletezza della teoria marxiana a questo riguardo, e benché nessuno di essi si sia prefissato il compito esplicito di portare a compimento il progetto originario di Marx, vi sono stati alcuni tentativi di colmare almeno parzialmente questa lacuna. Prendendo le distanze dall’opinione prevalente, in questo saggio si sostiene che lo Stato in quanto tale non presenta particolari ostacoli alla teoria marxista, e che il suo armamentario concettuale è sufficiente per condurne un’analisi esaustiva. L’articolazione a partire dalla quale la faccenda diventa più delicata risiede nel passaggio dall’astratto al concreto, che nell’opera di Marx coincide con la transizione dal concetto di capitale in generale alla molteplicità dei singoli capitali in concorrenza fra loro. Seguendo il metodo marxiano, ci proponiamo di delineare il passaggio dallo Stato capitalista in generale – nozione adeguata soltanto ai livelli più alti di astrazione – ad una pluralità di Stati che, agendo l’uno sull’altro, prendono posto in un sistema di Stati. A nostro modo di vedere, tale sistema, vera controparte politica del modo di produzione capitalista nella sua esistenza concreta, deve essere analizzato come parte di una totalità: il mercato mondiale. La sua logica fondante viene da noi individuata nell’indispensabile attività di organizzazione del mercato mondiale. Le implicazioni teoriche e politiche sono vaste e in larga misura inesplorate dalla ricerca marxista. Questa cornice interpretativa è finalizzata a permettere una miglior comprensione del mercato mondiale come spazio «prodotto», fortemente strutturato e mai preesistente alla sua formalizzazione istituzionale; al contempo, essa è da intendersi come un contributo alla rielaborazione su basi nuove dei temi della strategia e del potere, con riferimento alla prospettiva del superamento dei rapporti sociali capitalistici, che paiono oggi precipitare dalla crisi alla guerra.
La questione
Nel presente articolo, il nostro punto di partenza consiste in tre assunti di base che verranno dati per scontati nel seguito della discussione. Il primo è che il capitalismo – o, nella terminologia di Marx, il modo di produzione capitalistico (MPC) – rappresenta il modo di produzione prevalente nella storia moderna e contemporanea, e che tale prevalenza è andata solo accentuandosi nel tempo. Il secondo è che l’architettura politica predominante che affianca lo sviluppo del MPC su scala globale si presenta nella forma di un «sistema di Stati»[1], il quale emerge dalla generalizzazione planetaria dello Stato moderno (nazionale o multinazionale). Il terzo è che tale specifica forma di Stato, che si distingue dalle sue forme pre-moderne e pre-capitaliste, deve essere considerata come qualitativamente superiore rispetto alle istituzioni internazionali e sovranazionali – le quali sono, ai nostri occhi, escrescenze di singoli Stati o arene di cooperazione e di scontro tra Stati – e a maggior ragione delle istituzioni locali o regionali, componenti necessariamente subordinate di questi Stati (salvo diventare esse stesse degli Stati, attraverso movimenti separatisti).
Nell’ambito dello studio delle relazioni internazionali o della geopolitica, l’esistenza di tale sistema di Stati (o sistema interstatale) non sembra aver finora suscitato il bisogno di una delucidazione logico-filosofica: assunto come un dato di fatto, esso viene nel migliore dei casi associato alla diversità antropologica degli aggregati umani (famiglie, tribù, nazioni, ecc.). Alcuni autori della corrente realista, come John J. Mearsheimer, insistono nella fattispecie sull’impossibilità radicale per questi aggregati di raggiungere un accordo definitivo sui «principi primi» e su «cosa costituisca una buona vita»[2]. Questi autori, inoltre, riconoscono a giusto titolo la natura altamente competitiva del sistema interstatale, ma persino questo basilare attributo non sembra esigere una spiegazione cogente, eccezion fatta per il ricorso a considerazioni estremamente generali sulla natura umana o sull’incertezza strutturale delle relazioni interstatali. Come si vedrà, a parer nostro il problema risiede nella separazione metodologica tra lo Stato e la sfera economica. Purtroppo, nell’ambito delle relazioni internazionali, questa separazione viene contestata principalmente da correnti non-realiste (per esempio dalla teoria dell’interdipendenza economica), e principalmente al fine di contestare la stessa natura competitiva del sistema interstatale.
Nella visione marxista, la natura conflittuale di questo sistema appare connessa alla concorrenza economica che vede coinvolte, in diversi ambiti e a diversi livelli, le imprese – vale a dire porzioni di capitale che vivono o periscono a seconda della loro capacità di generare profitti. L’assunto qui implicito o esplicito è che la concorrenza economica tra imprese e branche dell’economia capitalista si trasferisce, in una maniera o nell’altra, sia alla politica interna (per esempio nella competizione tra partiti politici, o tra correnti nei sistemi a partito unico), sia alla politica estera. Mentre il carattere competitivo del sistema interstatale viene dunque concepito dai marxisti come una conseguenza del carattere concorrenziale dei rapporti economici, la ragion d’essere profonda del sistema interstatale stesso – ossia di un insieme articolato composto di una pluralità di Stati interagenti – viene collegata a due opposte spiegazioni. La prima considera tale pluralità una sorta di retaggio delle condizioni in cui il MPC è emerso storicamente da società pre-capitalistiche. Questa visione, che si può trovare ad esempio negli scritti di Robert Brenner[3], sostiene che la formazione di un unico super-Stato globale, benché improbabile, sia più conforme al MPC. La seconda posizione, al contrario, concepisce la pluralità di entità statali come una componente conforme al MPC nella sua esistenza concreta, postulando un nesso forte, necessitante, tra il livello economico (i molti capitali concorrenti) e il livello politico (i molti Stati), senza tuttavia riuscire ad argomentare questa correlazione in maniera soddisfacente. La divergenza teorica qui evidenziata può essere riassunta come opposizione tra uno storicismo forse efficace sul terreno della ricerca empirica, ma concettualmente debole, e uno strutturalismo che fallisce precisamente sul suo terreno di predilezione, quello logico-concettuale, nella misura in cui si dimostra incapace di dedurre il sistema interstatale dalle categorie analitiche più astratte del MPC. L’obiettivo di questo articolo, evidentemente, non è estraneo alle preoccupazioni del secondo approccio appena menzionato. Ciononostante, il nostro metodo differisce da quest’ultimo poiché non procede dalla separazione di teoria e storia, ma si sforza piuttosto di integrare la seconda alla prima, seguendo il percorso dello stesso Marx nel Capitale[4], dove la sistematizzazione dei concetti e dei rapporti che intercorrono tra di essi non risultano «né [da] una serie puramente logica, né si ordinano secondo la fatticità puramente storica»[5].
Data la dimensione del problema e i limiti di spazio, non offriremo una rassegna della letteratura sulle teorie marxiste dello Stato, o un riassunto dei dibattiti marxisti sullo Stato, ma ci limiteremo pressoché esclusivamente al testo marxiano, con l’intento di isolare le fondamenta di qualunque teoria marxista dello Stato. In un secondo momento, ne valuteremo i limiti ai fini dell’elaborazione di una teoria del sistema interstatale, e procederemo all’inventario dei materiali e delle nozioni marxiane potenzialmente attivabili in questa direzione. Per le ragioni summenzionate, faremo un uso piuttosto parco delle citazioni, fornendo però al lettore tutti i riferimenti bibliografici per verificare l’attendibilità delle nostre tesi e riservando per il futuro eventuali sviluppi ulteriori.
Lineamenti di una teoria marxista dello Stato
È generalmente noto che Marx non riuscì a scrivere il libro o la sezione sullo Stato previsto nel piano (più volte rimaneggiato) del Capitale. Nondimeno, lo Stato è tutto fuorché assente dal suo quadro teorico. Oltre alle innumerevoli osservazioni e commenti sul tema disseminate nelle sue opere giovanili o storico-politiche, lo Stato è presente – ora in maniera implicita, ora esplicita – anche nel suo opus magnum e nelle sue bozze o lavori preparatori[6]. Si può infatti sostenere, sulla scorta di Tran Hai Hac[7], che il concetto di MPC implichi necessariamente quello di Stato, e che la delucidazione dell’aspetto politico (cioè relativo allo Stato, per l’appunto) inerente ai concetti di forza-lavoro, denaro e rendita fondiaria capitalistica sia un elemento cruciale del progetto critico marxiano inteso come una critica della economia politica, perciò radicalmente distinto da qualsiasi economia politica critica. In termini più generali, diversamente dall’economia neoclassica, che sostiene une presunta tendenza all’equilibrio per negare ogni necessità di iniziative non private, la posizione marxiana si caratterizza in primo luogo per la sua negazione di qualunque propensione spontanea del MPC all’armonia[8]. La tendenza reale – dice Marx – evolve verso uno squilibrio che deriva, in ciascuna delle sue manifestazioni, dal duplice carattere dell’economia capitalista. Il capitalismo è, al contempo, un intreccio di produzione e circolazione di valore (o, in termini più empirici, un sistema di prezzi) e un processo materiale, il cui andamento – anche in condizioni ottimali dal punto di vista dei rapporti di valore – è sempre esposto al rischio della disorganizzazione. Sebbene il MPC non scateni permanentemente crisi e recessioni, i rapporti tra capitalisti e lavoratori, o i rapporti reciproci tra imprese o settori produttivi, sono potenzialmente portatori di perturbazioni spesso prive di qualsiasi effetto stabilizzatore endogeno. Data questa condizione di congenita instabilità, la riproduzione allargata del MPC non è mai un esito scontato, e presuppone ad ogni istante la funzione orientativa dello Stato sul capitale privato.
Questa inscrizione immediata dello Stato nella sfera dell’attività economica contraddice le rappresentazioni abituali, ereditate dall’economia politica classica, di uno Stato il cui «intervento» in campo economico (opportuno o meno, desiderabile o meno) verrebbe in ogni caso condotto «dall’esterno». Nella visione marxiana, la specificità dello Stato risiede nella sua capacità di svincolarsi dai meccanismi di formazione e ridefinizione del saggio di profitto medio o, detto più semplicemente, di creare, dentro al campo stesso delle forze economiche, una sfera di attività al riparo dalla concorrenza e dal criterio della redditività in senso stretto. Ciò non equivale però a situare lo Stato al di fuori del campo degli agenti economici. L’imperativo della riproduzione di rapporti economici determinati all’interno di un modo di produzione che non possiede alcuna tendenza naturale all’equilibrio richiede tanto l’esistenza di una simile sfera, quanto la sua effettiva espansione sul filo del processo storico. Il carattere multidirezionale e potenzialmente onnicomprensivo dell’attività dello Stato nella sfera economica esige dunque una relativa autonomia dagli interessi particolari e a breve termine tipici degli attori economici privati. La ragione di ciò può essere chiarita solamente ponendo in rilievo la natura decisiva della posta in gioco: la perpetuazione della società secondo assetti ben definiti, ovvero il contrasto effettivo delle spinte autodistruttive inscritte nel suo funzionamento fondato sui rapporti sociali capitalistici. Ad un livello superficiale, questa affermazione potrebbe apparire contraddittoria rispetto alla natura di classe dello Stato rintracciata dalla concezione marxista, ma così non è. Bisogna far qui intervenire la frammentazione della classe capitalista, che nella sua totalità condivide un unico interesse comune, di natura estremamente generale: il mantenimento/approfondimento del processo di estrazione di plusvalore. Per sopravvivere in maniera effettuale come polo dominante della società, la sua unità deve concretizzarsi come una forza distinta dall’ambiente imprenditoriale strictu sensu, e per giunta capace, se necessario, di imporsi su tutti gli attori particolari, sempre suscettibili di perseguire i rispettivi interessi anche a discapito della sostenibilità dei rapporti di produzione esistenti. Ciò detto, diamo un rapido sguardo alle forme e modalità principali in cui l’attività statale appare nell’opus magnum marxiano.
Condizioni della compravendita della forza-lavoro
Secondo la teoria del Capitale, i rapporti sociali capitalistici coinvolgono tre categorie economiche: capitale, lavoro salariato e proprietà fondiaria. Il rapporto tra lavoro salariato e capitale è il più fondamentale del triangolo, in quanto crea la sostanza economica che viene spartita fra le tre le categorie (il valore). Il primo momento di questo rapporto consiste nella compravendita della forza-lavoro, allorché lavoratori e capitalisti fissano i termini dello scambio tra lavoro e capitale in base allo stato vigente dei rapporti di forza. Lo Stato gioca un ruolo fondamentale nella trasformazione della forza-lavoro in merce, sia dal punto di vista della sua genesi e del suo iniziale sviluppo, sia della continuità del processo su scala allargata. In diversi scritti, Marx e Engels fanno notare che nelle società precapitalistiche, sin dall’antichità, lo Stato, e soprattutto l’esercito, hanno ospitato le prime forme di lavoro salariato[9]. Agli albori della modernità, quando la comparsa del lavoro salariato inizia a diffondersi nell’economia privata dei centri urbani, l’intento dello Stato di consolidarlo ed estenderlo alle campagne, dove ancora si concentra la parte più consistente del processo economico, risulta decisiva. A tal fine, occorre procedere alla separazione dei lavoratori dai mezzi di produzione, sia in termini di proprietà che di possesso. Ciò avviene attraverso misure coercitive introdotte appunto dallo Stato: enclosures, esproprio dei contadini indipendenti, nuove leggi contro il diritto consuetudinario (sulla raccolta di legname, sul bracconaggio, ecc.) o contro il vagabondaggio, ecc. Il capitolo 24 del Libro I del Capitale, dedicato alla «cosiddetta accumulazione originaria»[10], ne fornisce l’esemplificazione per l’Inghilterra, dove la formazione di capitale è endogena. L’ultimo capitolo del Libro I, «La teoria moderna della colonizzazione»[11], descrive invece l’espropriazione dei produttori diretti in aree in cui la formazione di capitale non è endogena. Marx scrive che «la borghesia, al suo sorgere, ha bisogno del potere dello Stato»[12], e descrive i mezzi che essa impiega come «atti di violenza diretta»[13], in un certo senso «extraeconomica»[14] sebbene «la violenza […] è essa stessa una potenza economica»[15]. Nello stesso modo in cui lo Stato crea le condizioni del rapporto tra lavoro salariato e capitale, esso istituisce parimenti la proprietà fondiaria capitalista, poiché anch’essa – a differenza della proprietà fondiaria feudale, che garantiva l’uso della terra al servo e di fatto incatenava l’uno all’altra – presuppone la separazione dei lavoratori dai mezzi di produzione[16].
Tuttavia, come scrive Marx, «non basta che le condizioni di lavoro si presentino come capitale a un polo e che all’altro polo si presentino uomini che non hanno altro da vendere che la propria forza-lavoro. E non basta neppure costringere questi uomini a vendersi volontariamente»[17]. Anche dopo aver conferito un carattere irreversibile e una certa taglia critica al rapporto tra lavoro salariato e capitale, la sua continuità richiede che lo Stato garantisca sempre e comunque l’incontro quotidiano tra i venditori e gli acquirenti di forza-lavoro, possibilmente in condizioni favorevoli ai secondi. Con lo sviluppo della produzione capitalistica, la continuità dello scambio tra lavoro e capitale avviene sempre più «naturalmente», in virtù delle condizioni economiche prevalenti e della loro forza oggettiva. Ciononostante, «si continua, è vero, sempre ad usare la forma extraeconomica, immediata», seppur «solo per eccezione»[18].
Condizioni del consumo della forza-lavoro
Nella concezione marxiana, il profitto industriale non è che una delle forme «metamorfosate» del plusvalore. Le altre sono l’interesse e la rendita fondiaria. Ma affinché la ripartizione del plusvalore abbia luogo, remunerando così anche gli attori sociali non direttamente coinvolti nella sfera della produzione, è pur sempre necessario che il plusvalore venga prodotto. Ciò avviene in due modalità fondamentali: la produzione di plusvalore assoluto, basata sull’aumento delle ore di lavoro, e la produzione di plusvalore relativo, basata sull’aumento della produttività attraverso l’investimento in macchinari.
Ne consegue inevitabilmente che queste due modalità di produzione di plusvalore siano anche due diverse maniere di affrontare la definizione della giornata lavorativa «normale» e socialmente accettata. Lo Stato prende parte a questo processo definitorio – che include la regolazione della giornata lavorativa, ovvero dei suoi limiti legali – ora sostenendo le spinte interne alle imprese, ora contrastandole. Il problema della regolazione della giornata lavorativa compare nel Libro I del Capitale, in particolare nel capitolo 8 («La giornata lavorativa») § 5-6[19] e nel capitolo 13 («Macchine e grande industria»), § 9[20]. In questi passaggi, Marx evidenzia che lo Stato inizialmente promuove il plusvalore assoluto attraverso legislazioni specifiche, in combinazione coi processi di espropriazione già menzionati, con l’obiettivo di radicare la propensione al lavoro salariato nel tessuto sociale. In uno stadio successivo, lo sviluppo di una nuova base tecnica per il processo lavorativo – nella fattispecie, la transizione dalla manifattura alla grande industria – rende teoricamente possibili degli incrementi di produttività senza precedenti, non più connessi all’allungamento della giornata lavorativa. Ciononostante, la transizione dal plusvalore assoluto al plusvalore relativo non è mai automatica. Per realizzarsi, sono necessarie due condizioni: la resistenza dei lavoratori e una legislazione che limiti la giornata lavorativa. Nell’introdurre simili norme, lo Stato agisce certo con riluttanza, sotto la pressione della contestazione sociale; ma nel lungo termine agisce comunque nell’ottica della riproduzione, giacché promuove un impiego della forza-lavoro meno estenuante e distruttivo.
Industrie di Stato
Fino ad ora abbiamo commentato dei passaggi relativamente conosciuti del Libro I del Capitale. È meno noto invece che il Libro II si soffermi anche su casi in cui lo Stato assume direttamente il ruolo di capitalista, ovvero di proprietario dei mezzi di produzione e di direttore del processo lavorativo. Marx specifica che questo coinvolgimento nel processo di produzione immediato non pregiudica necessariamente la natura capitalistica delle attività economiche intraprese dallo Stato, poiché «il capitale sociale è uguale alla somma dei capitali individuali (compresi i capitali per azioni, e rispettivamente il capitale dello Stato, in quanto i governi che impiegano lavoro salariato produttivo in miniere, ferrovie, ecc., operano come capitalisti industriali)»[21]. Vi sono inoltre settori della produzione sociale che risultano assolutamente indispensabili al capitale privato nel suo complesso, ma che per caratteristiche loro proprie corrispondono male all’imperativo della redditività. Su tutti, è il caso di quelle infrastrutture materiali che vengono talvolta descritte come «monopoli naturali». Gli investimenti necessari alla loro costruzione richiedono generalmente tempi di rotazione estremamente lunghi. In estrema sintesi, il tempo di rotazione è il tempo necessario a un capitale dato per tornare alla sua forma iniziale dopo aver percorso tutti i momenti del suo ciclo (D-M-D’). A tal proposito, Marx contempla la possibilità secondo cui «imprese che esigono un lungo periodo di lavoro, quindi un grande esborso di capitale per un tempo piuttosto lungo, soprattutto se attuabili soltanto su vasta scala, […] non vengono affatto compiute capitalisticamente, come ad es. strade, canali ecc. [realizzate] a spese dei comuni o dello Stato»[22]. Nei due casi qui menzionati – industrie statali volte alla redditività da un lato, e industrie destinate a una gestione non redditizia dall’altro – il passaggio al controllo statale sottrae l’impresa alla concorrenza di mercato, e dunque alla perequazione del saggio di profitto. Se tale impresa è caratterizzata da una debole redditività, come spesso accade nella pratica, ciò determina un incremento del saggio medio di profitto nel settore privato.
Condizioni per la circolazione di valore
Contrariamente all’opinione dominante, la teoria monetaria del Capitale non propugna una concezione «neutra» della moneta, che la vedrebbe come una semplice intermediaria per rapporti di scambio che avverrebbero altrimenti tramite baratto. L’idea del denaro come equivalente generale implica che il denaro venga ricercato in quanto tale, in virtù del suo specifico valore d’uso – vale a dire della capacità di scambiarsi contro qualsiasi altra merce, qui ed ora o in un secondo tempo, e non soltanto di fungere come un mero intermediario per acquisire tale o tal’altra merce. In aggiunta, la scissione merce-denaro, che pone una merce come equivalente generale di tutte le altre, separa questa stessa merce da tutte le altre. Ne consegue che, sebbene nell’ottica di Marx la genesi del denaro sia chiaramente un processo endogeno ai rapporti economici e non un atto politico, il monopolio inerente alla funzione di equivalente generale presuppone implicitamente il potere dello Stato come suo promotore e garante[23]. La teoria monetaria del Capitale non è dunque una teoria puramente «metallista» della moneta-merce, né una teoria (pre-keynesiana o simil-keynesiana) della moneta fiduciaria, poiché le incorpora e le supera entrambe.
Nel Libro II del Capitale, Marx chiarisce che «noi supponiamo il denaro come moneta metallica, escludendo la moneta simbolica, puri e semplici segni di valore che costituiscono solo la specialità di certi Stati, e la moneta creditizia, che non è ancora sviluppata. In primo luogo, questo è il corso della storia: la moneta di credito ha una parte nulla o insignificante nella prima epoca della produzione capitalistica»[24]. Benché l’argomentazione sia discutibile sul piano storico, la moneta metallica offre per Marx il vantaggio di riassumere il concetto di denaro in generale, ossia di concentrare tutte le funzioni che gli attribuisce. La moneta metallica può fungere sia da mezzo di circolazione (di pagamento), sia da misura di valore e da riserva di valore, giacché anche i metalli preziosi sono prodotti sulla base del meccanismo del tempo di lavoro socialmente necessario. Tuttavia, la nozione marxiana di moneta-merce si fonda su premesse non-metalliste, poiché non può essere ridotta al metallo di cui è materialmente composta. L’oro o l’argento non sono in sé moneta metallica: per diventare tali, è necessario che la zecca nazionale li trasformi in monete. E nell’adottare la moneta metallica, lo Stato ne stabilisce il corso legale e le condizioni di convertibilità in cartamoneta. Non a caso, in un passaggio dell’Urtext, Marx scrive che «la monarchia assoluta, essa stessa già prodotto dello sviluppo della ricchezza borghese ad un grado ormai non più compatibile con i vecchi rapporti feudali, in corrispondenza del potere generale ed uniforme, che doveva essere capace di esercitare su tutti i punti della periferia, come leva materiale dell’equivalente generale, aveva bisogno della ricchezza nella sua forma già pronta, del tutto indipendente da particolari rapporti locali, naturali, individuali. Aveva bisogno della ricchezza nella sua forma di denaro»[25]. La monarchia assoluta «si comporta perciò in modo attivo nel processo di trasformazione del denaro in generale mezzo di pagamento»[26]. Se incluso nel Capitale, questo brano avrebbe evitato non pochi fraintendimenti.
Dallo Stato in generale al sistema degli Stati
Nella parte precedente, abbiamo visto le principali declinazioni sotto cui lo Stato viene presentato nell’esposizione del Capitale. Ne abbiamo tralasciate alcune, senza dubbio rilevanti, ma che non caratterizzano (o caratterizzano in minor misura) lo Stato in quanto Stato capitalista: lo Stato come esattore delle tasse, lo Stato come proprietario terriero, lo Stato come debitore[27], e qualche altra ancora. Ricordiamo inoltre che ciò che abbiamo riassunto qui non è una versione particolare della teoria marxista dello Stato, ma sono solo i suoi lineamenti minimi. Qualsiasi variante della teoria marxista dello Stato, nella misura in cui condivide in toto o in parte questi lineamenti, presenta una serie di problemi allorché deve fare i conti con la dimensione espansiva e immediatamente internazionale del MPC. Li illustreremo rapidamente, prima di vedere come possano essere affrontati.
Problemi di una teoria marxista dello Stato
Come accennato all’inizio del presente articolo, lo Stato capitalista non esiste se non come una pluralità di Stati. Nel resoconto fornito fin qui, però, l’identità tra lo spazio del mercato e il territorio dello Stato, entrambi concepiti come univoci e sovrapposti, era supposta in via implicita. Ebbene, non soltanto la storia reale, ma anche la stessa teorizzazione di Marx contraddice questa identità, affermando invece la tendenza alla formazione del mercato mondiale, il cui grado di integrazione va ben oltre la semplice giustapposizione dei cosiddetti mercati nazionali: «la tendenza a creare il mercato mondiale è data immediatamente nel concetto del capitale stesso»[28]. Dunque, la sfasatura tra il mercato, per definizione mosso da un impulso universalizzante, e lo Stato, destinato (anche qualora sia politicamente espansionista) a rimanere tassello di un mosaico più vasto, è chiaramente presente nel Capitale[29], ma non viene approfondita da Marx in quanto tale.
Nei nostri Lineamenti abbiamo evidenziato un duplice nesso tra l’uno e il molteplice: da un lato, tra le molte merci e il denaro (nesso socialmente convalidato dallo Stato); dall’altro, tra i molti capitali e lo Stato stesso. Il primo nesso può essere visto come un aspetto o una conseguenza del secondo. Ad ogni modo, in entrambi i casi questo nesso permette di cogliere una specifica gerarchia tra gli attori economici. Lo Stato, in questo quadro, non è in sé l’attore principale o predominante, ma è il più potente essendo sempre nelle condizioni di poter orientare gli attori privati, anche ritraendosi o praticando il lassez-faire. Tuttavia, una simile concezione della strutturazione interna e delle gerarchie del campo economico non sfugge a ciò che Claudia Von Braunmühl ha chiamato «il punto di vista tradizionale che considera lo Stato determinato in prima istanza da processi interni, ai quali, per così dire, le determinanti esterne vengono annesse a posteriori»[30]. In effetti, Von Braunmühl e i suoi interlocutori nel Weltmarkt-Debatte tedesco degli anni 1970 offrirono un importante contributo in vista di una visone più esaustiva, ma ripiegarono a tratti su una semplice inversione del punto di vista da loro criticato, ipostatizzando il mercato mondiale come un fatto statico (e non come una tendenza per definizione sempre in divenire, à-la Marx) o come una sorta di assioma. Allorché Von Braunmühl qualifica «lo Stato-nazione borghese» come una «particolarizzazione» del mercato mondiale, a sua volta definito come sfera della circolazione di capitale[31], giunge implicitamente a dedurre lo Stato esclusivamente dai rapporti inter-capitalistici (cioè intercorrenti tra i molti capitali), e si vede dunque costretta a reintrodurre il rapporto tra capitale e lavoro a posteriori. Ora, il rapporto sociale capitalistico reale consiste simultaneamente nei rapporti inter-capitalistici e nel rapporto tra capitale e lavoro. Ma da dove partire per concettualizzare lo Stato? Seguendo le indicazioni metodologiche di Marx sul passaggio dall’astratto al concreto, risulta evidente che lo Stato debba essere derivato in primo luogo dal rapporto tra capitale e lavoro, mentre i molti Stati e il mercato mondiale possono essere dedotti soltanto in una fase successiva[32]. Ciò non significa affatto che questi, e il rapporto inter-capitalistico di cui sono espressione, siano meno rilevanti socialmente. Fintanto che il MPC si riproduce normalmente, anche malgrado scosse importanti, recessioni ecc., il livelli dei rapporti reciproci tra i molti capitali prevale inevitabilmente. Nondimeno, il nocciolo dell’analisi di Marx sta nello svelamento della sua conditio sine qua non (l’estrazione del plusvalore) e nella delucidazione del suo carattere storicamente transitorio e strategicamente decisivo. A questo livello di astrazione, non dovendosi qui relazionare con fattori esterni, lo Stato può assumere i tratti dello Stato in generale, come «sintesi della società borghese nella forma dello Stato»[33]. Ma non appena il concetto di capitale viene precisato introducendo passo dopo passo tutte le sue differenziazioni interne, lo Stato in generale diviene lo Stato al singolare, inserito in una rete di rapporti che lo trascendono in larga misura. Seguendo l’intuizione di Braunmühl, identifichiamo questa rete con il mercato mondiale stesso. Cercheremo in questo modo di dispiegarne il concetto in tutta la sua ampiezza e profondità, inquadrando lo Stato come parte di un sistema di Stati (o sistema interstatale) e facendolo emergere come momento di differenziazione interna (o «auto-rispecchiamento», à la Hegel) del mercato mondiale stesso.
I molti Stati e il mercato mondiale
La nozione di mercato mondiale non deve essere intesa come la sommatoria di mercati più ristretti, nazionali o macro-regionali. Allo stesso tempo, la sua esistenza come totalità superiore alla somma delle sue parti non produce un’istanza suprema che restituisca a queste parti la loro interrelazione nelle vesti di una forza costrittiva «esterna». In altri termini, il mercato mondiale è una totalità immanente, non trascendente. Questo è quanto viene riconosciuto dagli studiosi realisti delle relazioni internazionali, quando sostengono che il sistema interstatale è anarchico, vale a dire che manca di una gerarchia prestabilita tra le sue componenti (gli Stati). Sfortunatamente, però, la distinzione metodologica tra lo Stato e la sfera economica generalmente impedisce loro di spingere questa potente intuizione alle sue conseguenze ultime. Se gli Stati, e il sistema interstatale, vengono inseriti nella cornice più ampia del mercato mondiale, l’anarchia diventa un attributo dell’intero, ossia del mercato mondiale stesso. Come corollario, non può essere data per scontata alcuna gerarchia prestabilita tra gli attori di diversa natura – pubblici e privati – che vi prendono parte. Come vedremo, ciò non equivale a negare che il mercato mondiale sia altamente strutturato e internamente differenziato, e tantomeno a contestare la maggiore efficienza del livello (inter-)statale su altri livelli e istanze; significa piuttosto che questa primazia degli Stati è un risultato che deve essere costantemente riprodotto, e che la sua riproduzione, appunto, non è mai garantita. Dietro il funzionamento relativamente sostenibile dell’anarchia concorrenziale su scala mondiale, si deve sempre cogliere sullo sfondo l’incessante produzione di plusvalore, la cui capacità di irrigare ogni genere di ramificazioni – comprese le più distanti da ciò che Marx chiama «il segreto laboratorio della produzione»[34] – permane solo nella misura in cui funzioni correttamente. La primazia degli Stati tra gli attori del mercato mondiale non è dunque una legge divina, ma il prodotto, incessantemente rinnovato, di un processo sociale.
Perché gli Stati competono? Ciascuno di essi incarna un certo sottoinsieme economico che consiste in uno spettro eterogeneo di interessi privati che si muovono al confine tra interno ed estero. Capitali domestici fluiscono verso l’esterno, capitali esteri verso l’interno. Gli Stati sono le dighe che regolano questi movimenti. Sul versante strettamente «interno», essi predispongono, come minimo, una cornice normativa alla collisione degli interessi privati. Tale inquadramento, applicato ai rapporti di concorrenza, favorisce necessariamente alcuni e danneggia altri, mirando però a salvaguardare la riproduzione dell’insieme. Il grado di penetrazione del capitale estero può modificare in larga misura la forma di un tale inquadramento, il quale, nel contesto del mercato mondiale, è sempre un compromesso tra interessi domestici ed esteri. Al livello interstatale, ogni Stato è chiamato a comprovare, giorno dopo giorno, la sua capacità di fare valere gli interessi privati proiettati all’estero dando loro una forma concentrata e organizzata – il che significa anche dimostrare, giorno dopo giorno, che tale espressione concentrata e organizzata è preferibile alla loro espressione immediata, puramente privata, da parte di ciascuno dei singoli capitali presi individualmente. Questi ultimi, infatti, sperimentano la propria limitatezza ogniqualvolta collidono con un interesse economico di segno opposto e di pari peso, ma sostenuto dal «proprio» Stato di riferimento.
Entro il mercato mondiale i sottoinsiemi economici incarnati dagli Stati non sono «economie nazionali» nel senso tradizionale del termine (come quelle misurate dalla contabilità nazionale, dal PIL, dalla bilancia commerciale, ecc.), poiché ogni perimetro nazionale comprende una combinazione di forze economiche nazionali ed estere (vedi più oltre, Libero scambio e protezionismo). Questi sottoinsiemi dunque non costituiscono il mercato mondiale giustapponendosi l’uno all’altro, ma compenetrandosi in maniera diseguale. Alcuni di essi eccedono ampiamente le loro presunte «economie nazionali», mentre altri hanno dimensioni ben più ridotte. Le analisi classiche dello sviluppo ineguale e del «sottosviluppo» mettono variamente a tema questo fatto, senza necessariamente esplicitarlo (vedi oltre, Disparità di sviluppo e divisione internazionale del lavoro). Nella maniera più contraddittoria, i sottoinsiemi economici dominanti sono spinti a rimettere in discussione la geografia politico-amministrativa disegnata dai confini statali, senza mai riuscire a superarla realmente. Questo movimento contraddittorio riassume il mercato mondiale inteso come tendenza, ovvero come una legge che si impone attraverso la sua stessa incompiutezza.
Nel sistema interstatale, non vi è alcuna gerarchia o quadro normativo indipendente dalle pratiche degli attori stessi, ovvero dall’insieme dei rapporti (multilaterali, bilaterali, unilaterali) di collaborazione e competizione, di attrazione e repulsione, che gli Stati alimentanto fra loro. Ciò non significa che una gerarchia e un quadro normativo siano del tutto assenti, quanto piuttosto che essi emergono come configurazioni provvisorie, come cristallizzazioni temporanee dei rapporti di forza tra sottoinsiemi economici, espressi in forma concentrata per mezzo dei rapporti tra Stati. I movimenti di capitali generano frizioni, scosse, spinte espansive che non sono sempre compatibili le une con le altre, il che conduce inevitabilmente a ripercussioni sul campo dei rapporti interstatali. Che l’insieme di questi rapporti sia in grado a) di mantenersi nella forma di un sistema, cioè di preservare il predominio della forma-Stato sull’intero globo e b) di fornire un ordine relativo, è ancora una volta un risultato, e mai un esito scontato. Ciò richiede in particolare l’espletamento di una specifica funzione ordinativa, che può essere assunta soltanto da una parte del sistema, segnatamente da uno Stato. Ma quale? Solamente la «potenza dominante sul mercato mondiale»[35], ossia lo Stato associato al sottoinsieme economico dominante su scala globale (la Gran Bretagna ai tempi di Marx, gli Stati Uniti dal 1945 a oggi), attraverso la sua forza economica e politico-militare, può imporre un quadro normativo (provvisorio) sul sistema interstatale e espletare questa funzione ordinativa per un dato periodo di tempo. Le fasi di competizione «multipolare» per il ruolo di potenza dominante sul mercato mondiale vengono usualmente inaugurate da profonde crisi economiche, che manifestano l’insufficienza di plusvalore rispetto al capitale sovra-accumulato, e si concludono con il ristabilimento delle condizioni per la rivitalizzazione della produzione di plusvalore – eventualmente attraverso la guerra.
Anarchia e organizzazione
Come anticipato, l’attività di organizzazione del mercato mondiale viene esercitata su un’entità altamente incline al disordine, e gli Stati – compresa la potenza dominante sul mercato mondiale – vi partecipano come attori parziali, privi di controllo integrale sulla totalità. Gli Stati si rapportano alla totalità solo indirettamente, mediatamente, fintanto che riescono a dare una forma concentrata e organizzata agli interessi dei sottoinsiemi economici che incarnano. Ma la coesione dell’intero non esclude il conflitto tra le sue parti, e gli stati sono chiamati a farsene carico. Ciò avviene in modalità prevalentemente pacifiche, ma l’uso della forza armata e soprattutto la sua minaccia sono sempre dietro l’angolo. In breve, la conflittualità è un aspetto ineluttabile dei rapporti interstatali. La cornice analitica marxiana può offrire una comprensione più adeguata del contenuto e delle cause di una porzione considerevole di questi conflitti.
I circuiti della concorrenza
Il mercato mondiale non è uno «spazio astratto»[36]. È uno spazio profondo, irregolare, altamente stratificato, che consiste di una combinazione di mercati transnazionali, nazionali e sub-nazionali (regionali). Questi tre livelli sono sempre esistiti, sebbene in forme diverse. Al primo livello, alcune grandi imprese di branche economiche specifiche concorrono in circuiti che trascendono, talvolta largamente, i confini degli Stati. Nel secondo, delle imprese grandi e piccole competono all’interno di un perimetro che coincide grossomodo con il territorio dello Stato. Nel terzo, aziende generalmente piccole si scontrano su spazi limitati, corrispondenti a frazioni del territorio statale. Per meglio illustrare come questi flussi si combinino tra loro, ci sia consentito di ricapitolare sommariamente la teoria marxiana della concorrenza esposta nel Capitale, Libro III, sezione 2, capitoli 9 e 10[37]. Contrariamente alle rappresentazioni abituali di una generica «guerra di tutti contro tutti», Marx precisa che la concorrenza si coagula in via preponderante attorno a piccoli segmenti di mercato. Questi segmenti, che Marx chiama «branche», sono molto più ristrettei di ciò che i commentatori di questioni economiche chiamano «settori» (per esempio: le tecnologie dell’informazione, l’automotive, la farmaceutica): la base di una branca può essere un singolo prodotto, se non una minuscola componente, e la produzione dello stesso prodotto, ma di qualità diverse, può dare origine ad altrettante branche. Un’azienda può essere posizionata su un gran numero di branche, e un «settore» riassumerne in sé un numero colossale. Il punto fondamentale è che solo quelle imprese che si dedicano alla produzione di un medesimo prodotto, di qualità comparabile e sullo stesso mercato, si possono qualificare come concorrenti diretti. Solo in virtù di questa forma di concorrenza molto concreta e stringente, in ogni branca della produzione sociale può emergere un prezzo medio regolatore e un saggio medio di profitto. Il successo o il fallimento di ciascun concorrente dipende dalla sua capacità di adeguarsi al prezzo regolatore generando un profitto uguale o maggiore al profitto medio della sua branca. A questo livello, la concorrenza generalizzata è una mera tendenza che, per essere del tutto realizzata, richiederebbe una condizione non data nella realtà quotidiana, ovvero la perfetta mobilità del capitale attraverso le innumerevoli branche della produzione sociale, in modo da poter migrare incessantemente verso le branche più redditizie e portare così alla formazione di un unico saggio di profitto generale per tutte le branche.
Il quadro della concorrenza diventa ancor più frastagliato quando introduciamo le determinanti geografiche (non esplicite nell’analisi di Marx) da cui siamo partiti in questa sezione, ovvero il carattere dell’area di mercato. I tre strati summenzionati (sub-nazionale, nazionale e transnazionale) non sono compartimenti stagni: in primo luogo, perché le imprese distribuite su questi tre livelli sono, quantomeno in una certa misura, ognuna un cliente per l’altra; in secondo luogo, perché la crescita di un determinato capitale può condurlo a espandere la sua area di mercato dal livello sub-nazionale a quello nazionale, e da questo al piano transnazionale. Un elemento importante dell’attività degli Stati consiste nella supervisione e nell’accompagnamento di questi processi, in particolare all’intersezione tra lo spazio nazionale e transnazionale, agendo in favore dell’apertura di nuove aree di smercio attraverso accordi di libero scambio, o al contrario innalzando barriere per proteggere le aree esistenti. Ciò ci conduce al punto seguente.
Libero scambio e protezionismo
Marx viene talvolta apprezzato dagli economisti liberali come un difensore del libero mercato contro il protezionismo, cosa che il suo Discorso sulla questione del libero scambio[38] a prima vista parrebbe confermare. Sebbene sia vero che Marx abbia approvato l’abolizione delle leggi sul grano del 1846, mai ebbe l’intento di celebrare il «libero corso» delle forze economiche, se non per accelerare la rivoluzione. Il liberalismo è in sé una politica statale fortemente «interventista»[39], che emerge a uno stadio maturo della traiettoria capitalistica. Il MPC nasce protezionista. Nel Capitale, Marx associa il protezionismo principalmente alla fase dell’accumulazione originaria, i cui momenti
vengono combinati sistematicamente in Inghilterra in sistema coloniale, sistema del debito pubblico, sistema tributario e protezionistico moderni. I metodi poggiano in parte sulla violenza più brutale, come p. es. il sistema coloniale. Ma tutti si servono del potere dello Stato, violenza concentrata e organizzata della società, per fomentare artificialmente il processo di trasformazione del modo di produzione feudale in modo di produzione capitalistico e per accorciarne i passaggi.[40]
E ancora:
Il sistema protezionistico è stato un espediente per fabbricare fabbricanti, per espropriare lavoratori indipendenti, per capitalizzare i mezzi nazionali di produzione e di sussistenza, per abbreviare con la forza il trapasso dal modo di produzione antico a quello moderno. […] Sistema coloniale, debito pubblico, peso fiscale, protezionismo, guerre commerciali, ecc., tutti questi rampolli del periodo della manifattura in senso proprio crescono come giganti nel periodo d’infanzia della grande industria[41].
In definitiva, «il sistema protezionistico alle origini tendeva alla fabbricazione di capitalisti nella madre patria»[42]. Marx morì nel 1883, quindi non poté assistere all’ondata protezionista del tardo XIX secolo; inoltre, la sua interpretazione del fenomeno, essenzialmente limitata alle politiche tariffarie, non poteva includere le forme successive che apparvero nel XX secolo (misure non tariffarie, protezionismo fiscale, ecc.). Ciononostante, l’espressione marxiana sul protezionismo come un mezzo per «fabbricare fabbricanti» permette di capire che, contrariamente a quanto sostenuto da coloro che chiama «gli altri ottimisti liberoscambisti dell’età presente»[43], la transizione dal protezionismo al libero scambio non è una strada a senso unico. Il ripresentarsi periodico di politiche protezionistiche, sia in condizioni di arretratezza che di capitalismo maturo, può essere spiegato dalla necessità di incoraggiare una rimonta economica o di facilitare l’emergenza di industrie nascenti in condizioni concorrenziali altrimenti proibitive. In una delle invettive di Marx contro Henry Carey, possiamo inoltre identificare una peculiare dialettica del protezionismo. Carey accusa l’Inghilterra industriale di tentare di trasformare il resto del mondo in una schiera di paesi agricoli arretrati, e incolpa l’Inghilterra, e Mr. Urquhart in particolare, per la rovina della Turchia, ma «il più bello è che il Carey […] vuole impedire questo processo di separazione» tra agricoltura e industria domestica «proprio mediante quel sistema protezionistico che l’affretta»[44]. In breve, secondo Marx in condizioni di arretratezza il protezionismo viene generalmente adottato per tutelare i piccoli produttori dalla concorrenza internazionale, ma lo sviluppo industriale che esso stesso stimola li porterà comunque, nel lungo termine, all’inevitabile scomparsa.
Disparità di sviluppo e divisione internazionale del lavoro
In maniera strettamente connessa con il punto precedente, è importante comprendere perché, oltre un certo grado di maturazione, l’ingresso di nuovi attori in una data branca della produzione sociale, o la rimonta economica di un dato paese, siano così difficili da realizzare, soprattutto in condizioni internazionali di libero scambio. Nel Libro III del Capitale, nel capitolo dedicato alle controtendenze alla caduta del saggio di profitto, Marx sostiene che
i capitali investiti nel commercio estero possono offrire un saggio del profitto più elevato soprattutto perché in tal caso fanno concorrenza a merci che vengono prodotte da altri paesi a condizioni meno favorevoli; il paese più progredito vende allora i suoi prodotti ad un prezzo maggiore del loro valore, quantunque inferiore a quello dei paesi concorrenti. […] La stessa situazione si può presentare rispetto ad un paese con il quale si stabiliscono rapporti di importazione e di esportazione: esso fornisce in natura una quantità di lavoro oggettivato superiore a quello che riceve e tuttavia ottiene la merce più a buon mercato di quanto non potrebbe esso stesso produrre[45].
Ci ritroviamo qui di fronte alle trasformazioni che la legge del valore subisce nella sua applicazione internazionale, ossia quando gli scambi economici – analizzabili sia come scambi tra singoli soggetti, sia come scambi aggregati tra paesi – avvengono tra diversi livelli di produttività media e di sviluppo economico generale. Come precisato da Marx nel Libro I, in queste condizioni il lavoro più produttivo si presenta come lavoro di maggiore intensità. Ciò significa che i prodotti di due diversi processi lavorativi che differiscono toto coelo in produttività e intensività diventano comparabili come se fossero il prodotto dello stesso lavoro, effettuato a livelli di intensità diversi; cosicché un’unità di lavoro più intenso può essere scambiata con più unità di lavoro meno intenso. Supponiamo ora che i produttori di beni alimentari dei paesi avanzati, rafforzati da una produttività più vantaggiosa, penetrino nei mercati di sbocco (nazionali o transnazionali) dei produttori dei paesi arretrati: all’inizio, e finché il prezzo regolatore della branca non si modifica, vedremo i primi percepire un sovrapprofitto; in un secondo momento, data la loro incapacità a tenere il passo dei primi, vedremo i secondi venire gradualmente esclusi da questi mercati, determinando con ciò un nuovo prezzo regolatore della branca. Tuttavia, se i produttori dei paesi avanzati dovessero competere con quelli arretrati sull’intera produzione sociale, gli ultimi finirebbero semplicemente con lo scomparire, sopprimendo con ciò una fonte importante di sovraprofitto. È per questo che la divisione internazionale del lavoro assume generalmente i tratti della specializzazione, grazie alla quale i paesi più avanzati scambiano prodotti complessi e «ad alto valore aggiunto» con prodotti più elementari, «a basso valore aggiunto». All’epoca di Marx, ancora caratterizzata dal dominio coloniale, ciò prendeva la forma di «una nuova divisione internazionale del lavoro in corrispondenza alle sedi [leggi: dei paesi. NdT] principali del sistema delle macchine», la quale «trasforma una parte del globo terrestre in campo di produzione prevalentemente agricolo per l’altra parte quale campo di produzione prevalentemente industriale»[46]. Se oggi la polarizzazione del mondo tra paesi industriali e agricoli è molto meno marcata, ciò dipende dal fatto che la forma stessa della divisione internazionale del lavoro è divenuta un oggetto di contesa nel sistema interstatale, e che la forma promossa dai produttori più performanti nelle aree avanzate viene periodicamente contestata (decolonizzazione, non-allineamento, ecc.).
Immigrazione e «mercato del lavoro»
La nozione di «mercato del lavoro» viene fatta propria da Marx per mera comodità. Nella concezione marxiana del rapporto tra capitale e lavoro, ciò che viene venduto non è il lavoro in sé (che non può essere una merce), ma la forza-lavoro, che è inseparabile dal suo portatore. Ciò la distingue da ogni altra merce, ed esclude ipso facto l’esistenza di un «mercato del lavoro» equiparabile in tutto e per tutto a quello delle merci ordinarie: in primo luogo, poiché la forza-lavoro viene prodotta e riprodotta in condizioni non mercantili (se lo fosse, potrebbe soltanto trasferire il suo stesso valore al prodotto, ma non aggiungerne, così come avviene per i macchinari o le materie prime); in secondo luogo, perché il paniere dei mezzi di sussistenza che formano il valore della forza-lavoro non è predeterminato, ma viene incessantemente ridefinito dalla contrattazione, dal volume dei bisogni storicamente riconosciuti come necessari, ecc. Ci sia concesso di aggiungere un terzo punto, che deriva dalla separazione del lavoratore dei mezzi di produzione. Come abbiamo osservato nei nostri Lineamenti, lo Stato gioca un ruolo di primo piano nella creazione e nel mantenimento delle condizioni della compravendita della forza-lavoro. Eppure, affinché il «mercato del lavoro» funzioni correttamente dal punto di vista dell’imprenditoria, è necessario un surplus di manodopera disponibile per disciplinare il comportamento dei lavoratori. Marx indaga la formazione di questa manodopera eccedente nel Libro I del Capitale, sezione 7, capitolo 23, § 3, alla voce «Produzione progressiva di una sovrappopolazione relativa ossia di un esercito industriale di riserva»[47]. Secondo Marx, questa produzione è dovuta alla relativa diminuzione di forza-lavoro necessaria per unità di capitale, ovvero al generale incremento della produttività connessa all’applicazione della scienza al processo produttivo. Nelle parole di Marx, la formazione di una sovrappopolazione relativa è «una legge della popolazione peculiare del modo di produzione capitalistico»[48], indipendente dall’«aumento naturale della popolazione»[49], il che spiega gran parte dei «movimenti generali del salario […] regolati esclusivamente dall’espansione e dalla contrazione dell’esercito industriale di riserva»[50], a sua volta connesse «all’alternarsi dei periodi del ciclo industriale»[51]. Tuttavia, per una serie di ragioni che non verranno esaminate in questa sede (alcune delle quali legate all’applicazione internazionale della legge del valore summenzionata), la produzione di una sovrappopolazione relativa non si verifica necessariamente laddove lo sviluppo capitalistico è più avanzato, ma piuttosto laddove il suo dispiegarsi endogeno è maggiormente ostacolato; da qui il problema di rilocare i lavoratori effettivi o potenziali da un’area all’altra, preso in carico direttamente o indirettamente dagli Stati. Nondimeno, nella stessa misura in cui un incremento nella sovrappopolazione relativa in seno agli Stati capitalisticamente avanzati ha un effetto depressivo sui salari locali, la sua contrazione nei paesi capitalisticamente arretrati spinge qui verso l’alto i salari locali, indebolendo ulteriormente la formazione autoctona di capitali o la loro importazione. I sottoinsiemi economici più sviluppati hanno interesse a drenare forza-lavoro dai sottoinsiemi economici meno sviluppati, mentre questi ultimi hanno interesse a trattenerla in loco. Ogni Stato deve dunque farsi carico di questi interessi, in un duplice rapporto con agenti esterni (altri Stati, ma non solo) e con la pressione opposta proveniente dalla manodopera locale.
Conclusione: verso una teoria del sistema interstatale
Nel presente articolo abbiamo tentato di sintetizzare l’approccio marxiano allo Stato in generale e i problemi da esso posti nella prospettiva di una teoria marxista del sistema interstatale. Per l’essenziale, l’elaborazione di una tale teoria resta da fare. Per il momento, ci siamo limitati a proporre alcune ipotesi di lavoro, cercando nell’opera di Marx le soluzioni ai problemi incontrati. Si tratta solo di un inizio, e il ventaglio delle questioni teoriche da affrontare è enorme. Tra queste, ci preme menzionare la questione delle nazionalità, quella dell’imperialismo nelle sue forme contemporanee e, soprattutto, quella della disgregazione dell’ordine internazionale (nel passato e nel futuro). Su queste questioni è stato gettato a lungo un cono d’ombra, ma esse sono tornate prepotentemente alla ribalta, non di rado in forme inedite. Questo testo dovrebbe dunque essere letto anche come un appello all’elaborazione collettiva, poiché soltanto attraverso un dibattito a più voci su tali questioni la loro elaborazione teorica può essere rinnovata e messa al lavoro nella realtà. La «vecchia talpa» ha ancora da scavare.
Traduzione a cura di Kamo Modena
Note
[1] Vladimir I. Lenin, La guerra e la rivoluzione [discorso tenuto a Pietrogrado il 15 maggio 1917, pubblicato per la prima volta in Pravda, 23 aprile 1929], in Id. Opere, vol. XXIV, Editori Riuniti, Roma 1966, p. 413.
[2] John J. Mearsheimer, La grande illusione. Perché la democrazia liberale non può cambiare il mondo, Luiss University Press, Milano, 2019, p. 35-36.
[3] Robert Brenner, «What is, and what is not, imperialism», Historical Materialism, vol.14, n. 4, 2006, p. 84.
[4] Per una critica della separazione/opposizione tra storicismo e strutturalismo, cfr. Alfred Schmidt, Storia e struttura. Problemi di una teoria marxista della storia, De Donato, Bari 1972.
[5] György Lukács, Storia e coscienza di classe, SugarCo, Milano 1978, p. 210.
[6] Nella nostra disamina, ci limitiamo pressoché esclusivamente a questi materiali, segnatamente Il Capitale, i Grundrisse e Per la critica dell’economia politica.
[7] Tran Hai Hac, «État et capital dans l’exposé du Capital», in Aa. VV. (a cura di Antoine Artous), Nature et forme de l’État capitaliste: Analyses marxistes contemporaines, Syllepse, Parigi 2015, pp. 48-49.
[8] Henryk Grossmann, Marx, l’economia politica classica e il problema della dinamica, Laterza, Bari 1971, pp. 95-117.
[9] «Guerra sviluppata prima della pace; modo in cui attraverso la guerra e negli eserciti ecc. determinati rapporti economici come il lavoro salariato, le macchine ecc. si sono sviluppati prima che all’interno della società borghese. Anche il rapporto tra forza produttiva e rapporti di traffico diviene particolarmente evidente nell’esercito». (Karl Marx, Lineamenti fondamentali di critica dell’economia politica, 2 Voll., Einaudi, Torino 1983, vol. I, pp. 34-35).
[10] Karl Marx, Il Capitale. Critica dell’economia politica. Libro primo, Editori Riuniti, Roma, 1980, p. 777.
[11] Op. cit., pp. 827-836.
[12] Op. cit., pp. 800-801.
[13] Op. cit., p. 474.
[14] Op. cit., p. 800.
[15] Op. cit., p. 814, corsivo nell’originale.
[16] Nell’agricoltura capitalista, se proprietà e gestione della terra non coincidono nella medesima figura, la seconda tocca al coltivatore capitalista, che paga al proprietario terriero una parte del plusvalore sotto forma di rendita fondiaria.
[17] Op. cit., p. 800.
[18] Ibid.
[19] Op. cit., pp. 300-334.
[20] Op. cit., pp. 527-549.
[21] Id., Il Capitale. Critica dell’economia politica. Libro secondo, Editori Riuniti, Roma 1980, p. 100, corsivo nostro.
[22] Op. cit., p. 242.
[23] Tran Hai Hac, Relire le Capital: Marx, critique de l’économie et objet de la critique de l’économie politique, 2 Voll. Page deux, Losanna 2003, vol. I, p. 126-132.
[24] Karl Marx, Il Capitale. Critica dell’economia politica. Libro secondo, op. cit., p. 115.
[25] Karl Marx, Frammento del testo primitivo (1858) di «Per la critica dell’economia politica», in Id., Scritti inediti di economia politica, Editori Riuniti, Roma, 1963, p. 34.
[26] Ibid.
[27] Ciononostante Marx riconosce una grande importaza al debito pubblico, con riferimento particolare al tema dell’accumulazione originaria: «con i debiti pubblici è sorto un sistema di credito internazionale che spesso nasconde una delle fonti dell’accumulazione originaria di questo o di quel popolo». (Karl Marx, Il Capitale, Critica dell’economia politica. Libro primo, op. cit., p. 818). La questione del debito pubblico è ancor più rilevante al giorno d’oggi, come fonte di capitale fittizio.
[28] Karl Marx, Lineamenti fondamentali di critica dell’economia politica, op. cit., vol. I, p. 375.
[29] Si veda anche la teoria del commercio estero nel Libro III, sezione 3, capitolo 14, § 5 (Karl Marx, Il Capitale. Critica dell’economia politica. Libro terzo, 2 voll., Editori Riuniti, Roma 1980, vol. I, pp. 288-292). Questa teoria sarebbe completamente priva di senso se i diversi livelli di sviluppo economico, da cui Marx trae rilevanti implicazioni per il funzionamento della legge del valore su scala internazionale, non si coagulassero entro perimetri politico-amministrativi distinti.
[30] Claudia Von Braunmühl, «On the Analysis of the Bourgeois Nation State within the World Market Context. An Attempt to Develop a Methodological and Theoretical Approach», in Aa. VV. (a cura di John Holloway e Sol Picciotto), State and Capital. A Marxist Debate, Edward Arnold, Londra 1978, p. 161.
[31] «Di fronte a questa totalità, le partizioni e divisioni storiche, la convergenza dei capitali nello Stato-nazione borghese e gli apparati dello Stato nazionale con le loro attività debbono essere determinate analiticamente come il particolare. Il mercato mondiale deve essere posto in relazione alle sfere di circolazione nazionali [concependolo come] l’unica sfera effettiva di circolazione di capitali, [intendendo le seconde] come particolarizzazioni definite da questa stessa relazione». (Op. cit., p. 164).
[32] «Sembra giusto incominciare con ciò che è reale e concreto, con il presupposto reale, quindi ad esempio nell’economia con la popolazione, che è la base e il soggetto dell’intero atto sociale di produzione. Eppure, considerando le cose più da presso, ciò si rivela sbagliato. La popolazione è un’astrazione, se ad esempio non tengo conto delle classi di cui si compone. Queste classi sono a loro volta una parola priva di significato, se non conosco gli elementi sui quali esse si fondano. Ad esempio il lavoro salariato, il capitale ecc. […] Gli economisti del XVII secolo incominciano ad esempio sempre dall’insieme vivente, la popolazione, la nazione, lo Stato, più stati ecc.; finiscono però sempre con l’individuare attraverso l’analisi alcune relazioni astratte e generali determinanti, come la divisione del lavoro, il denaro, il valore ecc. Appena questi singoli momenti furono più o meno fissati e astratti, sorsero i sistemi economici che dal semplice, come il lavoro, la divisione del lavoro, il bisogno, il valore di scambio, risalirono fino allo Stato, allo scambio tra le nazioni e al mercato mondiale. Quest’ultimo è evidentemente il metodo scientificamente corretto». (Karl Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica, op. cit., vol. I, pp. 24-25, corsivo nostro).
[33] Op. cit., p. 34.
[34] Karl Marx, Il Capitale. Critica dell’economia politica. Libro primo, op. cit., p. 208.
[35] Karl Marx, Lineamenti fondamentali di critica dell’economia politica, op. cit., vol. II, p. 1030.
[36] Henri Lefebvre, La produzione dello spazio, Moizzi, Milano 1976, pp. 296-300.
[37] Karl Marx, Il Capitale. Critica dell’economia politica. Libro terzo, op. cit., pp. 195-243.
[38] Cfr. Karl Marx, «Discorso sulla questione del libero scambio», in Karl Marx, Friedrich Engels, Opere complete, Editori Riuniti, Roma 1973, vol. VI, pp. 3469-482.
[39] Antonio Gramsci, «Alcuni aspetti teorici e pratici dell’«economismo», in Id. Quaderni dal carcere. 4 voll, Einaudi, Torino, 1974, vol. III, pp. 1589-1590.
[40] Karl Marx, Il Capitale. Critica dell’economia politica. Libro primo, op. cit., pp. 813-814, corsivo nell’originale.
[41] Op. cit., pp. 819-820, corsivo nell’originale.
[42] Op. cit., p. 828, corsivo nell’originale.
[43] Op. cit., p. 618.
[44] Op. cit., p. 812, nota 236.
[45] Id., Il Capitale. Critica dell’economia politica. Libro terzo, op. cit., vol. I, p. 289.
[46] Marx, Il Capitale. Critica dell’economia politica. Libro primo, op. cit., p. 496.
[47] Op. cit., p. 688.
[48] Op. cit., pp. 691-692, corsivo nell’originale.
[49] Op. cit., p. 695.
[50] Op. cit., p. 697, corsivo nell’originale.
[51] Ibid.
***
Robert Ferro è traduttore e ricercatore indipendente. Vive e lavora in Francia, dove ha pubblicato, in collaborazione con Bruno Astarian, Le Ménage à trois de la lutte des classes (L’Asymétrie, 2019)
Raffaele Sciortino dottore di ricerca in studi politici e relazioni internazionali, è ricercatore indipendente. Si occupa di politica economica internazionale, con particolare riferimento alla globalizzazione, e di geopolitica nel suo intreccio con i movimenti sociali. Ha pubblicato, tra gli altri: I dieci anni che sconvolsero il mondo (Asterios, 2019) e Stati Uniti e Cina allo scontro globale (Asterios, 2022).
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.