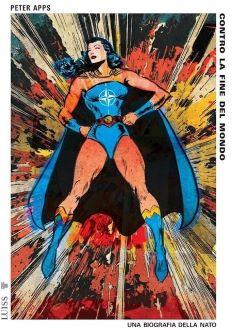Trump 2.0: una svolta epocale?
“Il capitalismo cadrà come il muro di Berlino”
José Francesco Bergoglio
Un confronto sulla percezione che sulle due sponde dell’Atlantico si ha della crisi in corso è importante, ma deve scontare uno choc cognitivo dovuto alla difficoltà di mettere a fuoco una svolta forse epocale. In effetti, è in corso a Washington un vero e proprio regime change, contrappasso della politica da decenni perseguita dalla Foreign Policy Community statunitense a tutte le latitudini.
di Raffaele Sciortino, da Sinistra in Rete
Se a prima vista sembra regnarvi il caos, la sfida è individuare una logica di fondo in questo caos. Detto altrimenti, Trump è sintomo e prodotto di profonde spinte materiali interne ed esterne oltreché l’attore di un tentativo di svolta nella postura strategica degli Stati Uniti nel mondo, dal corso incerto e con esiti difficilmente prevedibili.
Come fattori immediati, Trump 2.0 è il prodotto dei tre fallimenti principali e tangibili dell’amministrazione Biden: 1) non essere riuscita a infliggere una ”sconfitta strategica” alla Russia nel conflitto ucraino, avendo anzi favorito l’ulteriore riavvicinamento tra Mosca e Pechino e con gran parte del Sud Globale; 2) aver mancato l’obiettivo del decoupling selettivo con la Cina, ovvero il blocco della sua modernizzazione tecnologica e della risalita nelle catene globali del valore; 3) non aver arrestato il deterioramento del quadro sociale interno (nonostante gli impegni per una middle class foreign policy e gli abbozzi di reshoring, che in realtà si sono fermati sulla soglia del friendshoring con paesi come Messico e Vietnam). Anche solo alla luce di questi fattori, non era difficile ipotizzare che non Trump era la parentesi, ma Biden (le cui misure, non a caso, si sono collocate sul solco protezionistico di Trump 1.0, sanzioni comprese). Ma c’è di più. I fallimenti dell’amministrazione Democratica si configurano non come errori contingenti, bensì come la coda di un lungo ciclo della politica Usa e mondiale, quello della globalizzazione ascendente, già duramente scosso dalla crisi del 2008.
Un ciclo che oggi è alla fine perché ha reso gli Stati Uniti più dipendenti dal mondo che pure dominano, ma con costi economici sempre più gravi (deindustrializzazione relativa e deficit commerciale inarrestabile), con una polarizzazione e disgregazione sociale crescente, e con il rischio non più solo ipotetico che la Cina sfugga con qualche possibilità di successo al meccanismo ancora imperante del prelievo imperialista del dollaro (https://www.haymarketbooks.org/books/2577-the-us-china-rift-and-its-impact-on-globalisation). Sono queste le cause profonde della sempre più evidente ”crisi ordinativa” del sistema internazionale (della Pax Americana), rovesciamento dialettico del dominio dell’unico imperialismo in senso proprio rimasto sulla scena in quanto capace di combinare investimenti esteri all’estero, signoraggio monetario mondiale, controllo globale dei mari e dello spazio attraverso la potenza militare full-spectre, un apparato statale proiettato ampiamente all’estero.
La reazione a questa situazione si colloca negli Stati Uniti all’incrocio tra spinte provenienti dal profondo della società e spinte provenienti da frazioni importanti del capitalismo yankee. Si tratta delle frazioni fin qui meno favorite dalla proiezione globale (settori industriali di “vecchia” tecnologia) o che necessitano di un rafforzato rapporto con lo Stato (parte della Silicon Valley, Musk, ecc.) e in dissidio con alcuni grandi operatori finanziari. Sarebbe però frutto di illusione ottica considerare solo questo lato. La spinta dal basso – ben al di là del movimento Maga- è un fattore determinante della svolta in atto: una spinta sicuramente interclassista (in particolare, classi medie impoverite), ma che esprime anche istanze sociali di settori importanti di proletariato (non solo “bianco”) sempre più insofferenti verso le ricadute negative della globalizzazione (https://projectpppr.org/populisms/blog-post-title-one-jzade). Questo assemblaggio trumpista non è ancora un blocco sociale omogeneo, e potrebbe non diventarlo mai; ma al momento incanala anche aspettative proletarie di nazionalismo economico difensivo – piaccia o non piaccia – che coprono il vuoto lasciato dal vecchio riformismo newdealistico.
Trump è la risposta a tutto ciò – in una situazione che per certi versi ricorda la prima presidenza Nixon – con una strategia di ribaltamento del Volcker shock dei primi anni Ottanta (effettivo innesco della cosiddetta globalizzazione finanziaria trainata dal dollaro e dal doppio deficit statunitense pagato con l’emissione di montagne di Treasuries). Il nucleo del team trumpiano – più coeso di otto anni fa – ha a questo punto ben chiari: il rischio di declino degli Stati Uniti, la necessità di una prospettiva di medio-lungo periodo che mette in conto anche sacrifici e ritorni non immediati, e la posta in palio esistenziale per il mantenimento della supremazia degli Stati Uniti nel mondo. In più, in alcuni esponenti di punta del movimento Maga si intravvede la percezione di una ”crisi di civiltà” (ovvero dell’Occidente) ad ampio spettro, ben oltre una lettura meramente economica o geopolitica della crisi americana.
Al momento, tra gli alti e bassi di annunci e misure, è evidente una forzatura dall’alto corrispondente alla radicalità della svolta prospettata. La strategia che si sta delineando (almeno provvisoriamente e con la cautela del caso) è quella di “un passo indietro e due avanti”. Un passo indietro sul piano diplomatico-militare (https://www.newstatesman.com/ns-interview/2024/07/elbridge-colby-i-am-signalling-to-china-that-my-policy-is-status-quo) atto a evitare la precipitazione di uno scontro militare diretto con Russia e Cina (di qui la ricerca di una exit strategy dall’Ucraina, meglio se con un quasi rapprochement con Mosca, e il tentativo di raffreddare le tensioni con Teheran) – compensato da ”diversivi sensati” (Panama, Groenlandia, ecc.). Per Washington si tratta di tirare il fiato prendendo atto della incapacità al momento di fare guerra ai due nemici, come ampiamente dimostrato sul terreno di scontro ucraino (di qui l’appoggio a Trump anche di settori importanti del Pentagono). Due passi avanti sul piano della diplomazia economica coercitiva attraverso negoziazioni a somma zero supportate dalle misure tariffarie agitate come un grosso bastone, dalla svalutazione del dollaro e dalla ristrutturazione del debito estero imposto agli alleati in cambio della “protezione” militare – come nel piano del consigliere economico di Trump Stephen Miran (https://www.hudsonbaycapital.com/documents/FG/hudsonbay/research/638199_A_Users_Guide_to_Restructuring_the_Global_Trading_System.pdf). Tutto ciò finalizzato al rilancio della produzione industriale interna nei settori strategici in vista di future major wars, e presentato altresì come difesa ”produttivista” (non welfarista) del lavoro. In prospettiva si intravvede l’obiettivo strategico di un completo decoupling dalla Cina, da compensare con alleati e amici sul piano finanziario (Treasuries consolidati a cento anni, uso della stablecoin), energetico (acquisto di gas liquefatto ad alto prezzo) e militare (acquisto di armi statunitensi da incrementare). Il decoupling dalla Cina è visto dall’entourage di Trump come l’unico strumento efficace per bloccarne o farne deragliare la crescita economica e la stabilità socio-politica. Le tariffe esorbitanti varate ad aprile e in parte sospese sono dunque il primo passo di un percorso negoziale differenziato verso Pechino da un lato, la Ue e i paesi amici dell’Asia orientale dall’altro. Ma anche per questi ultimi lo smantellamento di parte della loro industria è condizione necessaria (anche se non sufficiente) della ricostruzione dell’apparato industriale statunitense: uno smantellamento pur parzialmente compensato da un friendshoring selettivo per alcune filiere, che diventerebbero comunque più dipendenti dal capofila statunitense e con condizioni “cinesi” per i lavoratori coinvolti. In generale si sta dunque facendo strada una ridefinizione della Grand Strategy statunitense per un ordine internazionale post-globalizzazione (https://americanaffairsjournal.org/2024/11/america-china-and-the-death-of-the-international-monetary-non-system/), che lascerà sul campo morti e feriti.
Sarebbe ingenuo pensare a una facile realizzabilità di questi obiettivi, intermedi e finali, grazie alla leva del dollaro – tuttora insostituibile sui mercati internazionali – e all’ampiezza del mercato interno statunitense. Ma anche escludere a priori la fattibilità di tale strategia appellandosi a un declino degli Stati Uniti naturalisticamente inteso (e già disatteso negli anni Settanta). Certo, gli ostacoli che Trump deve affrontare sono notevoli. Sul fronte interno: gli apparati statali e la Foreign Policy Community ostili (ancora in grado di mettergli i bastoni tra le ruote, per esempio in Ucraina); il compact Federal Reserve-Wall Street (che già si è fatto sentire condizionando l’altalena dei rendimenti dei Treasuries); le ricadute negative anche per la base sociale trompista di una possibile recessione, che riderebbe fiato ai settori sociali che più hanno beneficiato della globalizzazione, i professionals urbani e il ceto medio dei servizi digitali e finanziari, del mondo dei media e della formazione universitaria. Sul fronte internazionale: una Cina niente affatto arrendevole che già da tempo sta ristrutturando il proprio modello di sviluppo via dalla dipendenza dall’export; il riavvicinamento Mosca-Pechino, oramai difficile da rompere; il multiallineamento dei paesi Brics; l’incertezza sul riposizionamento della Germania in un Europa che la Nato oramai ha il compito di controllare più che proteggere. In più, la situazione in Medio Oriente potrebbe sfuggire di mano a fronte delle velleità israeliane, né il negoziato per la fine del conflitto ucraino si prospetta facile. In una parola, il risentimento anti-americano non farà che crescere, anche nei paesi amici rispetto alla inaffidabilità della potenza statunitense.
Ma a monte di tutto ciò, il nodo di fondo è la difficoltà obiettiva di innestare una logica neo-mercantilistica (incentrata sull’esportazione di merci) all’interno di una struttura economico-sociale imperialista incentrata sugli investimenti diretti all’estero e sul dollaro quasi moneta mondiale che permette il controllo sui flussi internazionali di capitale pur a costo di un crescente deficit commerciale. Questa struttura – emersa all’indomani della fine del sistema monetario internazionale di Bretton Woods nel 1971 – ha avuto un incredibile successo per Washington nel disintegrare le barriere statuali e finanziarie degli altri stati nazionali (in particolare quelle degli alleati, meno verso la Cina la Russia). Ma rischia oggi di disintegrare la stessa struttura industriale e sociale statunitense che si ritrova come concorrente principale… la propria moneta (la propria finanza)!
Il boomerang dell’imperialismo ritorna così verso il suo centro a una scala inedita per la parabola storica dell’imperialismo capitalistico. Il che spiega il sorprendente ritorno di una inedita “questione nazionale” in Occidente sotto forma di populismi e sovranismi che si fanno strada tra settori popolari in cerca di una difesa che il vecchio movimento operaio sindacale non è più in grado di dare. Di qui la compresenza all’interno dei settori proletari di sciovinismo (soprattutto anticinese) e rivendicazioni “neoriformiste” (in particolare anti-finanza), ambivalenza che il futuro dovrà sciogliere.
Difficile prevedere come la situazione evolverà. Di massima, si può pensare a due scenari opposti. Nel primo, il tentativo trumpiano – per il concorrere degli ostacoli visti – finisce nel caos con conseguenze a oggi non determinabili, ma sicuramente di grande momento per la stabilità già precaria dell’ordine internazionale. Nel secondo scenario, il successo della nuova strategia statunitense porterebbe alla formazione di due blocchi contrapposti: il primo a guida statunitense con un’Europa piegata e ridotta a una sorta di cortile di casa in stile già latino-americano; il secondo intorno a una Cina più integrata all’economia asiatico-orientale e alleata di Mosca. Anche in questo caso le incognite sono importanti per la tenuta della dollarizzazione pur in tono minore: cosa faranno Germania, Giappone, Corea del Sud, India, Turchia? In entrambi gli scenari, per vie differenti, si tratterebbe della fine della globalizzazione per come l’abbiamo conosciuta, di un ritorno al controllo dei capitali e delle valute (da parte dei soggetti statali forti), della riconfigurazione multidomestica delle imprese multinazionali. Non si tratterebbe dell’inizio di un ordine internazionale multipolare relativamente stabile bensì altamente conflittuale in vista della preparazione, più o meno accelerata, della guerra degli Stati Uniti contro la Cina, con un giro di vite su alleati e amici di Washington – che peraltro già vediamo ben avviato.
In tutto ciò l’elemento più interessante è il ritorno di una crisi sociale profonda nel cuore dell’imperialismo occidentale, ritorno che prelude alla possibile riattivizzazione di un proletariato passivo, disperso e frantumato. È dunque la difficoltà crescente – economica e geopolitica, comprese possibili sconfitte militari – dell’anello forte del sistema imperialistico ad apparire come condizione necessaria perché si riaprano i giochi anche sul piano dei rapporti di classe con una possibile ripresa dei conflitti di classe su scala mondiale. Con una crisi sistemica della riproduzione sociale all’orizzonte, riuscirà nuovamente l’imperialismo incentrato sugli Stati Uniti a “unire il separato”?
Anche se c’è poco che i comunisti possano fare politicamente e organizzativamente all’immediato, c’è già molto materiale su cui esercitare uno sforzo teorico e analitico che rimetta al centro i nodi strutturali del modo di produzione capitalistico, dopo decenni di autoinflitta limitazione alla dimensione culturale della critica marxista. Un po’ meno di Gramsci, insomma, e un po’ più di Lenin e Bordiga. La “fine della storia” è finita.
Questo testo è la versione italiana dell’articolo scritto per il collettivo statunitense Heatwave (https://heatwavemag.info/) di prossima pubblicazione.
[Questo contributo ha beneficiato delle discussioni all’interno del seminario torinese sull’imperialismo e con Steve Wright]
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.