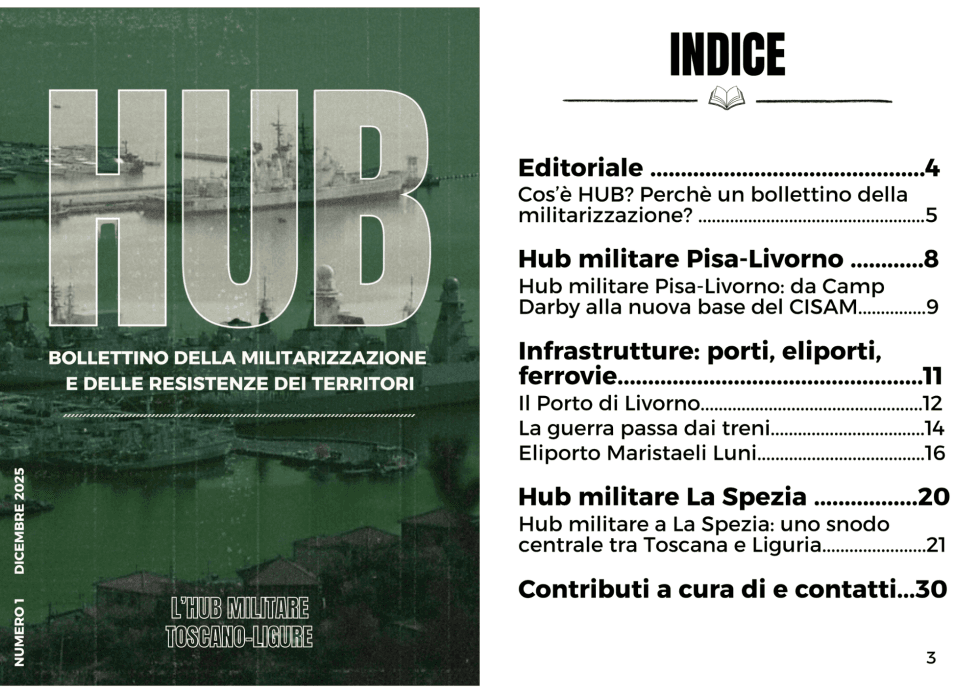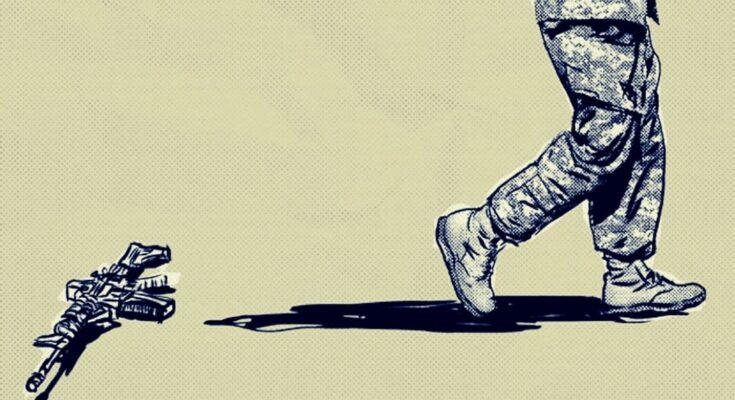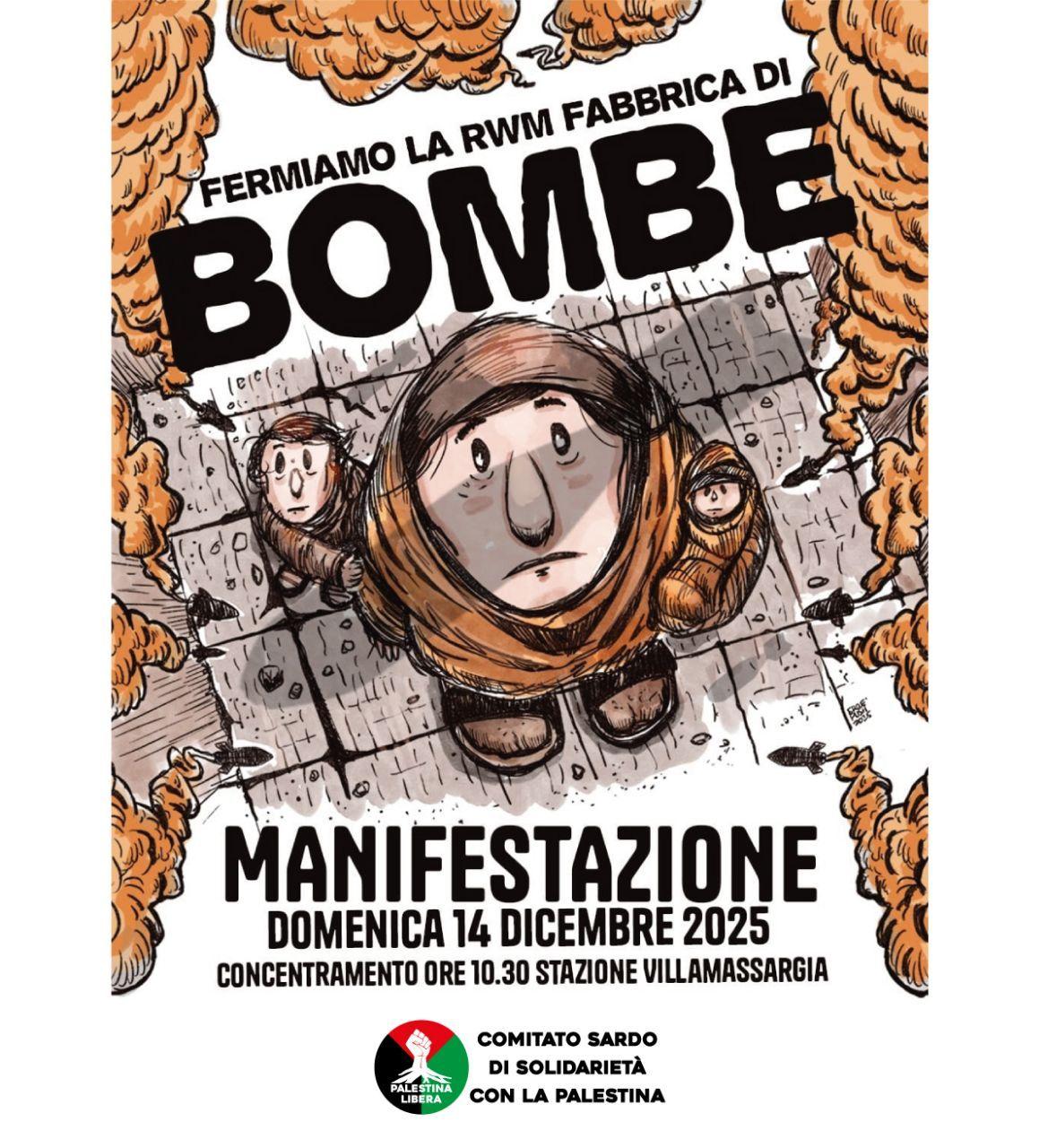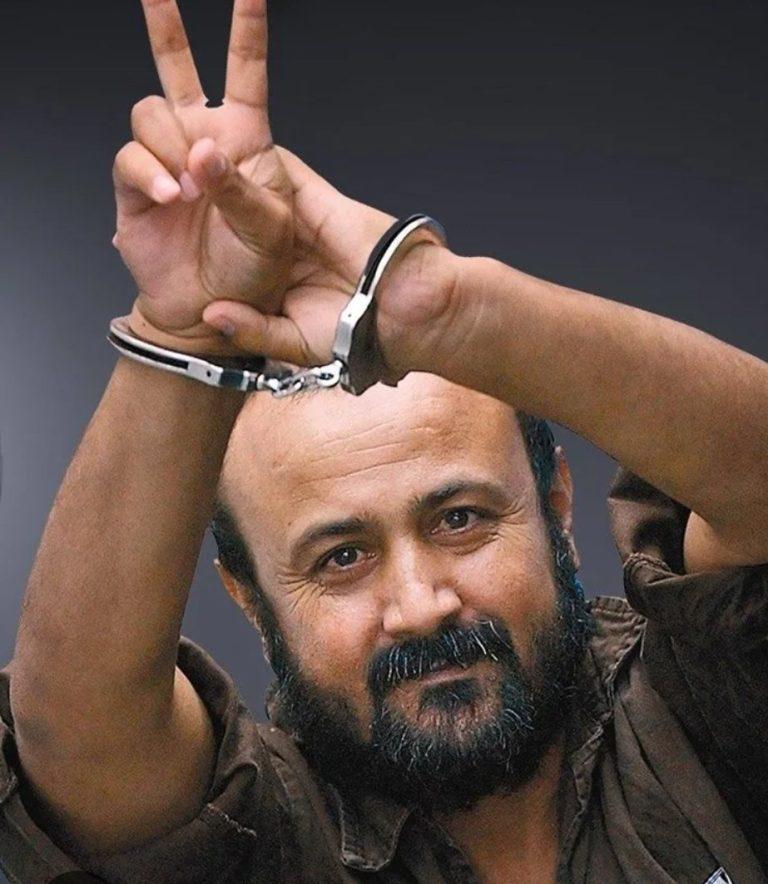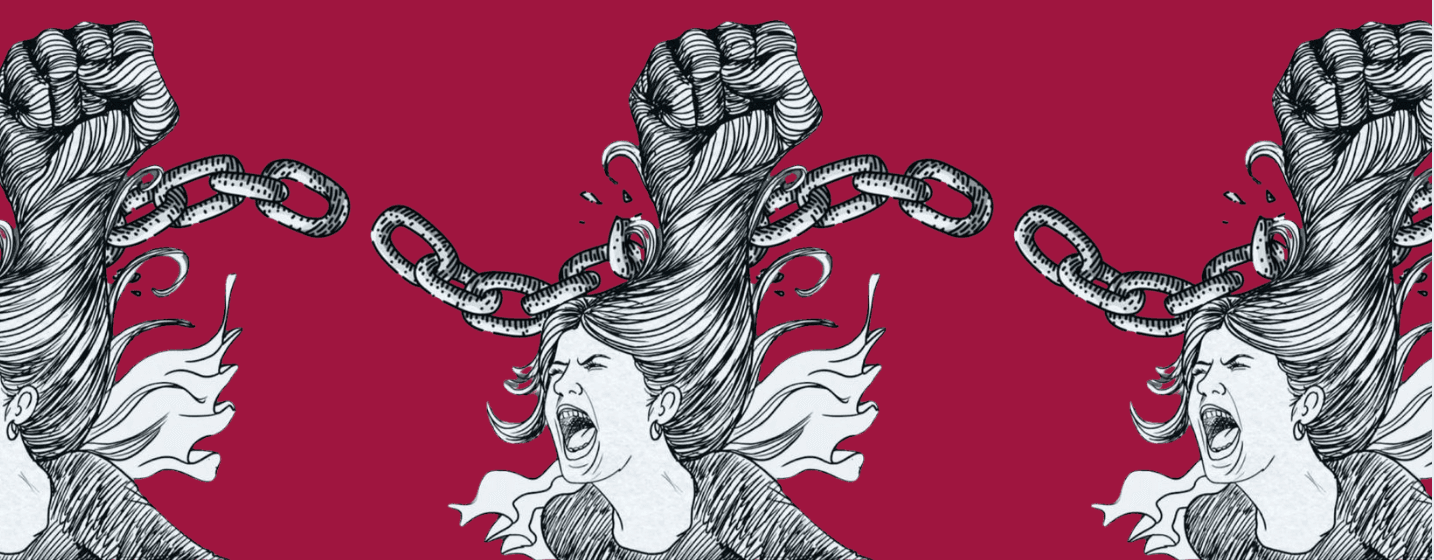Creatività e rivoluzione. Pittori, scultori, musicisti del Rojava

In una piccola stanza, mostrano una quantità di piccoli oggetti creati dai bambini delle scuole durante i corsi di artigianato messi in piedi dall’istituto. Tutto è relativo al folklore curdo, in un momento in cui l’identità del Kurdistan vive al tempo stesso la sua massima esposizione e forza politica e uno dei più duri attacchi della sua storia, e dopo decenni di censura ed oppressione culturale in Siria. Lo sforzo di queste opere creative di essere parte di un processo sociale e politico, prima ancora che di soddisfare le aspirazioni individuali dell’autore o del singolo fruitore, è dimostrato dal carattere fortemente allegorico delle sculture di Hasun, dove Daesh è rappresentato come una testa urlante di pessimo aspetto cui, soprattutto, manca il cervello. In generale, tutte le opere di Hasun sembrano organizzate come un alfabeto, in cui ad ogni elemento estetico presente nell’oggetto – un bassorilievo, una rappresentazione, un movimento della materia – corrisponde un significato ottenuto per associazione. Tiene in mano le sue opere ed elenca: “Questo è il popolo che insorge, questa è la resistenza, questa è la donna oppressa…”.
Colpisce la distanza tra le poetiche artistiche maggiormente associate ai movimenti rivoluzionari in Europa, che rifiuterebbero (almeno in teoria) questa spiritualizzazione “alfabetica” dell’opera, e tale disciplinata organizzazione del senso in categorie semplici e trasmissibili, tentativo di sottomettere l’apparenza estetica a una sorta di legge della ripetizione simbolica (a questo corrisponde quest’altro, ecc.). Questo genere di corrispondenza ha luogo soltanto quando si praticano percorsi già noti, o ad essi è possibile fare in qualche forma riferimento; eppure la critica di queste forme di espressione politica ha caratterizzato i movimenti europei nelle loro fasi più elitarie, che hanno regolarmente precedeuto la disfatta: negli anni della repubblica di Weimar – prima del trionfo nazista – o nelle ribellioni giovanili del 1968-1977, alla vigilia dell’instaurazione del dominio neoliberista in cui tutt’oggi viviamo. La mobilitazione popolare pretende di comprendere immediatamente e collettivamente il gesto creativo dell’individuo, e la pur legittima scelta dell’artista europeo, che più o meno segretamente la disprezza, deve pagare il prezzo della sua irrelazione ai movimenti reali, o la loro ostilità e sospetto.
D’altra parte, oggi – corcostanza forse liberatrice, ad Amuda come a Tokio o a Londra – le forme espressive preferite dalle masse non sono la scultura e la pittura, ma il video, la grafica, il cinema, la musica, il vestiario e, in modo più ambivalente, l’architettura, o il mai declinato interesse per il romanzo. Nel centro è presente una piccola biblioteca composta da appena tre grandi scaffali. Nella sezione filosofica troviamo Platone e Aristotele, Karl Yung, Eric Fromm e John S. Mill, ma anche Kim Il Sung, Engels, Lenin e Marx. Non mancano i sociologi del mondo arabo, naturalmente, anche se la bibliotecaria sostiene che l’unico curdo passabile in filosofia (sebbene normalmente considerato un profeta) fosse Zarathustra. C’è una sezione cinefila con libri su Charlie Chaplin, sul cinema giapponese ed europeo, sul cinema classico egiziano e monografie su Bunuel e Scorsese, Qatiba Al-Shahab, Stanley Kubrik e Orson Wells. “Lo studio del cinema è in forte sviluppo nella rivoluzione, ed è stata aperta una scuola di cinema a Derik, anche con insegnanti stranieri”. Troviamo libri di storia curda, araba, francese; critica letteraria e teatrale, romanzi (molti di Dan Brown) e tante poesie di Mahmud Darwish, Nizar Kabbani, Khalil Jibrar.
Quali sono i libri più richiesti, chiediamo? “Quelli per bambini al primo posto; poi quelli sulla cultura curda, quelli sul cinema e i romanzi”. Nella sala a fianco c’è la scuola di musica: qui si svolgono lezioni per bambini e preparativi per esibizioni musicali in occasioni pubbliche. Il maestro, Muslum Agri, dice che la stragrande maggioranza dell’attività musicale è improntata alla musica tradizionale e folklorica curda, ma che talvolta può accadere che anche la musica straniera sia presa in considerazione. In verità, non sembrano così vogliosi di ascoltare musica straniera; ma se dovessero scegliere, dicono nella scuola, sceglierebbero l’hip hop. “Questo posto, comunque, è aperto a tutti: curdi, arabi, ecc., e tutti gli stili musicali vengono accettati”. L’attività di insegnamento musicale ed espressivo è più importante qui che altrove. “I bambini del Rojava sono colpiti dalla guerra, per questo diamo loro lezioni e materiali: ne hanno bisogno per superare la paura e dare spazio ai propri sentimenti; ne hanno bisogno per non emigrare” dice Abdullah. Le sue parole non possono non farci ricordare un abitante del campo profughi di Aida a Betlemme, che aveva raccontato come i soldati israeliani della base che lo sorveglia non esitassero a colpire con lacrimogeni la scuola musicale, ogni volta che si accorgevano che i ragazzini stavano suonando.
“Noi non emigreremo mai – aggiunge Abdullah – resteremo qui fino alla morte”. Assieme ad Abu e Ibrahim, Abdullah dipinge i muri della città di Amuda: Ibrahim spiega che rendere la città più gradevole è per loro uno sforzo volto, ancora una volta, a impedire che aumenti l’emigrazione, fattore di indebolimento della rivoluzione, come accadde per tutte quelle precedenti. Seguono anche un progetto a Derik per la progettazione di una sala conferenze assieme degli olandesi; la società olandese sembra essere, assieme a quella ceca, una delle più attive nel supporto e nello sviluppo di progetti in Rojava. “Un dipinto – afferma un altro pittore, Musah Abdul – è come una lingua internazionale che parla a tutto il mondo e a tutte le nazioni, e a grandi, piccoli e anziani: con questo mezzo voglio dare un’idea realistica del Rojava al mondo intero, rappresentando tutte le componenti della società confederata con i colori della primavera”. Tutto questo lavoro “è per le donne curde e per la loro sofferenza”, afferma, e Abdullah gli fa eco: “Le donne curde sono state a lungo oppresse, ma adesso stanno combattendo e sono diventate un esempio per tutto il mondo. Noi rappresentiamo le Ypj nelle nostre opere affinché le donne possano avere la grazie di far parte della storia del Kurdistan”.
Narsin è donna e pittrice, e dipinge secondo uno stile reminescente, nelle sue stesse parole “l’espressionismo o l’arte astratta, a seconda delle opere”. Nonostante molti nel centro di Amuda siano i pittori e gli scultori, huner, il termine curdo traducibile come “arte” – spiega un compagno europeo che ha a lungo studiato la lingua curda – “ha mantenuto il senso antico che ‘le arti’ avevano in Europa: è molto vicino a chand, ‘cultura’, perché riferito a tutte le forme espressive umane, compreso ciò che normalmente è connesso con la vita sociale e l’economia”. Anche in questo, il continuo riferimento all’Europa che attraversa, per ragioni evidenti, il medio oriente e il Kurdistan in particolare, non cancella la distanza che separa l’evoluzione delle parole e dei concetti in un luogo o nell’altro del pianeta. Ciononostante, l’Europa non può che essere un orizzonte in Siria, benché caratterizzato dal dolore: “Ogni opera esprime la nostra situazione. Ho dipinto a lungo il mare della Turchia, dove affogano i migranti diretti in Grecia, perché questo è ciò che mi colpisce. Attraverso la pittura – dice Narsin – i miei sentimenti trovano la propria espressione”.
Dall’inviato di Radio Onda d’Urto e Infoaut ad Amuda, Rojava
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.