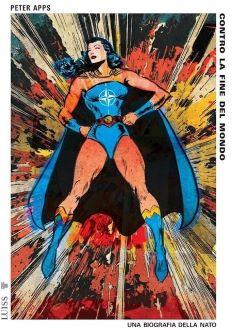Russia: i segreti della resilienza economica
Abbiamo tradotto il testo di Mylène Gaulard, docente di economia presso Università Pierre Mendes France – Grenoble 2, apparso originariamente su Hors-serie in quanto intende mettere a nudo l’enorme distanza tra la narrazione dominante occidentale (e principalmente europea) sul conflitto in Ucraina e la realtà materiale dei rapporti di forza economici e geopolitici che si stanno ridefinendo su scala globale.
La guerra contro la Russia è oggi il fulcro di una trasformazione sistemica attraverso la quale il Capitale euro-atlantico tenta di riconfigurare le proprie economie, principalmente attraverso l’estensione del paradigma bellico.
In Europa, la costruzione della Russia come “nemico esistenziale” risponde a esigenze strutturali prima ancora che strategiche: serve a fornire un quadro ideologico coerente per una profonda ristrutturazione industriale, che altrimenti sarebbe politicamente difficilmente giustificabile. In Germania – locomotiva industriale dell’UE e oggi per il secondo anno consecutivo in recessione – si parla esplicitamente di «Wirtschaftswende», una svolta economica che punta alla riconversione massiccia della filiera industriale verso la produzione militare: dai settori storici come l’automotive, sempre più orientati verso veicoli blindati e logistica militare, fino all’industria aerospaziale, oggi investita da programmi accelerati per la produzione di UAV, droni, sensori e sistemi di puntamento integrati. A cascata, come stabilito dal piano di finanziamento europeo presentato a marzo, questa riconversione dovrebbe interessare gli altri paesi europei, in cui i settori industriali languono o risentono della decrescita tedesca in quanto integrati nella catena di produzione a trazione tedesca.
La strategia politica che accompagna questo piano è tanto ambiziosa quanto fragile: si tratta di bloccare la Russia nel pantano ucraino, logorarla sul campo garantendo un flusso continuo di armi e aiuti finanziari all’esercito ucraino e al contempo strangolarne l’economia con un impianto sanzionatorio senza precedenti, confische extragiudiziali, interruzioni nei flussi commerciali (do you remember Nord Stream?) e nel sistema dei pagamenti globali.
Tuttavia, come i dati raccolti nel testo dimostrano con chiarezza, questa proiezione è sempre più lontana dalla realtà. Mentre le economie europee si muovono a fatica in un contesto segnato da stagnazione, calo degli investimenti e crescente disoccupazione industriale, la Russia registra una crescita del PIL che supera il 4%, trainata da una riconversione interna accelerata e da nuovi circuiti economici alternativi. La crisi non ha marginalizzato Mosca: l’ha costretta a diversificare, a spostarsi verso l’Asia, a investire nella propria capacità produttiva – e tutto questo in un contesto in cui il dollaro, pur restando egemone, vede erodersi lentamente la sua presa sulle dinamiche di scambio internazionale ed in cui gli Stati Uniti sembrano fare del ritorno al «protezionismo» e del disimpegno militare un nuovo terreno di manovra.
In questo scenario, la «vittoria finale» sulla Russia come unico esito accettabile di un conflitto «alle porte d’Europa» appare non solo militarmente improbabile, ma economicamente di difficile realizzazione. È vero, alla lunga l’economia russa potrebbe risentire di un conflitto prolungato, ma solo al prezzo di una lunga e sanguinosa guerra combattuta da centinaia di migliaia di proletari (per ora russi e ucraini; poi, chissá…). Nel frattempo, l’Europa si impoverisce, smantella i residui del proprio welfare per alimentare un’economia di guerra, e si lega mani e piedi alla subordinazione industriale e tecnologica verso gli Stati Uniti (importando armi, gas liquefatto, software militari e ora persino munizioni e acciaio) e verso altre nazioni il cui complesso militare-industriale vede nel riarmo europeo una ghiotta occasione di crescita (si pensi alla Turchia, che si candida a primo produttore mondiale di droni ed è pronta ad intraprendere massicce campagne di marketing in Europa).
Essere contro questa guerra – e contro l’ideologia bellicista che la sostiene – significa rifiutare un paradigma imperiale che si nutre di conflitti permanenti, destabilizzazione sistematica e compressione delle condizioni materiali di milioni di persone in nome di un’illusoria supremazia strategica. Non si tratta di prendere parte al gioco delle potenze, né di «tifare» per Mosca: si tratta di acquisire ed avere tra le mani gli strumenti per leggere ed interpretare la realtà senza affidarsi alle costruzioni propagandistiche europee, e saper utilizzare questi strumenti per indicare il baratro verso cui il capitale europeo ci sta trascinando.
Buona lettura!
Le cifre della resilienza
Bruno Le Maire, all’epoca ministro dell’Economia, annunciava nel marzo 2022 l’intenzione della Francia e dell’Unione europea di condurre una «guerra economica e finanziaria totale contro la Russia». Sperava così di provocare «il crollo della sua economia». Tre anni dopo, sembra che il raggiungimento di questo obiettivo sia assai lontano: la crescita francese supera di poco l’1%, la Germania registra un secondo anno consecutivo di recessione, mentre la Russia, lungi dal crollare, illustra al contrario una crescita del 3,6% nel 2023 e del 4,1% nel 2024. Paradosso inquietante: mentre, secondo le recenti dichiarazioni di Emmanuel Macron, il paese si è imposto come una «minaccia esistenziale» per l’Unione europea, la sua traiettoria economica non sembra interessare gli ambienti accademici[1].
L’uscita della Russia dalla «trappola dei redditi intermedi» nel 2023, ad esempio, è stata assai poco commentata dagli economisti occidentali. Tuttavia, una simile prestazione non è affatto trascurabile. Il concetto di «trappola dei redditi intermedi», reso popolare nel 2007 dagli economisti della Banca Mondiale[2], evidenzia le difficoltà strutturali incontrate dai paesi il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite si colloca tra 1136 e 13845 dollari, e in particolare la loro quasi-incapacità di accedere al livello dei redditi più elevati. Generalmente, queste economie faticano a mantenere la propria crescita, messa in discussione dalla perdita di competitività, dalla limitatezza dei mercati interni o da una produttività stagnante. Ora, con un reddito nazionale lordo pro capite che raggiunge i 14250 dollari nel 2023, la Russia risulta essere il primo paese del gruppo dei BRICS a sfuggire a questa trappola, superando addirittura la Cina (13390 dollari). Un’evoluzione tanto più rimarchevole nella misura in cui si dà nonostante le sanzioni e in un clima geopolitico teso.
Questo stato di fatto dovrebbe incoraggiare un esame rigoroso: siamo di fronte ad una resilienza economica congiunturale, legata agli idrocarburi e all’economia di guerra, o a una dinamica più duratura? Cercheremo qui di decifrare i meccanismi concreti che hanno permesso alla Russia, durante la grave crisi geopolitica che ha attraversato, di preservare le sue basi economiche.
Le misure prese da questa «economia di rendite» contro le sanzioni
Fino ad oggi, il ruolo di fanalino di coda in seno al gruppo dei BRICS veniva tanto più facilmente dato per scontato per la Russia, che questa era sospettata di vivere delle sue risorse naturali, in particolare delle rendite derivanti dal petrolio e dal gas. Questa critica, che assimila l’economia russa a una «economia di rendite», insistendo sul fatto che questi due idrocarburi sono all’origine di quasi il 15% del PIL russo e di un terzo delle entrate pubbliche, dev’essere tuttavia sfumata.
In effetti il concetto di rendita, quando applicato al caso della Russia, trascura gli sforzi di diversificazione intrapresi dal Paese negli ultimi vent’anni. Come «economia di rendite», la Russia avrebbe dovuto sperimentare un collasso economico, data un’economia pericolosamente compromessa da più di 20.000 sanzioni imposte dal 2014 e aumentate dopo il 2022. Queste sanzioni hanno contribuito, è vero, a una diminuzione del 24% delle entrate russe derivanti da petrolio e gas nel 2023, cui è seguito un ulteriore calo del 10% nel 2024. Questo calo si spiega principalmente attraverso due fattori: il tetto di 60 dollari al barile imposto al prezzo del petrolio russo e l’embargo europeo sulle importazioni di idrocarburi. Per aggirare queste restrizioni, la Russia ha anche dovuto ricorrere a una flotta petrolifera parallela, generando costi logistici elevati al fine di trasportare le sue esportazioni presso i suoi principali clienti, la Cina e l’India. Ma alla fine, piuttosto che avere un impatto sulla crescita economica russa, la quasi rottura dei legami commerciali con l’Unione europea e gli Stati Uniti ha soprattutto permesso di accelerare un riorientamento del commercio russo verso l’Asia, rafforzando la posizione della Cina come primo partner del Paese. Allo stesso modo, l’esclusione parziale del sistema SWIFT (la rete di messaggistica criptata utilizzata dalle banche per effettuare transazioni finanziarie internazionali), una sanzione che avrebbe dovuto paralizzare il funzionamento delle banche russe, è stata rapidamente aggirata grazie all’introduzione anticipata di soluzioni alternative come il sistema SPFS, l’equivalente russo di SWIFT sviluppato dal 2014 e l’uso crescente di valute regionali.
Queste misure puntuali, che vengono spesso citate, non sono tuttavia sufficienti a spiegare la resistenza dell’economia russa. Piuttosto che soffermarci su fenomeni secondari e congiunturali, dobbiamo tornare sulla strategia economica implementata dall’inizio del decennio 2000. Il processo di diversificazione intrapreso a quei tempi spiega infatti il mantenimento di una crescita relativamente elevata, anche nel recente periodo di calo dei prezzi del petrolio. Tanto più in un Paese che il crollo del sistema sovietico sembrava aver condannato alla stagnazione.
Ritorno dello Stato dopo il crollo degli anni ’90
Gli anni ’90 rimangono infatti per la Russia il teatro di un disastro economico senza precedenti in tempo di pace: la terapia d’urto neoliberista, con la sua panoplia di privatizzazioni (il 70% del parco pubblico venne ceduto a una manciata di oligarchi e di imprese straniere), ha comportato un calo del PIL del 42% tra il 1991 e il 1998. I salari reali sono stati dimezzati, mentre la povertà è esplosa. Le devastazioni della liberalizzazione finanziaria sono culminate con la crisi del 1998: fuga massiccia di capitali, crollo del rublo e un’inflazione galoppante che privava i russi dell’accesso ai beni essenziali. È su queste rovine che Vladimir Putin, nominato presidente del governo nel 1999 e poi eletto presidente della Federazione Russa nel 2000, ha intrapreso una revisione completa del modello economico.
Che sia per alleviare almeno temporaneamente una popolazione traumatizzata da un decennio di liberalismo brutale, o per uno scetticismo profondo nei confronti delle capacità di autoregolamentazione del mercato, Putin opera, a partire dal 2000, un ritorno in forze dello Stato negli ingranaggi economici. Questa svolta storica è vissuta come un vero affronto dai cantori del neoliberismo occidentale, quelli che non esitano a giustificare il salvataggio delle banche e dei mercati finanziari durante ogni crisi, e paradossalmente si ostinano a smantellare pezzo per pezzo le fondamenta dello Stato sociale così come quelle di uno Stato che svolga una funzione strategica in ambito economico. Appena arrivato al potere, il presidente russo mette invece in pratica le teorie economiche che aveva sviluppato nella sua tesi di dottorato, discussa nel 1997 alla Scuola mineraria di San Pietroburgo. I suoi lavori accademici, dedicati alla gestione strategica delle risorse naturali, rivelavano già una sfiducia caratteristica nei confronti degli attori privati, giudicati incapaci di garantire la stabilità nazionale in tempi di crisi[3]. Ancora più notevolmente, le sue pubblicazioni successive hanno stilato un elenco esplicito di settori ritenuti «vitali», tra cui le materie prime energetiche, che secondo lui dovevano assolutamente tornare sotto il controllo statale[4].
Questa dottrina trova la sua concretizzazione a partire dal 2003. Il colpo di scena legato all’arresto per frode dell’oligarca Michail Chodorkovskij, seguito dalla nazionalizzazione della sua compagnia petrolifera Jukos, segna una svolta decisiva. Rosneft, il fiore all’occhiello del petrolio di Stato, acquirente di Jukos, diventa immediatamente il simbolo di questa riconquista economica. Il movimento accelera nel 2005 con l’acquisizione di Sibneft, altra grande azienda petrolifera, da parte di Gazprom (azienda leader nel gas naturale, al 50,2% statale), completando il riposizionamento delle risorse strategiche entro il perimetro statale. Questo ritorno in forza metodico pone quindi fine a un decennio di anarchia post-sovietica in cui gli interessi privati avevano fatto a pezzi il patrimonio industriale russo.
Un vasto programma di nazionalizzazioni avviato da vent’anni
Un decreto dell’agosto 2004 stabiliva quindi un elenco di imprese pubbliche non privatizzabili in settori strategici dichiarati inalienabili: dalle infrastrutture logistiche vitali (porti, aeroporti), ai fiori all’occhiello dell’industria agroalimentare, fino ai simboli culturali del Paese. Lo Stato riprendeva così il controllo dei livelli più alti del capitalismo russo (energia, aviazione, finanza, elettricità). Le cifre parlano da sole: nel giro di un decennio, la sua quota nell’economia russa subisce un’inversione spettacolare, passando dal 10% del PIL nel 1999 a più del 50% di oggi, superando di gran lunga la media mondiale del 30%.
A differenza della Francia, che dagli anni 1980 ha progressivamente smantellato il suo settore pubblico preservando gli interessi dei suoi «oligarchi»[5], la Russia opera un sorprendente movimento inverso. Lungi dal limitarsi a semplici nazionalizzazioni, questa politica consiste in una ristrutturazione completa dell’apparato produttivo attorno a conglomerati statali. Oltre alle acquisizioni nel settore energetico effettuate da Rosneft e Gazprom e già citate, Rosoboronexport (creata nel 2001 per beneficiare del monopolio delle esportazioni di armi) si vede persino affidare nel 2005 le redini di AvtoVAZ, il costruttore di automobili Lada (prima di un’apertura parziale a Renault nel 2008). Questa logica di consolidamento settoriale raggiunge il suo apice tra il 2006 e il 2007 con la creazione delle «corporazioni di Stato»: OAK per l’aeronautica (civile e militare), OSK per il comparto navale, Rosatom per il nucleare, o ancora Rostechnologies e Rusnano per le nuove tecnologie. Un modello originale in cui lo Stato svolge un compito di strategia industriale più che di semplice di gestore.
Il processo di nazionalizzazione accelera anche dopo il 2022, in un contesto di sanzioni economiche, in particolare con l’assunzione del controllo sugli asset strategici delle imprese che hanno abbandonato la Russia. Sono ad esempio coinvolte società come Danone o Renault, così come le partecipazioni di ExxonMobil e Shell nei progetti Sakhaline 1 e 2 legati all’esplorazione e alla produzione di idrocarburi. Va notato che Shell era già diventata partner di minoranza nel 2006 dopo essere stata costretta a cedere più del 50% della sua quota di Sakhaline 2 a Gazprom, a seguito di accuse più o meno fondate di violazioni ambientali…
Volontà di reindustrializzazione per ridurre la dipendenza dagli idrocarburi
Al di là della riconquista da parte dello Stato di settori chiave dell’economia nazionale, emerge dalla politica economica condotta dalla Russia un’altra lezione essenziale. Lungi dall’accontentarsi di sfruttare passivamente la rendita del petrolio e del gas, il paese cerca attivamente di reindustrializzarsi sfruttandone i proventi. Nessuna modernizzazione economica sostenibile è effettivamente possibile senza un solido sviluppo del tessuto industriale; il rallentamento che accompagna la deindustrializzazione osservata nei paesi occidentali nel corso degli ultimi cinquant’anni ne è una prova lampante. Come enunciato dalla legge economica di Kaldor-Verdoorn, solo l’industria è effettivamente in grado di stimolare la produttività e di garantire un forte accrescimento del PIL nel medio/lungo termine.
Per questo motivo, dopo il brusco declino del peso dell’industria sul valore aggiunto nazionale durante gli anni ’90, viene accordata un’importanza crescente alla reindustrializzazione. Nella fattispecie, tale caduta corrispondeva anche alla volontà di diversificare l’economia riducendo la dipendenza dall’industria pesante e dai settori estrattivi, eredità di un’era sovietica che aveva trascurato l’agricoltura e l’industria dei beni di consumo. Tuttavia, nemmeno questi ultimi sono stati risparmiati dal movimento di deindustrializzazione di quegli anni. Tra il 1990 e il 1998, la produzione industriale russa è crollata del 56%, con cali particolarmente pronunciati nell’ambito dei beni strumentali (-64%) e dell’industria leggera (-89%).
Senza ricorrere necessariamente a un protezionismo virulento come quello di Donald Trump nei primi mesi del suo secondo mandato, la Russia ha progressivamente lavorato alla ricostruzione del suo apparato produttivo nazionale. A partire dal 2005, vengono introdotti incentivi per rilanciare l’industria automobilistica, in particolare riduzioni dei dazi doganali sulla componentistica d’importazione, agevolazioni fiscali e l’obbligo per i costruttori stranieri di associarsi a imprese locali per l’assemblaggio e la fornitura di pezzi di ricambio[6]. E sebbene un decreto del 2011 avesse già vietato l’importazione di macchine utensili in caso di disponibilità di un equivalente prodotto localmente, nell’aprile del 2014 è stata ufficialmente lanciata l’industrializzazione per sostituzione delle importazioni (ISI), con un programma incentrato prioritariamente sui beni strumentali, ovvero quasi un terzo delle importazioni russe, poi con la creazione nell’agosto 2014 della Commissione governativa per la sostituzione delle importazioni.
Approfittando del significativo deprezzamento del rublo a partire dal 2014, che ha perso più della metà del suo valore rispetto al dollaro, la Russia ha messo in atto una serie di misure per sostenere i settori più colpiti dalle sanzioni occidentali decise dopo l’annessione della Crimea nel marzo 2014, in particolare nel settore energetico e nell’industria militare. Ma anche settori come la farmaceutica e l’informatica ne beneficiano. Per sostenere questi rami strategici, la VEB, ovvero la Vnešeconombank, precedentemente responsabile delle transazioni finanziarie internazionali della Russia sovietica e trasformata nel 2007 in banca di sviluppo, così come il Fondo di sviluppo industriale, creato nell’agosto 2014, offrono alle imprese interessate prestiti a tasso ridotto. Allo stesso tempo, il governo impone regole severe: per gli ordini pubblici, i prodotti stranieri devono essere almeno il 15% più economici dei loro equivalenti locali per essere acquistati, e le imprese straniere sono obbligate a collaborare con le società russe per beneficiare di alcune esenzioni fiscali.
Il finanziamento oculato di questa reindustrializzazione
Tutte queste misure adottate a favore della reindustrializzazione sono ovviamente costose, motivo per cui la Russia mobilita sia il suo fondo sovrano, riciclando una parte delle entrate petrolifere, sia una tassazione particolarmente avveduta delle esportazioni di materie prime.
Creato nel 2004, il Fondo di stabilizzazione russo assorbiva allora il 15% delle entrate petrolifere e del gas. Diviso nel 2008 in un Fondo di ricchezza nazionale (dedicato alle pensioni e ai progetti interni) e un Fondo di riserva (per gli investimenti effettuati all’estero), esso viene progressivamente riorganizzato: il Fondo di riserva è stato sciolto nel 2018, lasciando solo il Fondo di ricchezza nazionale le cui risorse raggiungono i 130 miliardi di dollari alla fine del 2024 (ovvero il 6% del PIL), di cui un terzo in asset liquidi rapidamente mobilitabili. Questo fondo, l’undicesimo su scala mondiale, ha svolto un ruolo di stabilizzazione chiave nel 2022, ammortizzando la scossa sul mercato azionario in seguito all’invasione dell’Ucraina, e oggi finanzia le infrastrutture, l’agricoltura e la sostituzione delle importazioni, come il progetto di costruzione di 600 aerei commerciali lanciato alla fine del 2023[7].
Inoltre, con la medesima logica di diversificazione, a partire dagli anni 2000, materie prime come i semi di girasole o i cereali, così come il petrolio e il gas, vengono tassate non appena il loro prezzo supera un certo livello: sono queste risorse che, unite a quelle del fondo sovrano, permettono di sovvenzionare l’industria nazionale, scoraggiando le esportazioni di prodotti non trasformati. Nel 2020 e nel 2021, le esportazioni provenienti dalla metallurgia subiscono la stessa sorte. Nell’ottobre 2023, è il turno dei fertilizzanti e di tutte le materie prime diverse dal legno, dal petrolio, dal gas e dai cereali (già interessati da questo sistema di tassazione[8]).
Queste misure aiutano a limitare il deficit delle finanze pubbliche, che ammonta all’1,7% del PIL nel 2024 (contro il 5,8% della Francia) nonostante la guerra e la continuazione dell’ISI. Per tutti questi motivi, il debito pubblico russo rimane quindi contenuto, e rimane il più basso del gruppo BRICS, attestandosi al 17% del PIL nel 2024 (contro il 114% della Francia). La Russia dimostra così la praticabilità finanziaria del suo modello protezionistico, anche in contesto bellico.
Una reindustrializzazione che non si riduce ad un semplice stimolo all’industria militare
Anche se fortemente criticate dagli economisti neoliberisti dell’Istituto Gaidar di Mosca, eredi della terapia d’urto degli anni 1990, che attribuiscono loro la causa dell’inflazione, del calo di qualità dei prodotto e delle penurie[9], le politiche industriali russe hanno dimostrato la loro efficacia. Secondo i dati della Banca Mondiale e dell’UNIDO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, il valore aggiunto del settore manifatturiero russo è più che raddoppiato dal 2009, confermando un vero e proprio processo di reindustrializzazione. Tale progressione, verificabile presso queste due fonti internazionali, sconfessa sia le previsioni catastrofiche che i sospetti di manipolazione statistica.
Spesso percepito come il sintomo di una «economia del Kalašnikov»[10], cioè un’economia incentrata sulla produzione militare a discapito di una qualunque efficienza complessiva, il rinnovamento dell’industria manifatturiera non si limita tuttavia al solo settore della difesa. Non si può negare che il «keynesismo militare» abbia contribuito alla crescita degli ultimi tre anni: le spese militari rappresentano il 30% della spesa federale, il 7% del PIL nel 2024, essendo quasi raddoppiate dal 2022. Già nel 1940, John Maynard Keynes constatava che «per una democrazia capitalista sembra politicamente impossibile, tranne che in tempo di guerra, organizzare spese nelle proporzioni necessarie per realizzare i grandi esperimenti che dimostrerebbero la mia tesi»[11]. Questa idea non era nuova: un secolo prima, l’economista tedesco Friedrich List notava che l’Inghilterra aveva conosciuto uno sviluppo industriale spettacolare durante il blocco napoleonico[12]. Tuttavia, sarebbe riduttivo fare dell’industria militare l’unico motore dell’attuale successo russo, tanto sono state profonde le trasformazioni economiche avviate negli ultimi vent’anni.
Nell’ambito della sua politica di ISI, la Russia si è concentrata sui settori più dipendenti dalle importazioni, sulla farmaceutici, sui beni strumentali e sui trasporti, pur mantenendo le sue spese militari intorno al 4,5% del PIL fino al 2022, prima dell’aumento legato all’escalation del conflitto ucraino. Secondo i dati dell’UNIDO, il valore aggiunto nell’industria farmaceutica come in quella dei beni di trasporto è aumentato del 2,4% dal 2015; quello nell’industria informatica ed elettronica dell’1,9%. Soprattutto, le esportazioni manifatturiere russe, che rappresentavano solo lo 0,8% del commercio mondiale nel 2000, sono aumentate fino a raggiungere l’1,5% di questa quota nel 2023, con progressi significativi nei fertilizzanti, nell’agroalimentare, ma anche nei macchinari e nelle attrezzature industriali, in particolare nelle tecnologie del nucleare, e nei beni di trasporto (automobili e camion). Sebbene questa quota rimanga modesta, riflette un miglioramento della competitività industriale del Paese, parallelamente a una diminuzione della dipendenza dalle importazioni.
Una certa capacità di resistere alla concorrenza cinese
Questa politica di reindustrializzazione mira dunque fin dal principio a correggere gli eccessi del neoliberismo post-sovietico rivitalizzando i settori industriali trascurati durante il periodo sovietico, e non a riprodurre lo schema del suo produttivismo militarizzato. Il compito è tutt’altro che facile, tanto più in un contesto internazionale che vede la predominanza dalla Cina, che da sola assicura il 30% della produzione manifatturiera mondiale.
Mentre il gigante asiatico rappresenta ormai il 53% delle importazioni russe, Mosca cerca di limitare questa dipendenza con una strategia che combina protezionismo e rilocalizzazione della produzione: aumento dei dazi doganali (fino al 25% sui veicoli cinesi dal 2023, riprendendo misure simili adottate nell’elettronica a partire dagli anni 2010) e obbligo per i produttori di automobili cinesi come Chery, Haval o Geely di aprire stabilimenti sul territorio.
Se il settore dell’elettronica e l’industria automobilistica russa rimangono parzialmente dipendenti dall’assemblaggio di componenti cinesi, i dati dell’UNIDO mostrano un progresso significativo: il valore aggiunto derivante da questi due settori è triplicato dal 2009, a fronte di un «semplice» raddoppio della produzione manifatturiera complessiva. Nonostante lo sviluppo dei tre marchi cinesi menzionati in precedenza, i costruttori russi come AvtoVAZ sono ad esempio ancora particolarmente attivi, intestandosi quasi il 40% delle quote di mercato nel settore automobilistico e oltre i tre quarti per i camion e i veicoli commerciali con marchi leader come KamAZ o GAZ. Queste osservazioni attestano che la politica industriale ha effettivamente dinamizzato la base produttiva nazionale, e non si riduce a una questione di etichettatura o al semplice assemblaggio di componenti intermedie provenienti dalla Cina.
Dei progressi sociali innegabili nonostante un sistema sociale sotto pressione
Diversamente da quanto dovrebbe accadere in un’«economia di rendite», in Russia la produttività del lavoro aumenta rapidamente, e questo secondo i dati stessi della Banca Mondiale[13]. Alcuni potrebbero suggerire che questa espansione industriale improntata all’export vada a disscapito dei lavoratori e della popolazione russa. Tuttavia, i dati smentiscono questa ipotesi: nel 2023, il consumo delle famiglie è cresciuto quasi due volte più velocemente del PIL. Questa dinamica inaspettata smentisce l’idea di un degrado generalizzato del tenore di vita e sottolinea la necessità di analizzare più precisamente gli effetti concreti della politica economica russa sui redditi.
Anche se a lungo mantenuto al di sotto della soglia degli incrementi di produttività del lavoro, perlopiù nell’ottica di preservare la competitività e limitare il surriscaldamento economico, il salario reale medio è aumentato del 150% dal 2005 ad oggi, cioè è stato moltiplicato per 2 volte e mezzo[14]. Questo forte aumento dei salari si spiega principalmente con una contrazione senza precedenti della manodopera russa, con 4 milioni di lavoratori in meno tra il 2017 e il 2023. Questo declino demografico è il risultato di tre fattori chiave: un invecchiamento accelerato, una massiccia emigrazione di lavoratori qualificati dal 2022 e un aumento allarmante della mortalità degli attivi a causa del Covid-19 e della guerra in Ucraina.
Con un tasso di disoccupazione tra i più bassi al mondo, al 3% della popolazione attiva nel 2024, i lavoratori russi si trovano quindi in una posizione favorevole che oggi permette loro di beneficiare in maniera crescente dei frutti della crescita economica. Mentre la Russia era tra i paesi con più disuguaglianze alla fine degli anni 1990, con un indice di Gini[15] ancora a 0,42 nel 2007 – livello paragonabile a quello degli Stati Uniti – essa presenta oggi un livello di disuguaglianze di reddito paragonabile a quello dell’Italia o del Portogallo (0,35 nel 2023). Questo miglioramento riflette l’impatto della crescita economica e delle politiche pubbliche sulla riduzione delle disuguaglianze, anche se permangono differenze significative, in particolare tra regioni e categorie sociali.
Concretamente, sono stati compiuti notevoli progressi in molti settori devastati dalle politiche neoliberiste degli anni 1990. Ad esempio, il tasso di povertà, che misura la percentuale di persone che beneficiano di meno di 6,85 dollari al giorno per vivere, è passato dal 48% nel 1999 ad appena il 2% nel 2021. Anche l’aspettativa di vita ha registrato un netto miglioramento, passando da 65 a 73 anni, principalmente grazie al miglioramento dei servizi sanitari. Allo stesso modo, la mortalità infantile è diminuita, da 15,3 per mille nascite nel 2000 a 4,5 nel 2022, un tasso inferiore a quello degli Stati Uniti (5,6) e prossimo a quello della Francia (4,1).
Anche le pensioni sono state rafforzate grazie all’aumento della spesa pubblica e all’indicizzazione delle pensioni all’inflazione. Tuttavia, le disuguaglianze regionali persistono ancora a questo livello, e molti pensionati delle regioni rurali continuano a vivere con pensioni inferiori alla soglia di povertà. Tensioni di questa natura sono emerse anche durante la riforma delle pensioni del 2018, che ritarderà l’età pensionabile a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne entro il 2028. In effetti, l’invecchiamento della popolazione rappresenta un problema importante per la Russia, probabilmente ancor più importante che per l’Europa occidentale. Si prevede un calo della popolazione attiva di oltre 15 milioni di persone entro il 2050, mentre i pensionati potrebbero rappresentare il 40% della popolazione, un fenomeno che eserciterà una pressione aggiuntiva sulle finanze pubbliche e sul sistema sociale del paese.
I rischi di una continuazione della guerra in Ucraina
Nonostante i numerosi fattori che hanno contribuito alla crescita economica della Russia, persistono alcune debolezze. Un’inflazione elevata, vicina al 10% nel 2024, rimane un’evidente fonte di preoccupazione. L’aumento dei prezzi deriva sia dalla svalutazione del rublo, dai maggiori costi di produzione interni legati alla progressiva sostituzione delle importazioni, sia dall’aumento dei costi generato dall’elusione delle sanzioni (attraverso l’importazione di prodotti vietati per il tramite di Paesi terzi[16]). Soprattutto, il surriscaldamento dell’economia russa rischia di essere esacerbato negli anni a venire dall’aumento dei salari, un aumento indotto dalla carenza di lavoratori già menzionata.
In un tale contesto, un’inflazione «solo» del 10% potrebbe essere percepita come un male minore, o addirittura come il segno del fatto che la situazione economica è sotto controllo, soprattutto se si confronta questa cifra con il 230% di inflazione registrato in Venezuela nel 2024 o con il 32% in Iran, due paesi anch’essi isolati sulla scena internazionale. Tuttavia, se le strategie di sviluppo attuate da Mosca negli ultimi due decenni sembrano averle conferito una maggiore capacità di resilienza, la politica monetaria restrittiva, con un tasso di interesse mantenuto nel marzo 2025 al 21% per contrastare il surriscaldamento economico, potrebbe rapidamente diventare un ostacolo agli investimenti. Senza una continuazione degli aiuti concessi dalle autorità pubbliche alle imprese nazionali, questa politica monetaria potrebbe limitare la crescita dell’economia a medio termine.
Ora, l’aumento vertiginoso delle spese militari, che aggrava il surriscaldamento economico e lo squilibrio di bilancio (certo, ancora ridotto), aumenta la pressione che si esercita sul sistema. E sebbene la quota delle esportazioni di manufatti sia aumentata nell’ambito delle esportazioni totali, quasi il 55% di queste rimane dominato dal petrolio e dal gas, il che mantiene l’economia russa in una situazione di grande vulnerabilità rispetto all’evoluzione dei prezzi delle materie prime. Si stima che un calo duraturo del prezzo del barile di petrolio al di sotto dei 50 dollari, un’evoluzione legata soprattutto all’attuale rallentamento economico mondiale, potrebbe aggravare notevolmente il deficit pubblico e portare a lungo termine a una recessione. Questo crescente squilibrio potrebbe quindi minacciare la stabilità macroeconomica e ridurre il margine di manovra delle autorità per sostenere in modo durevole la crescita.
La continuazione del conflitto in Ucraina rappresenterebbe quindi un rischio per l’economia russa qualora il calo dei prezzi del petrolio dovesse compromettere il finanziamento della spesa pubblica. Sebbene il keynesismo militare possa sostenere la crescita a breve termine, la sua efficacia a lungo termine è infatti limitata dai suoi effetti inflazionistici e dalla distorsione che impone alla struttura produttiva. Una soluzione negoziata al conflitto potrebbe quindi diventare rapidamente necessaria, non solo per ragioni morali e geopolitiche, ma anche, e in modo sempre più vitale, per ragioni economiche.
[1] È anche molto raro trovare specialisti della Russia contemporanea che mantengano una vera imparzialità e la distanza indispensabile per analizzare questo paese, come lo fa il geografo David Teurtrie, insignito del premio Thibaudet 2024 per la sua opera essenziale Russie: le retour de la puissace (Dunod, 2024).
[2] GILL Indermit, KHARAS Homi, An East Asian Renaissance, Ideas for Economic Growth, Washington 2007, World Bank Report
[3] DANCHENKO Igor, GADDY Clifford (2006), «The Mystery of Vladimir Putin’s Dissertation», Brookings Institution, Foreign Policy Program Panel, 30 marzo.
[4] PUTIN Vladimir (2006), « Mineral Natural Resources in the Strategy for Development of the Russian Economy », Problems of Post-Communism, vol. 53, n°1 (trad. di un articolo del 1999, St Petersburg Mining Institute).
[5] È a dir poco irritante constatare che il termine «oligarchia», così volentieri applicato ai magnati russi, trova curiosamente poca eco quando si tratta di descrivere le relazioni incestuose tra alcuni capitani dell’industria francesi e il potere politico. I nostri famosi miliardari sono trattati con meno deferenza dal potere rispetto ai loro omologhi di Mosca? Le distribuzioni al volo di Legioni d’onore, le cene all’Eliseo, le telefonate direttamente al ministro interessato quando un dossier li preoccupa… tutto questo non rientra in una forma di oligarchia alla francese, semplicemente più controllata, più ovattata, drappeggiata nel velluto delle convenienze repubblicane?
[6] TRAUB-MERZ Rudolf (2015), « Oil or Cars. The prospects of Russia’s Reindustrialization », Friedrich Ebert Stiftung, Study FES Moscow, aprile.
[7] STOLYAROV Gleb (2024), «Russia splashes $12 billion to keep aviation sector in the air», Reuters, 21 dicembre 2023
[8] ASTROV Vasily, KOCHNEV Artom, STAMER Vincent, TETI Feodora (2024), «The Russian Economy Amidst the War and Sanctions», Russia Monitor, The Vienna Institute for International Economic Studies, gennaio
[9] SIMOLA Heli (2024), “Recent trends in Russia’s import substitution of technology products”, BOFIT Policy Brief 5/2024. Bank of Finland Institute for Economies in Transition, Helsinki,
[10] CONNOLLY Richard, The Russian Economy: A Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford 2020, p. 88
[11] KEYNES John Maynard, «The United States and the Keynes plan». New Republic, 103 (seconda parte), 1940, p.156.
[12] «I preparativi militari, le guerre e i debiti che in alcuni casi comportano possono, come dimostra l’esempio dell’Inghilterra, contribuire oltre misura all’aumento delle forze produttive di un Paese. I capitali materiali possono essere consumati in modo improduttivo nel senso stretto del termine, eppure questi consumi provocano nelle manifatture sforzi straordinari, nuove invenzioni, miglioramenti e, in generale, determinano un aumento della potenza produttivo» (LIST Friedrich, Il Sistema nazionale di economia politica [1841], Feltrinelli, Milano, 1976).
[13] Banca Mondiale, World Development Indicators data base.
[14] KAPELIUSHNIKOV, Rostislav (2023), «The Russian Labor Market: Long Term Trends and Short Term Fluctuations», Russian Journal of Economics 9, pp. 245-270.
[15] Il coefficiente di Gini, compreso tra 0 e 1, è un indicatore fondamentale che permette di misurare il livello di disuguaglianze nella distribuzione dei redditi o della ricchezza in seno ad una popolazione. Più il suo valore si avvicina a 0, più equa è la distribuzione; al contrario, una cifra vicina a 1 riflette forti disparità. Per garantire un confronto internazionale coerente, i dati qui presentati provengono dalla Banca Mondiale. Tuttavia, le cifre pubblicate da Rosstat, l’agenzia statistica russa, differiscono leggermente in ragione di una metodologia propria. Secondo questo istituto, l’indice di Gini ha raggiunto 0,408 nel 2024, contro 0,405 nel 2023, segnando un leggero aggravamento delle disuguaglianze dopo una tendenza al ribasso iniziata nel 2007. Questa evoluzione è confermata dall’aumento del rapporto tra i redditi del 10% più ricco e quelli del 10% più povero. Diversi fattori possono spiegare questa dinamica, in particolare l’aumento dei salari nei settori in espansione, in particolare quelli legati allo sforzo bellica, che ha beneficiato maggiormente i lavoratori qualificati. Di fronte a questa situazione, le autorità russe hanno fatto della riduzione delle disuguaglianze una priorità. Il presidente russo ha così definito queste disparità come «piaga della società moderna» e si è posto un obiettivo ambizioso: riportare il coefficiente di Gini a 0,37 entro il 2030. Resta il fatto che Rosstat osserva anche nel 2024, nonostante questo leggero aumento delle disuguaglianze, un aumento globale dei redditi reali (+8,4%) di cui han beneficiato tutti i decili della popolazione, e ciò nonostante l’inflazione.
[16] EMLINGER Charlotte, LEFEBVRE Kevin, «Working Around Sanctions. Quanto costa la Russia? », Policy Brief, Cepii, n°50, febbraio 2025
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.
bricscapitalismo russocinaeconomia di guerragasguerra in ucrainarecessionerussiasanzioni