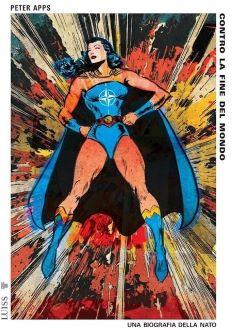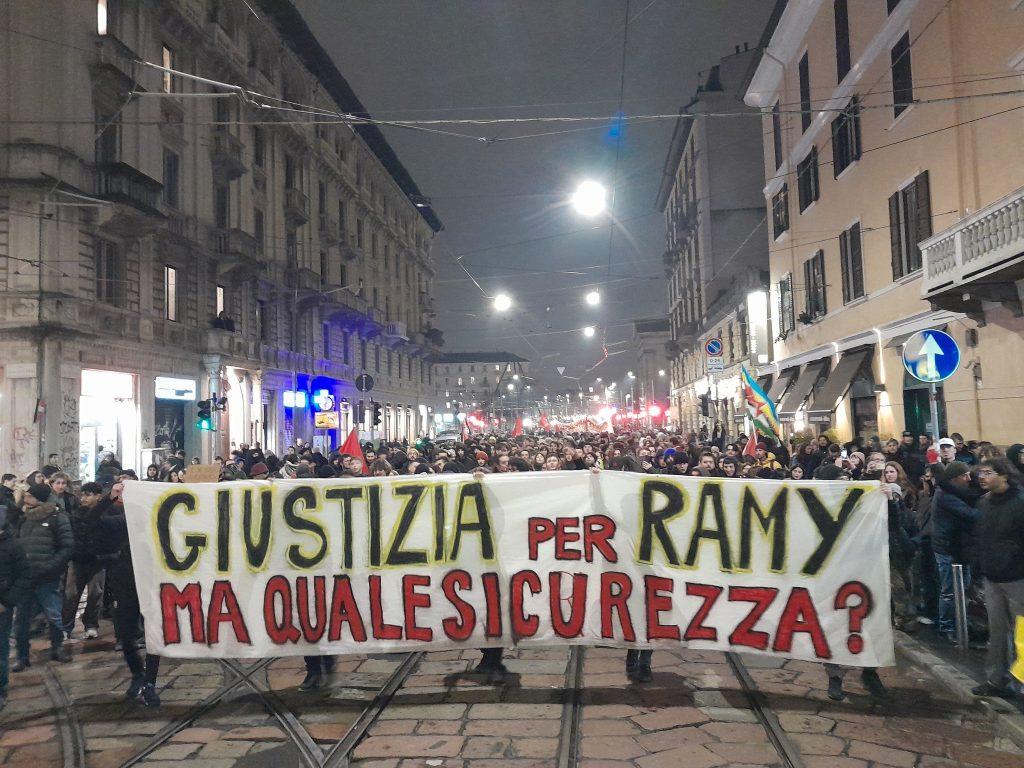L’emergenza come norma. Intervista a Silvia Pitzalis sulle politiche di gestione post-sisma (parte 2)

INFOAUT: Hanno fatto scalpore le parole di Delrio pronunciate da Vespa rispetto al terremoto come “volano per la crescita”. Del resto, nel titolo stesso del libro parli esplicitamente di politiche del disastro, inserendoti anche nella famosa definizione di “shock economy” coniata da studiosi come Naomi Klein. Quali sono state le principali linee di azione e sviluppo di queste politiche nel territorio emiliano?
Nell’ultimo ventennio le scienze sociali hanno evidenziato il fatto che disposizioni e procedure di intervento istituzionali in situazioni emergenziali siano ormai sempre più tese a rispondere a interessi di governi e organi internazionali, affidando al settore privato la gestione del post-disastro e istituendo modalità di azione che rientrano nel paradigma della “shock economy” (Klein 2007). Il quale si presenta come un fenomeno sociale che innesca processi di dilatazione delle tempistiche di ricostruzione e rilocazione della popolazione, favorendo, così, azioni presentate come soluzioni migliorative della sicurezza e dello sviluppo socio-economico, tese invece alla speculazione.
Il disastro si presenta come possibilità per le istituzioni di applicare specifiche strategie politiche e tecniche di governo che, da un lato, limitano le capacità economiche dei singoli, il loro accesso ai mezzi di sussistenza e alle risorse del territorio e, dall’altro, depotenzia la loro capacità auto-organizzativa, restringendo sempre più gli interstizi all’interno dei quali produrre forme oppositive al potere dominante. Questo utilizzo strumentale della catastrofe finalizzato al potenziamento di interessi capitalistici, oltre che incrementare la vulnerabilità dei soggetti, determina e amplifica stati di incertezza e precarietà che nutrono e definiscono il dissenso in forme contestualmente determinate.
Seguendo tali linee teoriche l’analisi della relazione tra le istituzioni (locali e nazionali) e il cittadini terremotati nella particolare fase della ricostruzione emiliana sembra essere governata da strategie dettate da forme di capitalismo dei disastri e legate a concezioni della vita dei soggetti fortemente influenzate dal neoliberismo. Nello specifico le attività di ispezione e monitorizzazione tecnico-legislativa delle procedure riguardanti la ricostruzione forniscono alle istituzioni e ai suoi agenti sempre maggiore potere sui cittadini, esercitato grazie alla politicizzazione del disastro (Alexander 2010) riducendo il terremotato a semplice pagante passivo, obbligato ad accettare acriticamente quanto deciso dai tecnici a supporto e legittimazione del programma ideato dalle istituzioni.
Il caso emiliano è fortemente caratterizzato dall’estromissione del soggetto in una fase ricostruttiva gestita dalle ordinanze del Commissario e dalla struttura burocratica. Dagli atti normativi, infatti, trapela una mancata (quando non negata) presenza del ruolo attivo dei terremotati e la loro figura emerge come un’entità astratta, una moltitudine indistinta differenziata solo da un indice scalare del danno delle abitazioni, che limita il rientrare degli individui nel diritto alla ricostruzione.
A mio avviso è stato così avviato il passaggio dallo “stato di eccezione” ad un nuovo “stato nel diritto”, intendendo con quest’ultimo uno spazio fortemente normato – ma in cui ancora l’ordinamento vigente viene derogato in favore di nuove leggi speciali – all’interno del quale il terremotato diventa possessore di diritti che gli offrono la possibilità di ottenere la ricostruzione della propria casa, ma solo a condizione che egli rientri nei dettami della norma, la quale segue precise indicazioni. L’intervento istituzionale si presenta, così, in una duplice e contemporanea veste: una, legittimata dall’urgenza, è tesa a rilocare la popolazione rimasta senza casa in nome dell’accudimento e della sicurezza; l’altra, supportata dalla giuridicità della riforma, costruisce i limiti di ciò che è a norma di legge, escludendo possibilità altre. Essa inoltre impone nuove identità neoliberiste sul cittadino, che da soggetto contemporaneamente desiderante e munito di diritti transita repentinamente verso lo status di semplice produttore-consumatore.
INFOAUT: Nonostante le promesse post-sisma, a quattro anni di distanza in Emilia ancora tanta gente vive nei container. In generale, un po’ come riguardo alla sfera partitica, sembra essere ormai sedimentata una sfiducia nei confronti delle istituzioni riguardo alla gestione di simili eventi. Che forme ha preso questa sfiducia nelle terre terremotate d’Emilia?
Nel caso emiliano due sono state le reazioni a questo dispositivo. La prima si è palesata con una profonda insoddisfazione nei confronti delle modalità di intervento imposte, in quanto si pensa all’azione istituzionale nell’emergenza prevalentemente in termini economici; lì ove appare ovvio che le cifre elargite sono spesso insufficienti per ricreare la vita economica delle migliaia di famiglie colpite dal disastro. Questa esiguità accresce la sensazione di essere stati abbandonati al proprio destino; per non parlare delle ricadute negative sul versante della fiducia collettiva e dei rapporti interpersonali, poiché può accadere che si creino disaccordi, invidie e dubbi su presunti o reali favoritismi nei confronti di chi ha ricevuto di più. Si aggiunga poi che il malcontento cresce nel momento in cui diventa evidente che il problema economico non è il solo e che, all’indomani di una catastrofe, urge una ri-edificazione del tessuto sociale, culturale e politico nel contesto di crisi.
La seconda reazione, conseguente alla prima, è che gli evidenti malcontenti producono rifiuto non solo della figura degli esecutori degli interventi, ma di tutto l’apparato istituzionale impiegato e delle sue procedure. Questo avviene anche perché la strategia retorica impiegata per la formulazione delle politiche d’intervento è, paradossalmente, indirizzata verso le istituzioni, che si auto-definiscono come principali agenti dell’intervento e trascurano, in pratica, le necessità e le volontà dei diretti interessati, tenuti ai margini delle decisioni relative alle modalità operative di medio e lungo termine da impiegarsi nel corso del post-sisma. Si nega così alle popolazioni la possibilità di reagire al disastro partecipando in maniera attiva ai percorsi di gestione dell’emergenza. In questo modo l’ordinamento dell’emergenza propone, ridefinendole, ideologie e pratiche di integrazione sociale asimmetriche, selettive e dinamiche.
In quanto “macchina anti-politica” (Ferguson 1990), il dispositivo dell’emergenza destituisce la politica come argomento collettivo, alimentando il fatalismo, l’assistenzialismo, la dipendenza e neutralizzando le potenzialità di innovazione locali (Malighetti 2011, 42). La standardizzazione delle condotte reprime l’auto-determinazione degli individui inducendo una diffusione diseguale del potere (Boni 2011, 45). Il terremotato risulta, quindi, escluso come protagonista attivo nelle procedure ma incluso in esse come fruitore-destinatario degli interventi. Operando attraverso il dispositivo dell’eccezione e della sospensione della norma, la categoria dell’emergenza, istituzionalizza l’esclusione dei soggetti, finalizzata all’inclusione eccezionale e al dominio (Malighetti 2011, 45). Questo dispositivo assistenziale concede ai terremotati forme di cittadinanza limitate al solo livello giuridico (per altro in maniera teorica), in linea con gli intenti di “integrazione parziale atte a supportare le condizioni di funzionamento del sistema” (Ibidem).
INFOAUT: Come questa sfiducia nelle istituzioni ha secondo te rinforzato le pratiche di solidarietà dal basso emerse in occasione di questo terremoto, ad esempio con le raccolte organizzate dalle BSA? Quali ulteriori spazi di comunicazione ed organizzazione tra realtà politiche autorganizzate e cittadini sono perseguibili?
Per rispondere a questa domanda e per meglio comprendere quali fossero le forze oppositive in campo bisogna, a mio avviso, prima evidenziare il fatto che da evento considerato generalmente come “eccezionale”, il cataclisma, in generale, si palesa come un catalizzatore e un rivelatore di crisi sociali e politiche più profonde. Questo nella misura in cui esso, nel suo manifestarsi, esso si presenta come generatore di profondi conflitti (Lupton 2003, 75) tra differenti soggettività in campo: tra coloro costruiscono definizioni e rappresentazioni della catastrofe e chi ne rimane coinvolto; tra coloro che assumono la gestione del post-disastro e i destinatari degli interventi. Sono questi gli aspetti che rendono il disastro un concetto altamente politico.
Credo sia fondamentale comprendere che il terremoto, come tutte le tipologie di disastro, non è unicamente un evento fisico che ha un preciso impatto su una comunità, ma un “disastro” inteso in senso socio-antropologico, ovvero come un fenomeno sociale, poliedrico e multifattoriale. Partendo, dunque, dalla valutazione di quest’ultimo come la particolare esacerbazione di una crisi preesistente – una crisi nella crisi – esso emerge come un evento, innegabilmente traumatico, ma di estrema trasformazione socio-culturale e politica che offre ai soggetti coinvolti l’opportunità di prendere coscienza della propria condizione (di terremotati ma anche di cittadini inascoltati), mettendo in discussione il sistema dominante ed evidenziando l’inadeguatezza e l’inefficacia del sistema socio-politico di riferimento; dall’altro come il potenziale motore di meccanismi di rigenerazione sociale e politica, in quanto genera un ripensamento e una riedificazione del sistema sociale, culturale e politico di riferimento, rispondendo alla necessità da parte della comunità coinvolta di ripristinare un nuovo ordine/equilibrio.
La catastrofe è, dunque, un fenomeno sociale indicatore del regime socioeconomico e politico del contesto in cui la violenza del suo dispiegarsi si manifesta e per questo rivelatore del grado di disuguaglianza e ingiustizia insita in una società (Saitta 2015, 10; Powers 2006). Essa inoltre irrigidisce le reazioni di alcuni settori della società, aprendo lo spazio per l’elaborazione di forme di critica al regime di azione associato alla risoluzione dei suoi danni (Revet 2011, 160). Alla luce di quanto detto il terremoto emiliano risulta un punto privilegiato da cui analizzare le relazioni tra cittadini e istituzioni, non solo entro il contesto locale, ma anche in quello globale.
L’intervento emergenziale, ad esempio, diventa un angolo privilegiato per monitorare, da un lato le manifestazioni della sovranità e del potere, dall’altro l’effettiva erosione della rappresentanza politica e della fiducia nei suoi esponenti. Indagare etnograficamente questi fenomeni significa dotarsi di uno strumento capace di supportare l’universalizzazione della libertà e del concetto di partecipazione, seguendo un progetto che abbia la volontà di rimettere al centro l’idea universale di essere umano, così come venne pensata da Hegel e Marx. Questo necessario processo deve avere come obiettivo la costruzione di percorsi di lotta che portino all’estensione dei diritti, in nome di una reale equità tra le persone. Lo studio dunque di cosa l’imposizione, il comando e il controllo generino a livello socio-politico e culturale rimane un atto necessario teso a tal fine. L’adesione da parte della popolazione alle procedure imposte dalla macchina emergenziale e, in generale, il grado di accettazione e “allineamento della prassi individuale al messaggio sponsorizzato e prevalente” (Boni 2011, 79), si manifesta per gradi differenti e risulta essere sempre parziale.
Ciò vuol dire che all’interno del modello imposto dalla Protezione Civile è possibile ammettere dei comportamenti che lo rigettano e delle forme di contro-condotta (Foucault 2005) che si pongono ai margini dell’arena di operatività governata dalla categoria emergenziale. Questa posizione di marginalità è tipica di chi si pone dei dubbi sulla plausibilità e sulla legittimità di determinati saperi e pratiche (Remotti 2000, 26), perché, come sostiene Scott (2006), non esiste nessuna società capace di produrre una forma di consenso e adesione che sia totalizzante e indiscutibile. Queste forme di devianza, ovvero quelle modalità di agire al di fuori di canoni prestabiliti, sono poste in essere da chi, escluso da specifici ambiti, elabora “una certa incredulità rispetto alle potenti verità del potere” (Boni 2011, 82). Per comprendere e definire queste pratiche Foucault ne La volontà di sapere sviluppa il concetto di resistenza, mettendo in luce il nesso tra forme di esercizio del potere e forme di resistenze ad esso.
Queste forme di contrapposizione al potere dominante sono inoltre spinte da precisi valori, quali la solidarietà e la condivisione, l’aiuto reciproco, l’orizzontalità, una certa propensione a diffidare della e a beffeggiare la autorità; oltre che da specifiche prassi, come l’autodeterminazione, le sollevazioni più o meno violente, il rigetto e il boicottaggio dei paradigmi e la produzione di alternative ai modelli imposti dal potere dominante. La prassi eversiva annuncia la volontà di un protagonismo politico che, rifiutando saperi, verità e procedure imposte come legittime in nome dell’ingerenza/urgenza/eccezione, si avvale della facoltà di ristabilire il proprio pensiero e la propria condotta (Boni 2011, 89). All’interno di questa teorizzazione potremmo inserire quell’insieme di strategie e pratiche alternative alla “gestione ufficiale” dell’emergenza che ha dato vita al fenomeno dei campi autogestiti, campi-tenda costruiti e composti dagli stessi terremotati emiliani in zone spaziose e verdi – parchi, giardini pubblici e privati, parcheggi, per lo più nei pressi delle abitazioni degli interessati – gestiti secondo i principi della condivisione, della collaborazione, dell’autonomia e dell’auto-gestione.
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.