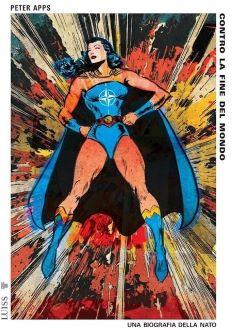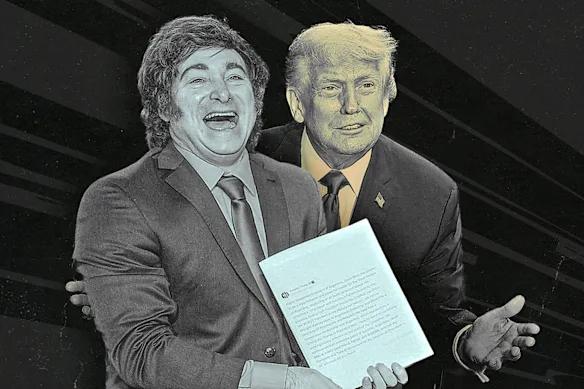Il significato dell’ascesa cinese
Riprendiamo e traduciamo da marxist.com questa interessante analisi di Kenny Wallace sul significato dell’ascesa cinese.
Buona lettura!
Questa nazione, che appena due decenni fa era ancora immersa nel sottosviluppo, è oggi impegnata in una titanica rivalità con gli Stati Uniti, nella quale riesce a mantenere la propria posizione. Nel frattempo, l’imperialismo americano, di gran lunga la potenza più forte del pianeta, appare in un vicolo cieco, intrappolato in una rete di contraddizioni.
Questa rivalità rappresenta oggi il principale asse attorno al quale ruota la situazione mondiale. Come ha fatto l’economia cinese a raggiungere un simile risultato? E cosa significa questo per la crisi del capitalismo mondiale?
Un’ascesa inconfondibile
In un’economia mondiale segnata dalla stagnazione, la crescita del PIL cinese si aggira recentemente intorno al 5%. Un’espansione notevole in termini assoluti per un’economia ormai tre volte più grande di quella giapponese. Ancor più rilevante, questo tasso supera di gran lunga quello delle vecchie potenze imperialiste: gli Stati Uniti crescono del 2,8%, mentre l’Unione Europea ristagna allo 0,1 per cento, con un’industria in declino.
A differenza di molte delle vecchie potenze imperialiste, le cui industrie si sono indebolite e deteriorate a favore del capitale finanziario, il settore industriale cinese rimane vitale e già domina su scala globale. Secondo The Economist, la sola Cina rappresenta il 30% della produzione manifatturiera mondiale, più di Stati Uniti, Germania, Giappone e Corea del Sud messi insieme. Non mostra inoltre segni di rallentamento: il valore aggiunto industriale cinese, ovvero il nuovo valore creato dall’industria, continua a crescere a un ritmo del 5-6% l’anno.
E’ necessario quindi anche osservare ciò che la Cina produce oggi. Sono ormai lontani i tempi in cui il Paese realizzava soltanto abbigliamento di bassa qualità, giocattoli e articoli di uso quotidiano. L’etichetta Made in China è ormai associata ai prodotti tecnologici più avanzati del mondo. Dal 2020, la Cina domina la produzione mondiale di computer ed elettronica, prodotti chimici, macchinari e apparecchiature, autoveicoli, metalli di base, metalli lavorati e apparecchiature elettriche.
Inoltre, la Cina è diventata una potenza nella ricerca e nell’innovazione. Oggi, secondo il Nature Index, sette delle dieci principali istituzioni di ricerca al mondo sono cinesi. Il Paese domina il settore della robotica sia per numero di brevetti depositati (i due terzi del totale mondiale provengono dalla Cina) sia per numero di robot installati, superiore a quello del resto del mondo messo insieme. Le cosiddette dark factories, fabbriche quasi completamente robotizzate che impiegano così pochi lavoratori da non richiedere illuminazione, vengono ormai introdotte in numerosi settori manifatturieri.
Anche nei comparti dove incontra difficoltà di aggiornamento a causa dell’ostruzionismo statunitense, come nell’industria dei semiconduttori, l’autosufficienza cinese continua a migliorare rapidamente. I tentativi degli Stati Uniti di bloccare l’accesso della Cina alle tecnologie più avanzate in questo campo stanno di fatto stimolando lo sviluppo di alternative domestiche all’avanguardia per la produzione di microchip di ultima generazione.
Sebbene la maggior parte di queste innovazioni sia stata applicata ai beni di consumo, il loro impiego militare sta rapidamente seguendo la stessa traiettoria. Per citarne solo alcune, la Cina ha introdotto droni capaci di muoversi sott’acqua e di volare, grandi droni subacquei e a propulsione che permetterebbero a qualsiasi nave da guerra di operare come una portaerei. Tutti questi sviluppi suscitano imbarazzo e timore tra i concorrenti occidentali della Cina.
Il quadro è chiarissimo: la Cina sta crescendo su una scala tale da mettere in discussione la supremazia statunitense in molti ambiti. Da tempo ha abbandonato la dipendenza dagli investimenti esteri e dalla manifattura a basso valore aggiunto, affermandosi come una potente nazione imperialista. Come è stato possibile tutto questo? E tale sviluppo potrà continuare senza contraddizioni?
I “privilegi dell’arretratezza”
Un fattore materiale chiave che spiega il sorprendente progresso della Cina risiede nel suo punto di partenza. Mentre i primi Paesi capitalisti portano sulle spalle il peso di decenni di contraddizioni accumulate, inefficienze, debiti e altri problemi legati alle forze produttive, la Cina, pur possedendo una certa base industriale, era un Paese arretrato rispetto all’Occidente quando entrò nel mercato capitalistico mondiale. L’industria high-tech era inesistente e poteva essere costruita da zero.
Eppure, la Cina non dovette sviluppare la propria industria completamente da capo: fin dall’inizio poté adottare le tecniche più avanzate disponibili nel mondo.
Questo fenomeno rientra nello sviluppo diseguale e combinato del capitalismo come sistema mondiale, che Trotsky aveva già osservato in Russia:
“Il privilegio dell’arretratezza storica, e tale privilegio esiste, permette, o meglio costringe, ad adottare tutto ciò che è già pronto, saltando una serie di fasi intermedie. I selvaggi abbandonano arco e frecce per i fucili tutto d’un tratto, senza percorrere la strada che un tempo separava le due armi. I coloni europei in America non ricominciarono la storia dall’inizio. Il fatto che la Germania e gli Stati Uniti abbiano superato economicamente l’Inghilterra è stato reso possibile proprio dalla loro arretratezza nello sviluppo capitalistico. D’altro canto, l’anarchia conservatrice dell’industria carbonifera britannica, così come nella mente di MacDonald e dei suoi amici, è il prezzo da pagare per il passato, quando l’Inghilterra interpretò troppo a lungo il ruolo di pioniera capitalista. Lo sviluppo delle nazioni storicamente arretrate conduce necessariamente a una combinazione peculiare di differenti stadi nel processo storico. Il loro sviluppo complessivo assume un carattere complesso, irregolare e combinato”.
Shenzhen, oggi la terza città più grande della Cina, rappresenta l’esempio più evidente di questa trasformazione. Nel 1980 era poco più di un villaggio di pescatori con 30.000 abitanti. Designata come prima “zona economica speciale” in un passo verso la restaurazione capitalista, crebbe rapidamente fino a diventare un polo per le apparecchiature di telecomunicazione a metà degli anni ’90. Nei primi anni 2000 si era già trasformata nella “fabbrica del mondo”, producendo telefoni cellulari per i marchi occidentali.
Grazie a un intervento statale mirato, Shenzhen riuscì ad attirare enormi investimenti e forza lavoro qualificata, permettendo così il passaggio a industrie tecnologicamente più avanzate. Oggi è celebrata come la “Silicon Valley della Cina”. Tutto questo si è realizzato in appena quattro decenni.
Gli esempi dei benefici derivanti dal cosiddetto privilegio dell’arretratezza, noto anche come vantaggio del ritardatario, sono numerosi. La Stazione Spaziale Tiangong, gestita in modo indipendente dalla Cina e una delle sole due stazioni spaziali attualmente operative, è stata costruita sfruttando le ricerche e le lezioni più recenti dei programmi spaziali statunitense e russo. Progressi analoghi si riscontrano anche nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nell’alta velocità ferroviaria e nella raffinazione dei minerali di terre rare.
La Cina riconosce e sfrutta pienamente questo vantaggio. Come ha spiegato con chiarezza Fan Gang (樊纲), presidente del China Development Institute, ente statale di ricerca economica:
“Ogni anno il Paese spende più di 30 miliardi di dollari per acquistare proprietà intellettuali o diritti di licenza; e impara e imita voracemente le conoscenze non protette. In quanto late bloomer, può accedere a tali conoscenze più rapidamente e a costi inferiori. E imitare non è vergognoso.”
Tuttavia, i “privilegi dell’arretratezza” da soli non bastano certo a spiegare il successo prolungato della Cina. Esistono molti altri Paesi che, pur partendo da condizioni simili, restano intrappolati nell’arretratezza e non riescono a uscirne. Un ulteriore fattore decisivo del successo cinese risiede nel ruolo dello Stato controllato dal Partito Comunista Cinese (PCC).
Il ruolo di uno Stato bonapartista
La Cina è governata da una dittatura monopartitica guidata dal Partito Comunista Cinese. Pur sostenendo il capitalismo e reprimendo la classe lavoratrice, lo Stato interviene con forza nel mercato, mantenendo la borghesia sotto controllo e obbligandola a seguire le sue direttive su come comportarsi e dove investire il proprio capitale.
Il partito-Stato controlla diversi snodi chiave dell’economia. A differenza della maggior parte dei Paesi capitalistici, le politiche monetarie e fiscali della banca centrale sono dirette dal Partito. Inoltre, lo Stato detiene la proprietà maggioritaria delle principali banche commerciali del Paese, quattro delle quali sono oggi le più grandi al mondo, potendo così orientare il loro capitale in base alle priorità della politica statale rispetto al conseguimento di profitti a breve termine in favore degli azionisti. Inoltre, lo Stato stabilisce obiettivi di sviluppo economico e costringe la borghesia privata (ossia i capitalisti proprietari di imprese non statali) a conformarsi attraverso sussidi o regolamentazioni.
I capitalisti le cui azioni minacciano la stabilità del sistema vengono rapidamente fermati. Per esempio, quando il CEO di Alibaba, Jack Ma, tentò di lanciare la rischiosa iniziativa finanziaria Ant Group, che aveva raccolto la cifra record di 34 miliardi di dollari dagli investitori, lo Stato intervenne, bloccando il progetto e costringendolo temporaneamente all’esilio. Le autorità giudicarono che Ant Group presentasse molte delle caratteristiche tipiche delle grandi società finanziarie occidentali, comprese pratiche speculative e comportamenti dirigenziali irresponsabili che in passato avevano causato crisi come quella del 2008. Inoltre, Ma stava diventando un simbolo delle disuguaglianze sociali in Cina. Le autorità decisero quindi di intervenire tempestivamente, prima che il rischio potesse degenerare.
Anche la condotta personale di Jack Ma spinse il PCC ad agire. Al momento del lancio di Ant Group, Ma si lamentò pubblicamente dell’eccessiva regolamentazione nel settore finanziario. Data la sua notorietà e la sua ricchezza, una simile dichiarazione pubblica equivaleva a una sfida aperta all’autorità del Partito, un atto che non poteva restare impunito, nonostante Ma fosse egli stesso un iscritto al PCC. Inoltre, il Partito trasse da questa mossa un certo consenso popolare, poiché Jack Ma era già ampiamente detestato per la sua arroganza e la sua ostentata ricchezza.
Questa misura disciplinare contro un singolo capitalista non fu un episodio isolato. Nello stesso anno in cui Jack Ma venne punito, il PCC inflisse multe a numerose aziende cinesi per centinaia di milioni di dollari, provocando un calo dei titoli azionari e perdite per oltre mille miliardi di dollari agli investitori. Nel 2024, secondo il quotidiano statale Global Times, il totale delle sanzioni comminate è salito a 1,52 miliardi di dollari. Inoltre, gli imprenditori che dichiaravano bancarotta venivano inseriti in una lista nera, esclusi dai prestiti futuri e privati del diritto di sostenere spese di lusso.
In Occidente, dove i politici sono nelle tasche dei ricchi, la borghesia domina generalmente lo Stato, la cosiddetta “rule of law” viene formalmente rispettata, e i capitalisti non rischiano di essere presi come esempio negativo. La loro proprietà è al sicuro, e non devono nascondersi se criticano il governo, anzi, sono spesso i politici a doversi piegare alla volontà della classe capitalista.
Il confronto tra Elon Musk e Jack Ma è istruttivo. Entrambi sono miliardari della tecnologia, megalomani e con un’irrefrenabile voglia di esprimere le proprie opinioni al mondo. Tuttavia, gli esiti delle loro vicende sono stati molto diversi: Musk ha potuto comprare influenza politica, scontrarsi con un Presidente degli Stati Uniti e continuare a mantenere intatti il proprio patrimonio e i contratti pubblici; Ma, invece, è stato emarginato per anni e privato di una parte significativa del suo impero economico dal PCC.
Oltre alle punizioni severe, lo Stato cinese utilizza anche un approccio basato sul principio del “bastone e la carota” per indirizzare il mercato nella direzione desiderata. I settori favoriti dallo Stato ricevono sussidi massicci, tagli fiscali e altre agevolazioni, spesso attraverso joint venture pubblico-private con i governi locali. Inoltre, il Partito colloca propri quadri e strutture all’interno delle imprese private, in particolare quelle considerate “leader di settore”, per assicurarsi che operino in conformità con le linee politiche statali.
In questo modo, lo Stato garantisce anche che meno capitale confluisca in settori rischiosi o improduttivi, come quello finanziario. Mentre in Occidente miliardi vengono investiti in riacquisti di azioni (buyback) o nell’ennesima moda delle criptovalute, nel 2017 la Cina ha vietato il mining e il commercio di criptovalute sul proprio territorio, nonostante all’epoca ne fosse il più grande mercato mondiale.
L’indipendenza relativa dello Stato cinese dagli interessi borghesi immediati gli consente inoltre di disporre di più strumenti per contenere recessioni o crisi potenziali. È in questo modo che è stato gestito il caso del default di Evergrande, per evitare un effetto domino sull’intera economia.
Subito dopo la notizia del fallimento di Evergrande, lo Stato istituì un comitato ad hoc, dalla natura opaca, incaricato di gestire la crisi. Imprese statali e private furono mobilitate per assorbire parte del debito e completare i progetti edilizi incompiuti, mentre vennero congelati gli asset del CEO Hui Ka-yan, per un valore di centinaia di milioni di dollari. Così, sebbene la crisi resti in corso e il settore immobiliare continui a esercitare pressioni al ribasso sull’economia, si è riusciti a evitare un crollo sistemico.
Al contrario, quando Lehman Brothers precipitò nella crisi dopo anni di pratiche rischiose incontrollate, il governo statunitense non fu in grado di impedirne il collasso, che trascinò con sé l’economia mondiale. Eppure, dopo il disastro, la Federal Reserve fu costretta a spendere miliardi per salvare altre aziende ed evitare un effetto domino, mentre il CEO di Lehman Brothers poté conservare centinaia di milioni in stipendi e bonus.
Lo Stato cinese ha inoltre adottato misure per dirottare gli investimenti dal settore immobiliare verso la manifattura, ritenuta in grado di ridurre i rischi strutturali dell’economia.
Tuttavia, la disciplina imposta alla borghesia è solo una faccia della medaglia. La principale preoccupazione dello Stato cinese resta la repressione della classe lavoratrice.
Il Partito non ha mai concesso alle masse veri diritti democratici e, negli ultimi anni, ha ulteriormente rafforzato il controllo. La censura online è onnipresente e costantemente potenziata da tecnologie di sorveglianza sempre più sofisticate. Naturalmente, ogni tentativo di organizzare sindacati al di fuori delle strutture ufficiali viene represso senza esitazione.
In assenza di autentiche organizzazioni dei lavoratori, progetti come l’introduzione delle dark factories, che minacciano l’occupazione operaia, possono procedere senza opposizione.
Ma lo Stato controlla anche l’altro lato del conflitto di classe, per mantenere la stabilità complessiva del sistema. A volte interviene nelle dispute tra lavoratori e datori di lavoro a favore dei primi, per evitare che il malcontento si allarghi. Di recente, il governo ha anche promosso l’aumento del salario minimo, in parte per stimolare i consumi e contrastare la deflazione, ma anche per attenuare la rabbia sociale.
Il PCC è riuscito a conseguire tutto ciò perché, già prima della restaurazione del capitalismo in Cina, aveva dato vita ad uno Stato di polizia potente e pervasivo. A differenza di quanto accaduto nell’Unione Sovietica, dove lo Stato collassò, il PCC mantenne un controllo stretto sul processo di restaurazione capitalista, conservando così la propria posizione dominante nella società cinese.
Durante la trasformazione della Cina da economia pianificata a economia dominata dalle forze di mercato, dal profitto e dalla proprietà privata, il Partito mantenne il controllo dei principali snodi economici, in particolare delle banche e di alcuni settori strategici. Gli investimenti stranieri furono accolti, ma tenuti fuori dalla proprietà diretta delle imprese.
Da un lato, la burocrazia statale non ha alcun interesse a permettere che il proprio potere venga usurpato dagli imperialisti stranieri o da una frazione della borghesia. Dall’altro, essa deve anche reprimere la classe lavoratrice al servizio del capitalismo nel suo complesso, e dunque non ha alcun interesse a concedere alla classe operaia i diritti tipici della democrazia borghese, come quello di formare sindacati indipendenti.
La burocrazia del PCC deve costantemente mantenere un equilibrio tra la borghesia e la classe lavoratrice, una condizione che i marxisti definiscono “bonapartismo”, ossia una situazione in cui lo Stato si eleva al di sopra delle classi sociali e governa direttamente attraverso metodi di polizia, al fine di preservare l’ordine e il sistema esistente nel suo insieme.
Il bonapartismo dello Stato cinese, tuttavia, presenta cause e caratteristiche specifiche. Nella definizione di Marx, il bonapartismo si manifesta nei Paesi in cui la lotta di classe è in una fase di stallo: in questo contesto emerge un “uomo forte” che promette di ristabilire l’ordine rafforzando i poteri repressivi dello Stato, e che in tal modo riesce a conquistare un ampio margine di autonomia rispetto alla classe dominante, pur agendo, in ultima istanza, nel suo interesse.
Il regime bonapartista della Cina contemporanea non deriva da uno stallo nella lotta di classe, bensì da una burocrazia che, dopo aver drenato a proprio vantaggio i frutti dell’economia pianificata, ha restaurato il capitalismo fondando i propri privilegi e interessi su di esso. Tutto ciò non avrebbe potuto avvenire senza la continua repressione delle libertà politiche dei lavoratori. Allo stesso tempo, questo processo ha generato una nuova classe di capitalisti che dipendono da quello stesso Stato per la propria esistenza e prosperità.
La presenza di questo Stato bonapartista, capace di intervenire pesantemente nel mercato e di disciplinare il comportamento della classe capitalista, unita alla “giovinezza” dell’economia cinese, ha conferito alla Cina un vantaggio competitivo significativo rispetto agli avversari occidentali.
“Lo spirito dell’Apollo”
Forte del suo peso nella società, lo il Partito-stato può guidare progetti di ricerca e sviluppo su scala nazionale, coordinando gli sforzi con una rapidità straordinaria, in modo paradossalmente non troppo diverso da come gli Stati Uniti organizzarono la propria corsa allo spazio.
Come ha osservato Bruno Sergi, docente dell’Università di Harvard, in un articolo pubblicato su The Diplomat, un fattore decisivo del successo della NASA nel Progetto Apollo non fu la concorrenza del libero mercato, bensì la leadership centralizzata dello Stato. La NASA supervisionò un processo integrato di ricerca, sviluppo, produzione e implementazione, con le aziende private largamente subordinate alla direzione statale.
Nella corsa all’intelligenza artificiale, la Cina sta seguendo una strategia simile. Come spiega Sergi:
“Dal ‘Piano per lo sviluppo della nuova generazione di intelligenza artificiale’ emanato dal Consiglio di Stato nel 2017, Pechino ha fissato traguardi espliciti per la leadership entro il 2030, sostenuti da ingenti investimenti in istituti di ricerca, programmi universitari e parchi industriali. Le università cinesi sono profondamente integrate nella ricerca applicata, registrano brevetti e collaborano con giganti tecnologici come Baidu, Alibaba, Tencent e Huawei per commercializzare le innovazioni. La Cina può mobilitare vaste infrastrutture, data center e procedure di approvazione snelle con una rapidità che qualsiasi Paese occidentale invidierebbe.
La Cina si sta inoltre proteggendo dai colli di bottiglia causati dai controlli statunitensi sulle esportazioni di semiconduttori avanzati, accelerando la produzione interna di chip. Huawei guida la produzione di nuovi chip per l’intelligenza artificiale e dei processori Ascend, con piani di fabbricazione dedicata e potenziamento su larga scala, soprattutto tramite SMIC. Alibaba e Baidu stanno sviluppando acceleratori di AI domestici per ridurre la dipendenza dalle importazioni.
Lo stesso spirito di direzione statale coordinata va ben oltre l’intelligenza artificiale. Con l’iniziativa Made in China 2025, lanciata nel 2015, lo Stato cinese ha identificato i settori tecnologici strategici nei quali effettuare investimenti decisivi e concentrare gli sforzi, per rafforzare la competitività e l’autonomia tecnologica dell’industria nazionale. Nel 2024, oltre l’86% degli obiettivi del programma Made in China 2025 risultava raggiunto, come testimoniano molti dei traguardi già menzionati.
Tutto ciò mette in luce un punto fondamentale: contrariamente a quanto sostengono i fautori del libero mercato, data l’enorme divisione del lavoro necessaria oggi per far avanzare le forze produttive e la scala dei progetti coinvolti, l’intervento statale centralizzato risulta di gran lunga più efficace del mercato nel promuovere l’innovazione tecnologica. Il PCC sta ora sfruttando questa capacità nel campo dell’intelligenza artificiale per rafforzare la propria posizione di potenza capitalista globale, in competizione diretta con l’Occidente, e con progressi indubbiamente rapidi.
Si tratta di un’economia pianificata?
È evidente che oggi lo Stato cinese è in grado di fissare obiettivi economici concreti e di orientare l’economia per raggiungerli. Vi è dunque un certo grado di pianificazione.
Alla luce di ciò, e del fatto che il Partito al potere è ancora nominalmente un partito comunista, che definisce il sistema economico cinese non come “capitalismo” ma come “socialismo con caratteristiche cinesi”, ci si potrebbe chiedere: la Cina di oggi è un’economia pianificata?
In un’economia pianificata e nazionalizzata, le attività economiche non sono mosse dagli stessi meccanismi del capitalismo. I settori chiave dell’industria sarebbero di proprietà statale, e la produzione sarebbe organizzata secondo un piano volto a soddisfare i bisogni della società nel suo insieme, anziché il profitto.
Di conseguenza, non esisterebbe più un mercato anarchico con le sue crisi di sovrapproduzione e i cicli di espansione e recessione. Naturalmente, un’economia pianificata sana richiederebbe un controllo operaio effettivo per evitare sprechi, cattiva gestione e corruzione.
In passato, la Cina ebbe un’economia pianificata nazionalizzata, sebbene priva di democrazia operaia e dominata dalla burocrazia. Essa produsse enormi risultati: liberò il Paese dal dominio imperialista e dall’arretratezza, e lo introdusse nell’era moderna.
Nei decenni successivi, però, molti tratti dell’economia pianificata vennero distrutti dallo stesso PCC. L’occupazione garantita, l’alloggio e l’assistenza sociale sono oggi solo un lontano ricordo. Sebbene permangano alcuni elementi di quel passato, come la proprietà statale di importanti leve economiche tutto in Cina, incluse le imprese statali, opera oggi principalmente in funzione del profitto e delle quote di mercato, non dei bisogni sociali.
Piani industriali come Made in China 2025 non sono dunque strumenti di pianificazione socialista, ma strategie per assicurare che i prodotti cinesi superino quelli delle imprese capitaliste straniere sul mercato mondiale. Questo è il punto fondamentale: nonostante il forte intervento statale, sono le pressioni del mercato e della redditività, i due pilastri di base del capitalismo, a determinare, in ultima analisi, il funzionamento dell’economia.
Anche se lo Stato può orientare l’economia verso i propri obiettivi, incentivando o disciplinando i capitalisti e sviluppando direttamente alcune tecnologie, la logica del mercato tende costantemente a minare o a modificare i risultati perseguiti dallo Stato. Ciò si manifesta spesso in forma di sovrapproduzione e conseguente deflazione, dovute all’afflusso massiccio di investimenti nei settori favoriti dal governo.
Questi fenomeni sono divenuti talmente diffusi che è stato coniato un termine specifico per descriverli: “involuzione” (neijuan), menzionato persino da Xi Jinping. Si tratta dell’effetto indesiderato di una concorrenza eccessiva nei settori privilegiati, in cui diventa estremamente difficile persino raggiungere il pareggio e tenere il passo con i rivali.
Talmente tanto capitale affluisce in questi comparti che persino le imprese più produttive non riescono a guadagnare quote di mercato, poiché i concorrenti fanno esattamente lo stesso. Il risultato sono guerre dei prezzi, orari di lavoro estenuanti e un’enorme sovrapproduzione. Questa tendenza è destinata ad accentuarsi con la nuova spinta della Cina verso i più avanzati progressi tecnologici a livello mondiale.
L’esempio più evidente di questa dinamica è la massiccia sovrapproduzione di automobili elettriche. Le politiche statali e i sussidi degli ultimi anni hanno favorito la rapida crescita di un gruppo di marchi automobilistici dotati di enormi capacità produttive, generando così un eccesso di offerta sul mercato. L’urgenza di vendere queste vetture ha innescato una caotica guerra dei prezzi, che sta costringendo le aziende a operare in perdita, aumentando e non riducendo la propria dipendenza dal sostegno statale. In tal modo, lo Stato è diventato vittima del proprio stesso successo.
In un’economia pianificata e nazionalizzata, tali industrie avrebbero potuto essere riconvertite immediatamente per soddisfare altri bisogni sociali. Ad esempio, queste fabbriche potrebbero essere facilmente riadattate per produrre apparecchiature elettroniche o informatiche destinate alle regioni più povere della Cina, a basso costo o gratuitamente, contribuendo così a ridurre le profonde disuguaglianze regionali.
Invece, tutto ciò che lo Stato può fare è regolare le politiche di sussidio dei governi locali e consentire il fallimento di alcune imprese. Si tratta di un processo tutt’altro che rapido e difficile da attuare anche per il governo centrale, nonostante il suo apparato potente.
Le case automobilistiche, per aggirare l’ordine statale di fermare i tagli ai prezzi e continuare la corsa alle vendite, stanno trovando soluzioni alternative, come il finanziamento a tasso zero per i clienti, la fornitura gratuita di traffico dati e altri incentivi simili. La China Automobile Dealers Association ha spiegato che, per ottenere risultati concreti, il PCC dovrà prepararsi a una battaglia di lungo periodo.
Tutti questi fenomeni fanno parte integrante dello sviluppo capitalistico. Non vi è nulla di “caratteristicamente cinese” in essi. Marx ed Engels scrissero ampiamente su come i nuovi settori industriali ad alto tasso di profitto tendano a essere inondati da investimenti, i quali finiscono poi per ridurre i margini di guadagno e provocare una crisi nel settore. Tale processo conduce a fallimenti e, in seguito, alla concentrazione del mercato nelle mani di pochi monopoli. In L’imperialismo, fase suprema del capitalismo, Lenin citava la seguente descrizione dell’imperialismo britannico dell’epoca:
“Ogni nuova impresa che vuole tenere il passo con i giganteschi complessi nati dalla concentrazione produrrebbe una quantità così enorme di merci in eccesso che potrebbe collocarle solo grazie a un’enorme crescita della domanda; altrimenti, questo surplus farebbe crollare i prezzi a un livello non redditizio, sia per la nuova impresa sia per i monopoli già esistenti.”
Queste parole si applicano perfettamente anche alla Cina capitalista di oggi. In definitiva, finché il sistema economico resterà fondato su un mercato anarchico, sulla produzione per il profitto, sullo Stato-nazione e sulla proprietà privata, nessuna regolamentazione statale potrà impedire l’inevitabile esito di una crisi di sovrapproduzione, oggi chiaramente visibile in Cina. Il PCC non dispone di alcuna soluzione o piano per questa contraddizione fondamentale.
I limiti del capitalismo
Nonostante la crescita straordinaria ottenuta grazie alla direzione statale, la Cina, come molte altre economie capitalistiche avanzate, sta registrando un rallentamento del tasso di crescita.
La crisi di Evergrande, che pesa fortemente sull’economia cinese nella quale il settore immobiliare riveste un ruolo centrale, ha contribuito a questo rallentamento. Sebbene l’intervento statale abbia evitato un crollo paragonabile a quello della crisi finanziaria del 2008, il problema del default di Evergrande persiste e potrebbe richiedere anni per essere risolto, ammesso che ciò sia possibile.
Allo stesso modo, mentre lo Stato tenta di frenare le guerre dei prezzi, le imprese private e i governi locali che le sostengono continuano ad aggirare le politiche centrali per proteggere i propri interessi e profitti a breve termine.
In assenza di un’economia pianificata, non esistono soluzioni semplici o rapide ai problemi derivanti dalle dinamiche anarchiche del mercato. Come in tutte le economie capitaliste del mondo, anche in Cina si è accumulata una quantità enorme di debito, sia privato sia pubblico. Alla fine del 2024, lo Stato cinese ha dovuto introdurre un vasto pacchetto di stimoli fiscali per sostenere i consumi e il mercato finanziario, aumentando ulteriormente il proprio fardello debitorio.
Per le masse, il costo della vita e la disoccupazione, in particolare tra i neolaureati, sono in costante aumento. La pressione sui giovani è particolarmente intensa, poiché l’invecchiamento della popolazione cinese comporta un crescente onere sulle generazioni più giovani, chiamate a occuparsi degli anziani.
I programmi sociali come l’assicurazione sociale (社保) e quella sanitaria (医保) sono sotto forte pressione, poiché sempre più persone non riescono a sostenere i pagamenti. Misure tipiche di austerità, come l’innalzamento dell’età pensionabile, sono in corso di attuazione, sebbene in modo molto graduale.
Sarebbe un errore equiparare l’attuale portata dell’austerità in Cina a quella dell’Occidente. La Cina si trova solo all’inizio di questo processo, mentre le classi dirigenti occidentali portano avanti attacchi simili contro i lavoratori da oltre due decenni, senza alcun segnale di inversione. Tuttavia, la Cina sta seguendo la stessa traiettoria, un esito inevitabile del capitalismo, dal quale nessuno Stato, per quanto potente, può sfuggire.
Alla base di tutto ciò vi è un persistente problema di sovrapproduzione massiccia. Il tasso complessivo di utilizzo della capacità industriale è oggi al 74 per cento, il livello più basso dal 2020. Nell’industria dei veicoli elettrici, dove il problema è particolarmente grave, la capacità utilizzata nel 2024 era solo del 49,5 per cento. Di conseguenza, la redditività è diminuita: la quota di imprese industriali in perdita è passata da circa il 10 per cento nel 2016 a circa il 20 per cento nel 2024.
Come già osservato, la sovrapproduzione interna sta alimentando una deflazione persistente e una riduzione della redditività. In ultima analisi, la Cina dovrà inondare il mercato globale con le proprie merci, una tendenza già in corso, oppure affrontare il collasso di molte imprese coinvolte in guerre dei prezzi, con la conseguente minaccia di milioni di posti di lavoro.
Prospettive della lotta di classe
Il dinamismo dell’economia cinese, in particolare del suo settore industriale, contrasta nettamente con l’economia statunitense, che tenta in modo disordinato di difendere la propria supremazia globale, e con quella europea, che appare chiaramente in declino.
Lo sviluppo imponente delle forze produttive in Cina genera inevitabilmente, tra le masse, l’impressione che la loro vita possa migliorare progressivamente sotto la guida del PCC. I media statali alimentano attivamente questa percezione, mostrando il peggioramento delle condizioni della classe lavoratrice in Occidente, spesso senza bisogno di ricorrere a menzogne o distorsioni.
La crescente aggressività degli Stati Uniti nei confronti della Cina, intensificata sia dall’amministrazione Biden sia da quella Trump, ha inoltre riportato alla memoria delle masse cinesi il periodo umiliante in cui il Paese fu spartito e dominato dagli imperialisti occidentali. Da ciò è naturalmente sorto un rinnovato sentimento anti-imperialista e anti-occidentale. Questo offre al PCC l’opportunità di rafforzare cinicamente il proprio consenso, alimentando la propaganda nazionalista.
Come influisce tutto ciò sulla coscienza di classe in Cina? Negli ultimi trent’anni, il Paese è stato completamente trasformato, e con esso la vita di centinaia di milioni di persone. In una sola generazione, molti sono passati dall’essere contadini poveri nei villaggi a operai industriali nelle città moderne, con standard di vita molto più elevati e la speranza che i propri figli possano vivere ancora meglio. Inoltre, la Cina appare oggi come una potenza forte sulla scena mondiale, capace di proiettare la propria influenza nei confronti dei rivali.
Anche se alcuni possono provare risentimento o criticare il PCC, la continua crescita economica e la percezione di ostilità da parte dell’Occidente possono contribuire a soffocare gli impulsi rivoluzionari, almeno finché il sistema appare in grado di mantenere le proprie promesse.
Tuttavia, la lotta di classe non si sviluppa mai in linea retta, né segue un rapporto meccanicamente inverso con la prosperità economica. Spesso, infatti, un certo grado di crescita economica rafforza la fiducia della classe lavoratrice nella possibilità di lottare per i propri interessi.
Come detto, la società capitalista cinese rimane attraversata da contraddizioni profonde, destinate periodicamente a esplodere in superficie. All’inizio di quest’anno, mentre BYD consolidava la propria posizione dominante nel mercato mondiale delle auto elettriche, migliaia di operai dell’azienda in Cina hanno intrapreso dure mobilitazioni contro i tagli salariali.
Altri episodi, come le proteste di massa a Pucheng (Shaanxi) in gennaio e a Jiangyou (Sichuan) in agosto, dove migliaia di persone si sono radunate contro la gestione burocratica di casi di bullismo scolastico, trasformando la protesta in una più ampia richiesta di diritti democratici, mostrano che il fermento dal basso è tutt’altro che scomparso. Esso esprime il desiderio delle masse di prendere il controllo del proprio destino e di resistere alla dittatura burocratica.
Ascesa in un mondo in declino
La Cina sta chiaramente avanzando sotto molti aspetti, sostituendo gradualmente la supremazia statunitense in vari campi nella competizione per i mercati globali. Anche se al momento è ancora lontana dal soppiantare gli Stati Uniti, in molti ambiti ha imparato a essere una migliore amministratrice del capitalismo rispetto all’Occidente.
Eppure, nonostante vada meglio dei suoi rivali, il capitalismo cinese sta crescendo in un momento in cui il capitalismo mondiale attraversa la crisi più grave della sua storia. La Cina può difendersi solo in parte dagli effetti delle crisi globali o dalla concorrenza dell’imperialismo statunitense, ma non può sottrarsi completamente alle dinamiche di crisi del sistema capitalistico mondiale. Un rallentamento economico internazionale finirà inevitabilmente per colpire anche la Cina in modo significativo. Né essa potrà eludere indefinitamente la crisi di sovrapproduzione interna.
Soprattutto, il proletariato cinese, che si è enormemente rafforzato insieme all’espansione dell’economia occupa oggi una posizione senza precedenti sulla scena mondiale. Prima o poi, il mondo rimarrà ancora più impressionato dal movimento della classe lavoratrice cinese di quanto non lo sia oggi per i suoi progressi tecnologici.
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.