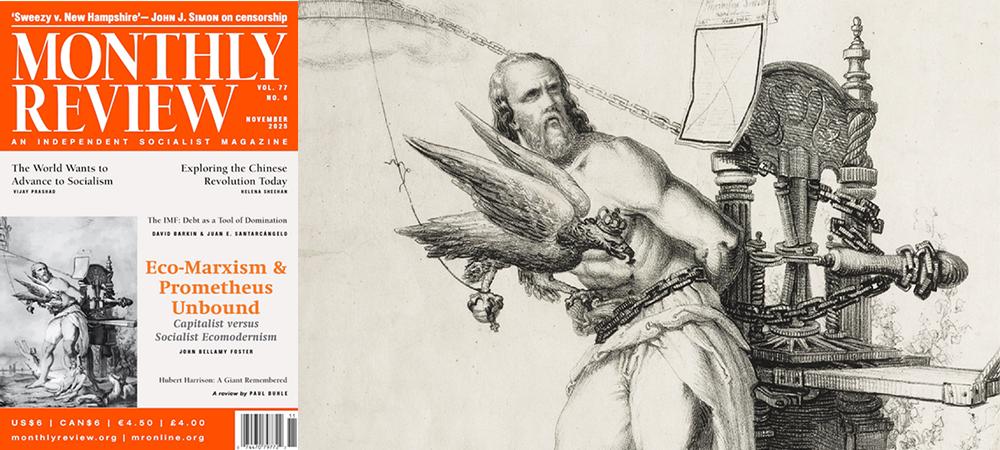Zone di sacrificio e territori in lotta: intervista a Paola Imperatore (I PARTE)
A pochi giorni dalla manifestazione del 10 maggio, che ha portato migliaia di valsusini nuovamente in marcia contro il deposito di smarino spostato da Salbertrand alla piana di Susa, ci teniamo a pubblicare in due puntate questa intervista alla ricercatrice Paola Imperatore.
da notav.info
Abbiamo invitato Paola all’assemblea che si è tenuta mercoledì 7 maggio al centro sociale Borgesa di Avigliana, a cui hanno partecipato istituzioni locali, comitati No Tav della bassa valle, il Coordinamento Pendolari Valsusa, docenti del liceo Norberto Rosa e tant* giovani che animano la vita politica della nostra Valle.
Ci sembrava importante condividere e sostanziare con tutt* una riflessione che da qualche tempo si sta discutendo all’interno del Movimento: i primi due cantieri stanno cominciando a mostrare le loro conseguenze disastrose sul nostro territorio, un terzo sta per essere installato e sarà potenzialmente il più impattante su tutto l’eco-sistema (ambientale, economico e sociale) valsusino. Vediamo sempre meno risorse stanziate per il nostro territorio, servizi basilari dal trasporto pubblico all’istruzione, dalla sanità alle opere per il dissesto idro-geologico, sempre più in difficoltà, il tutto per dirottare denaro su guerra e grandi infrastrutture che hanno funzioni “dual-use” (civile e militare).
La Val di Susa è stata eletta a zona di sacrificio in favore di una opera “strategica” (ma per chi?) e non importa quanta devastazione, impoverimento, disastri ambientali, perdita di biodiversità, salute, abbandono della propria terra dovrà costare al territorio e all* valsusin*, noi siamo solo un “prezzo che loro sono disposti a pagare” per il loro obiettivo.
Ribellarsi a questo destino già segnato è ciò che ci sta muovendo oggi a continuare una lotta trentennale e quella dello scorso sabato è solo la prima tappa di un percorso per continuare a liberarci da un colonizzatore interno e garantirci la possibilità di un futuro.
***********
Se ti va di iniziare cominciando a presentarti e posizionarti, così inquadriamo un po’ le tue ricerche e da dove si sviluppa il tuo punto di vista.
Sono una ricercatrice precaria all’Università di Pisa dove mi occupo di ecologia politica, ecologia operaia, e sono anche una militante; quindi, sono impegnata nel mio territorio nelle varie battaglie, come quella contro la base militare prevista nell’area del parco di San Rossore.
Da ormai una decina d’anni faccio ricerca nell’ambito di conflitti ambientali e territoriali. Sono partita da un evento più vicino a dove abito, l’alluvione che nel 2014 ha colpito Carrara, che ha fatto emergere il legame tra la distruzione del territorio, l’estrattivismo legato al settore lapideo nelle Alpi Apuane e gli effetti che poi si registravano a valle sulla comunità.

In quell’occasione ci fu una mobilitazione enorme che portò all’occupazione del Comune che durò per più di due mesi e che diede vita ad un’Assemblea Permanente. In quel caso, quello che mi colpì molto fu vedere come quel meccanismo di devastazione avesse innescato un processo comunitario molto forte, senza precedenti. In generale, mi incuriosiva la capacità di aprire intorno alla difesa del territorio uno spazio politico nuovo.
A partire da questa esperienza, ho continuato a fare ricerche sui conflitti territoriali e ho avuto un po’ la fortuna e l’occasione di incontrare territori e lotte differenti: da quelle contro gasdotti come Tap e Rete Adriatica, a quelle contro le Grandi Navi, il Muos, il Terzo Valico, l’estrazione intensiva di marmo. Allargare lo sguardo a quello che succedeva lungo tutto lo stivale mi fede anche rendere conto che alcune dinamiche di sfruttamento non sono eccezionali, ma ordinarie e strutturali, e che d’altra parte era necessario approfondire in modo altrettanto strutturale anche il lato della contestazione e quello che da essa poteva nascere.
Partiremmo con la prima domanda che un po’ ci interessa approfondire, per poi arrivare sulla parte che ci tocca più da vicino alla lotta in Val di Susa. Che cos’è una zona di sacrificio, quali sono le sue caratteristiche e quali sono i meccanismi che portano un territorio a trasformarsi ed a essere eletto in quanto tale?
La definizione proviene dagli Stati Uniti e dal gergo burocratico-militare che definì Zone di Sacrificio Nazionale quelle aree del Paese che venivano individuate per depositare le scorie radioattive legate ai test nucleari. Quindi, già nella sua origine, pur venendo dall’alto come concetto, emerge subito la dimensione di sacrificio per alcuni luoghi considerati di serie B. Negli ultimi anni questo concetto è stato recuperato dal basso, dai movimenti sociali e dall’ecologia politica per identificare territori e comunità di scarto che in qualche modo vengono definite sacrificabili in nome di un presunto interesse collettivo.
La domanda interessante è, non solo cosa denota il concetto di zona di sacrificio, ma anche come si diventa una zona di sacrificio e quali processi innescano questa dinamica centro-periferia che ha tante forme e che dà luogo a una geografia del potere che non è granitica ma che si muove continuamente secondo linee di potere. Se storicamente il rapporto gerarchico tra centro e periferia si innestava nella frattura tra paese colonizzatore/colonie e in quella città/campagna, credo che la violenta ondata di mercificazione del vivente sostenuta dalle politiche neoliberiste degli anni Novanta abbia moltiplicato in modo significativo il numero di territori e comunità divenute sacrificabili, mettendo in evidenza come la periferia non sia tanto una delimitazione geografica quanto una condizione di marginalità che tocca da vicino anche le nostre vite.
Quando si pensa alle zone di sacrificio, si pensa a quei territori che vengono ritenuti ricattabili, poveri, a basso costo, competitivi e convenienti per il capitale. La competitività proviene dal fatto che i costi della terra, i costi fondiari, siano bassi, che si possa reclutare manodopera a basso costo e che si possa contare su istituzioni con scarso potere di negoziazione. Inoltre, molto spesso, una delle scommesse di chi investe nei territori marginali – o meglio, resi marginali – è quella di non incontrare resistenza. Questa è una cosa molto interessante perché, prima di essere presentati e messi in atto, molti dei progetti che vengono valutati e stimati dalle imprese, sono stimati anche in base al rischio di eventuali contestazioni (per esempio furono proprio questi criteri che mossero la scelta di Melendugno in Puglia per posizionare TAP).

Da questo punto di vista è però importante notare che tante volte queste valutazioni sono errate, perch non tengono conto delle capacità di reazione delle comunità e dei territori, e della loro attitudine a mettersi in moto quando le proprie condizioni di vita e sopravvivenza vengono minacciate.
Questi sono sicuramente elementi di contorno che le aziende e le istituzioni valutano quando scelgono chi può essere sacrificato, ma ce ne sono anche altri: quali vite, quali comunità contano di meno dentro la scala del valore capitalista? A tal proposito, mi viene in mente una riflessione di Razmig Keucheyan1, un sociologo francese, sul razzismo ambientale. Lui partiva un po’ dal fatto – emerso grazie alle mobilitazioni delle persone razzializzate – che negli Stati Uniti la maggior parte delle discariche di rifiuti chimici e tossici fossero localizzate vicino ad aree abitate da persone nere. Nello spiegare questo meccanismo cercava di mettere in chiaro un elemento: non è che un’azienda individua una comunità di persone nere o – traslando il discorso all’Italia – una comunità di persone meridionali o persone povere e decide di conseguenza di andare lì. Semplicemente il mercato ha un meccanismo molto razionale di allocazione delle risorse e sceglie di andare dove i prezzi sono più bassi. Il punto è che la presenza, in quei territori, di alcune categorie inferiorizzate fa sì che il prezzo di quelle terre e quegli immobili sia più basso, che valga meno, rendendo competitivo per il mercato investire lì. Questo evidenzia la dinamica di sedimentazione spaziale delle diseguaglianze, ovvero come la discriminazione agisce su scala spaziale aumentando i margini di accumulazione del capitale.
Quello che poi caratterizza la zona in sacrificio è la logica di scambio ecologico ineguale. Il modello estrattivista regge sullo strutturale processo di estrazione di risorse, manodopera e natura da territori considerati inferiori verso i centri economici e finanziari. Questo è un meccanismo che va messo bene a fuoco perché ci aiuta a capire quando viene riprodotto anche in chiave green o con retoriche diverse.
Concentrarsi su cosa si produce è necessario ma non sufficiente. Sicuramente ci sono un produzioni o infrastrutture problematiche di per sé, ma anche quando non sono immediatamente e chiaramente problematiche dobbiamo capire entro quale meccanismo si iscrivono e quindi quale logica vanno ad asservire e assecondare.
Per concludere, quindi, in questo senso ciò che caratterizza la zona in sacrificio è l’elemento di costante inferiorità rispetto ai centri economici e finanziari che determinano quel flusso e quella logica.
Secondo te, i processi di industrializzazione quanto sono contati in passato nell’elezione di alcuni territori a zone di sacrificio e quanto contano al giorno d’oggi in questo sistema nuovi processi come, ad esempio, la transizione energetica?
Pur concentrandomi negli anni in particolare sui processi che si sono innescati con il neoliberismo e con la globalizzazione, di sicuro, puntando lo sguardo al Novecento, ci si rende conto che il polo industriale è un po’ la cifra del modello di sviluppo di quel secolo: in qualche modo intorno a questo si sono innescate delle trasformazioni, dei meccanismi e dei processi che successivamente abbiamo conosciuto anche noi e che hanno portato a delle impasse in cui siamo ancora oggi impantanati. Penso all’Ilva, ma anche a tantissimi poli petrolchimici o altre industrie con le quali abbiamo difficoltà a trovare delle forme di fuoriuscita dal ricatto strutturale.
Guardando invece dagli anni Novanta ad oggi – e il TAV in Valsusa ha fatto un po’ da preludio a quello che poi sarebbe successo altrove – la grande opera è diventata a mio avviso il principale meccanismo di accumulazione del capitale: una volta cambiata e riorganizzata lacatena del valore su scala globale, i territori a quel punto dovevano fungere da supporto economico alla globalizzazione, quindi in qualche modo funzionare da anelli di questa catena economica globale che aveva bisogno sempre di più di linee di trasporto ad alta velocità, hub del gas e tutta un’altra serie di infrastrutture che oggi sono pensate, progettate su scala globale e che rispondono a esigenze di un mercato finanziario su scala mondiale. Tanto intorno al TAV quanto intorno a TAP gli interessi in gioco non possono assolutamente essere circoscritti né al territorio né al contesto nazionale, ma chiamano in causa tutta un’altra serie di soggetti, di attività, di strategie speculative.
Quando parliamo di grande opera parliamo di qualcosa di molto specifico. Non parliamo di un’infrastruttura che è grande, ma parliamo di un paradigma ben preciso che ha delle caratteristiche e che è totalmente disgiunto e dissociato dalla dimensione sociale. I movimenti popolari ed ecologisti negli anni hanno lottato per avere delle infrastrutture, quindi è fazioso trattare i movimenti contro le grandi opere come movimenti che si oppongono all’esistenza di infrastrutture e al progresso. Al centro della discussione c’è un’altra questione, ovvero: “questa infrastruttura a chi serve? per quale motivo la facciamo? a quale bisogno risponde?”, ed è questo che in qualche modo i movimenti hanno messo in evidenza negli ultimi anni nel contestare la grande opera appunto come paradigma di governo dei territori.

Da un lato la grande opera risponde alle logiche di trasformazione del capitalismo su scala globale, dall’altro agisce su una serie di assi che consentono in qualche modo a questo meccanismo di stare in piedi e di riprodursi.
Il primo è la socializzazione dei costi e la privatizzazione dei profitti che è un elemento che abbiamo visto essere ricorrente ma anche strutturale, nel senso che la maggior parte degli investimenti in grandi opere non avrebbero senso di esistere, non sarebbero mai promossi da nessuno se non ci fosse la possibilità sistematica di scaricare tutti i costi sociali, ambientali e sanitari verso il basso e incassare solo i profitti. Questo aiuta anche a capire per quale motivo si aprono cantieri che non terminano mai: il vero obiettivo è mettere in moto un meccanismo di spartizione economica e non raggiungere un fine che potrebbe essere contestato ma quantomeno chiaro.
Il secondo elemento è l’imposizione di un regime di eccezionalità nel governo dei territori. Questa condizione, se nei primi anni si è in qualche modo manifestata come una conseguenza della grande opera, in quanto, di fronte all’incapacità di gestire il conflitto e le contestazioni, le istituzioni e i capitali si riorganizzavano creando un’impalcatura straordinaria di governo per annientare la protesta, in un secondo momento questo regime di eccezionalità da conseguenza è diventato condizione della grande opera. Oggi, in qualche modo, chi sostiene questo paradigma di distruzione e sviluppo, si prepara le carte in tavola facendo del regime di eccezionalità unmodello ordinario di governo dei territori. Questo, ad esempio, lo stiamo vedendo tantissimo anche con il Ponte sullo stretto di Messina, dove tutta una serie di dispositivi di militarizzazione, controllo e repressione sono stati disposti in maniera preventiva, ma lo vediamoanche nel lento, graduale ed inesorabile processo di svuotamento dei processi democratici attraverso decreti di semplificazione, decreti sicurezza, decreti sblocca cantieri, e così via, che, uno per uno, hanno cercato di smontare tutta l’impalcatura di norme che erano state frutto delle lotte e che senza altro erano insufficienti, ma che comunque garantivano degli spazi di partecipazione della società alle decisioni.
Il terzo asse su cui si fonda il paradigma grande opere è l’utilizzo di un modello coloniale di rapporto ai territori che si rivela sia nel modo in cui vengono narrate le contestazioni delle persone che si oppongono, sia nella militarizzazione, che è l’espressione più esplicita di un controllo su una colonia che non risponde all’autorità centrale. Si tratta di un meccanismo che evidenza il volto più violento del sistema capitalista sorretto dalle istituzioni e che appoggia su una modalità di narrazione delegittimante, che agisce in modo costante a screditare chi si oppone.
Ritorno al tema del Ponte sullo Stretto per fare un esempio: una delle tante pagine Facebook che fanno propaganda pro-ponte ha creato una grafica in cui fa vedere tutte le città (secondo loro evolute) con un ponte e poi rappresenta Messina con il volto di una scimmia, associando gli autoctoni ad un atteggiamento primitivo, come fatto anche dal Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini in visita a Messina. Vediamo quindi questo tentativo costante di ricodificare le opposizioni secondo il linguaggio coloniale del progresso.
Oggi la grande opera è esattamente questo meccanismo che trova nell’interesse strategico nazionale la saldatura tra l’interesse del capitale e l’interesse dello Stato-Nazione. Mi sembra importante evidenziare un’altra cosa: la grande opera è un po’ la cifra del neoliberismo e quindi anche del mercato globale. Per quanto la globalizzazione ci sia stata raccontata come la fase in cui i confini andavano a erodersi, stiamo vedendo un affermarsi violentissimo degli stati-nazione e dei confini, e le grandi opere che dovevano servire i flussi economici globale sono improvvisamente divenute anche strategiche in ambito militare.
Credo che questo sia un esito in qualche modo naturale del neoliberismo. Il punto, secondo me, è avere una politica delle infrastrutture che sia vincolata ai valori etici e sociali di una comunità. Nel momento in cui questi due elementi – infrastruttura e comunità – non vannoinsieme, l’infrastruttura diventa uno strumento di violenza che agisce e trasforma il territorio, spesso anche in modo irreversibile, ridisegnando completamente la geografia sociale ed ecologica di un territorio.
————————————————————————————————————————————————————————————————-
- Nato il 20 novembre 1975, è un sociologofranco-svizzero e attivista della sinistra radicale, professore all’Università Paris-Descartes. Si interessa tra le altre cose, al problema dell’ecologia e dimostra che la crisi ecologica non è indipendente dalle questioni e dalle lotte politiche. Sottolinea che le conseguenze ambientali dovute all’attività umana colpiscono in primo luogo le popolazioni e le classi dominate. Secondo lui, le opposizioni di classe non dovrebbero essere ignorate quando si affronta la questione dell’ambiente. In numerosi discorsi e forum sviluppa e analizza il fenomeno che chiama “razzismo ambientale”. Partendo da situazioni edificanti come la decisione, presa nel 1982, di installare una discarica di rifiuti tossici nella contea di Warren ( Carolina del Nord ), popolata in gran parte da neri poveri, Razmig Keucheyan mostra come «la distribuzione delle popolazioni più vulnerabili debba essere correlata alla divisione razzista dello spazio fisico, ma anche ai rapporti di potere di genere e alla distribuzione del danno ecologico contemporaneo (industrie tossiche, riserve di rifiuti, ecc.)» Reportage di Jérôme Lamy e Arnaud Saint-Martin sul sito ZILSEL: “ L’État, la nature et le capital : le triptyque infernal. Compte rendu et entretien flash avec Razmig Keucheyan”, 21 giugno 2014.
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.
CRISI CLIMATICAdevastazione ambientaleno tavPaola Imperatoreval di susazone di sacrificio