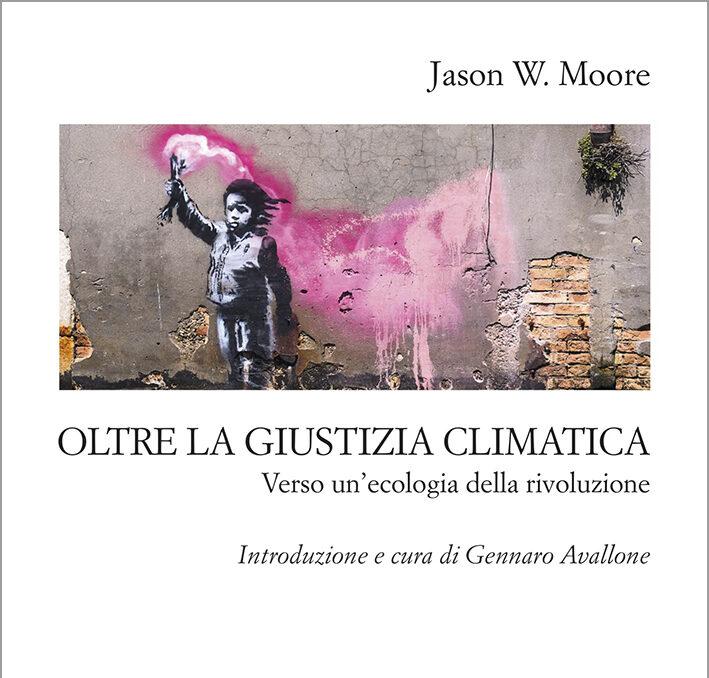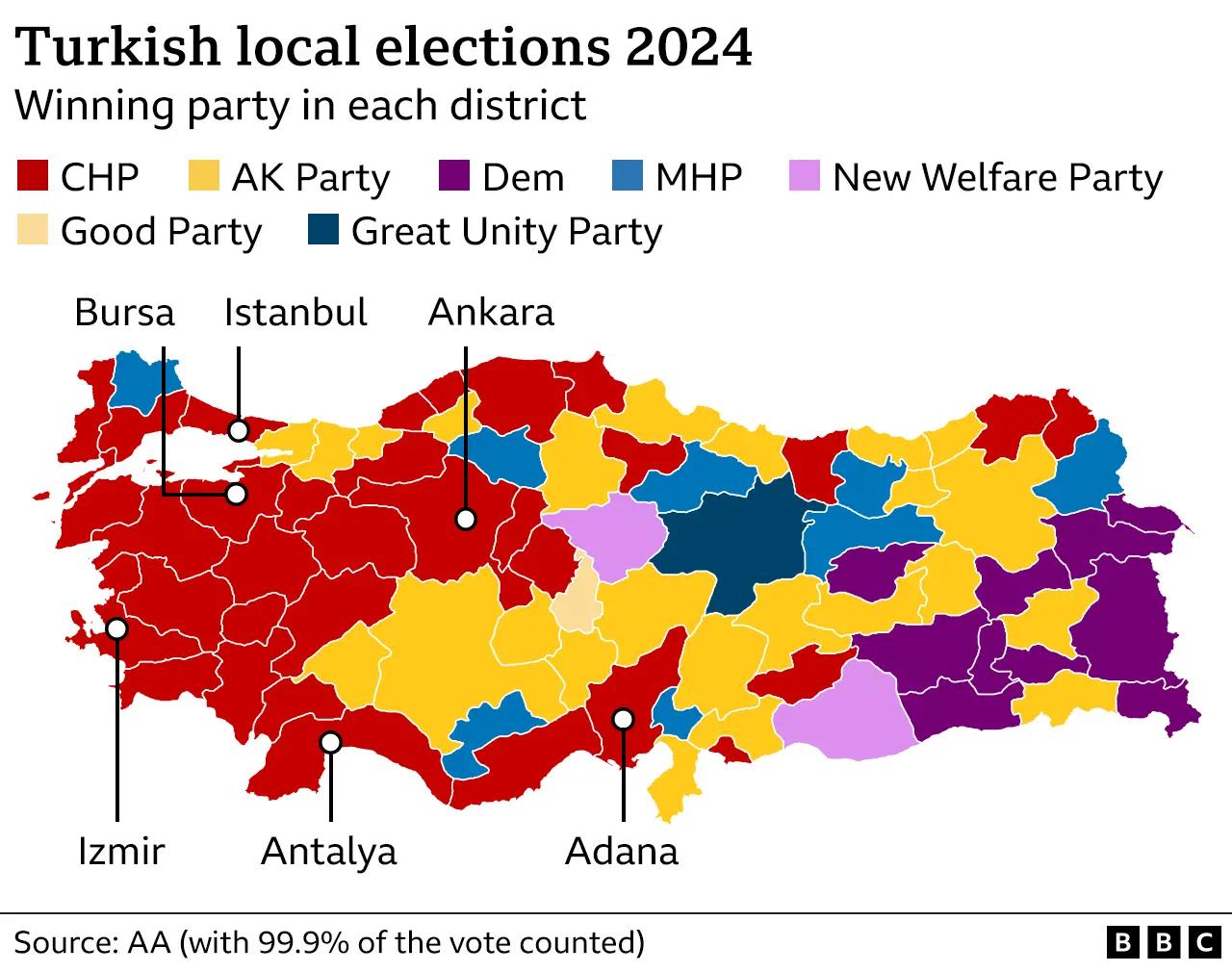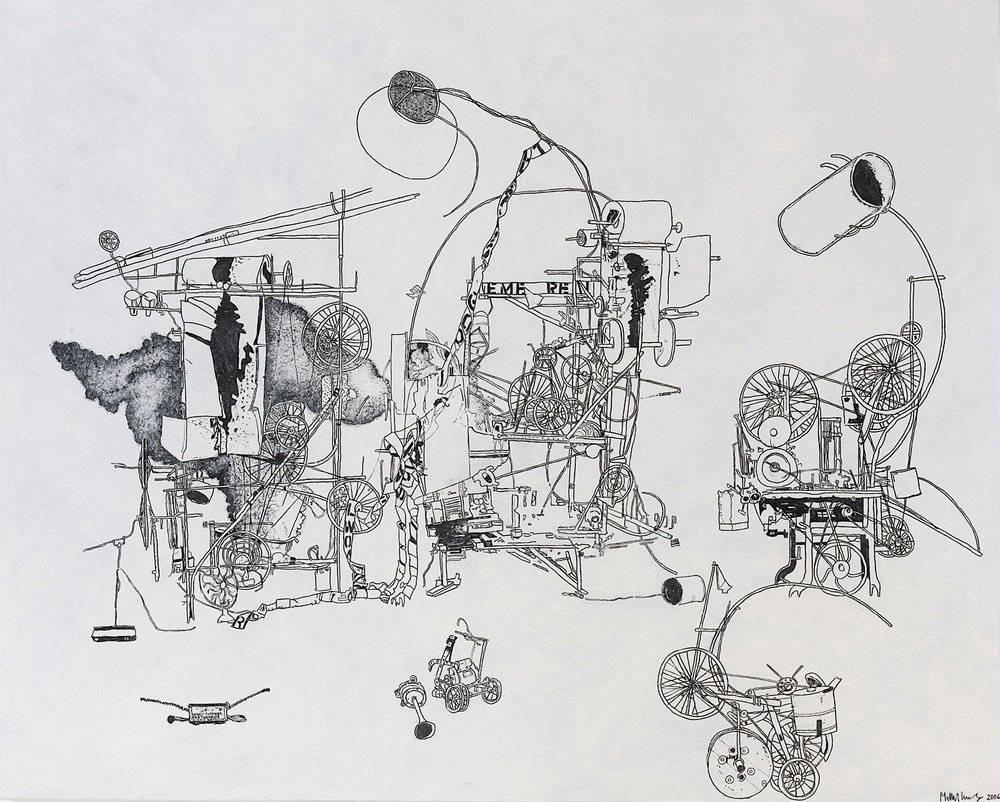Bruciare Abitare Pensare

« Agire da primitivo e prevedere da stratega »
1. Ogni teoria della rivoluzione è un bilancio delle sue sconfitte. Ecco cosa traspare delle prime pagine di Ai nostri amici, e distingue questo libro, nonostante la continuità di stile e obiettivi, da L’insurrezione che viene. Se in quest’ultimo, per parafrasare Il 18 brumaio, la fraseologia anticipava profeticamente il contenuto, ora è il contenuto a sorpassare la fraseologia. L’insurrezione è arrivata ed è stata sconfitta. E nonostante ciò, continua a venire. Ma l’ordine delle priorità è mutato, la poesia di un avvenire imminente fa sempre più spazio alla prosa del passato recente. Siamo stati vinti. Ma siamo ovunque. La stabilità è morta. Il capitalismo si sta disgregando. E tuttavia si riproduce – come catastrofe permanente.
2. La tendenza non è tanto quella di una lenta impazienza, piuttosto il suo contrario, una pazienza che si affretta, la distillazione di un orizzonte planetario nell’azione in situ, liberata da ogni appuntamento con la storia, da ogni incontro provvidenziale con la traiettoria del capitalismo. Una teoria della rivoluzione dovrebbe contemporaneamente ritrarre la congiuntura, sondare la tendenza di fondo, dare un nome ai nemici, raccogliere gli amici. “Chi sono i nostri nemici? Chi sono i nostri amici?” – queste sono le prime righe del primo volume delle Opere scelte di Mao Zedong. Sin dal titolo, questa domanda “classica” risuona in tutto il libro, Ai nostri amici. Ma è esattamente attraverso questo “noi”, ciò che il linguista Roman Jakobson chiama efficacemente commutatore (shifter) – un elemento del discorso il cui referente non può essere stabilito che a partire dal contesto del messaggio – che questo appello si rivela meno univoco di quanto possa sembrare in prima battuta.
3. Ciò non è tanto il frutto dell’anonimato imperfetto degli autori. Prendere misura della contro-rivoluzione esige uno sforzo di riflessività che relega in secondo piano la supremazia dei nemici, per preferire un esame delle debolezze delle “nostre” forze. L’impressione iniziale è quindi quella di un’auto-critica particolarmente benvenuta. Ma uno scarto decisivo si allarga tra il “noi” che ha fallito e il “noi” che ha scritto. L’automatismo politico della crisi, per esempio – associato qui, come ci si può aspettare, al facile immaginario d’un marxismo apocalittico – non poteva certo essere attribuito alla precedente professione di fede comunista del Comitato. Uno dei leimotivs più caustici de L’insurrezione che viene era l’idea che ciò che “ci” blocca sia la resilienza ostinata della “Sinistra”, intesa come un unico habitus di militanza condiviso tanto dai leninisti che dai social-democratici, gli anarchici e gli “indignados”. Allo stesso modo, quando attaccano tutto il repertorio dell’antagonismo consensuale, dell’human mic all’agitare le mani in aria in segno di approvazione, non sembrerebbe che gli autori, per parafrasare il poema di Fortini “Traducendo Brecht”, iscrivano i propri nomi nella lista dei nemici. E forse non potrebbero farlo, senza disturbare la retorica della secessione e dell’autenticità che impregna il loro testo.
4. Visto il considerevole talento del Comitato per l’intervento polemico e gli exploit devastanti di Kulturkritik, è un peccato che un po’ di autocontrollo non sia esercitato anche in materia di stile, anch’esso un affare politico. Il congedo finale, in versi, che sembra quasi presentare delle scuse per la vivace analisi che lo precede, ne è un esempio lampante. Per non parlare di dichiarazioni fastidiosamente pompose come “Il nostro margine d’azione è infinito. La vita storica ci tende le braccia” (p. 17). “Noi” non siamo certo dappertutto a cospirare, checché ne dicano speranzosamente gli autori. È con un eccesso di fiducia – e in contraddizione con la sua analisi della nostra epoca come colpita da un’indicibile degradazione metafisica e antropologica – che Ai nostri amici crede di vedere la saggezza popolare del momento condensarsi nel detto argentino ¡Que se vayan todos!. Questo è vero ma solo nella misura in cui il disprezzo per chi ci governa è anche una proprietà della destra, che lo maneggia con molta più destrezza del Partito dell’Uguaglianza. Allo stesso modo è una forzatura proiettare su Occupy Wall Street – un movimento le cui incursioni nel campo della rivoluzione della vita quotidiana si sono dimostrate relativamente timide – il “disgusto” per la vita di oggi. Non sarebbe più utile, al di là delle epifanie esistenziali che potrebbero coglierci all’interno dei nostri gruppi in fusione, misurare quanto i sollevamenti recenti hanno poco « rivoluzionato » le abitudini e le menti? Aderire a un partito comunista ai tempi di Stalin dava luogo senza dubbio a dei cambiamenti interiori incomparabili con quelli suscitati dalla partecipazione alle sollevazioni di oggi le quali, nel bene come nel male, richiedono di gran lunga meno in termini di de- e ri-soggettivazione.
5. Per farla finita con l’eredità delle filosofie della storia e le illusioni progressiste, Ai nostri amici ci intima di rifiutare d’interpellare la crisi economica. L’idea sottogiacente non è però quella di un nominalismo familiare nel quale la “crisi” non è più che un’astrazione illegittima proiettata sulla molteplicità reale della vita sociale. Non solo si afferma enfaticamente che gli eventi che hanno avuto luogo dal 2007 sono appartenenti a una stessa “sequenza”, “un’unica ondata mondiale di sollevazioni che comunicano impercettibilmente fra loro” (p. 6 – NdT. Tutte le citazioni sono riprese dall’edizione italiana disponibile su http://ainostriamici.noblogs.org/); l’insurrezione stessa diventa qui una sorta di totalità espressiva: ogni sollevazione individuale ha “immediatamente qualcosa di mondiale” (p. 6). Dalla Libia all’Ucraina, dalla Tunisia a Wall Street, da Notre-Dame-des-Landes a Oakland, il Comitato Invisibile si mostra estremamente inclusivo per quanto riguarda i siti dell’antagonismo contemporaneo, di ciò che cerca di far apparire come un unico (anche se non ancora unificato) processo rivoluzionario. Ma questo insieme d’insurrezioni non è l’espressione e nemmeno la risposta a una crisi capitalistica. In realtà, il discorso dominante sulla crisi, con la sua evocazione di un processo ingovernabile, non sarebbe altro che un’astuzia di governo. Ecco perché, in ultima analisi “Non c’è una “crisi” da cui bisognerebbe uscire. C’è una guerra che bisogna vincere” (p. 7). L’assenza di “punti” di crisi, l’esperienza quotidiana di una crisi senza fine – allo stesso tempo imposta e smentita dal potere -, è trasmutata in queste pagine in un orizzonte di negazione totale. Se le crisi (finanziarie, politiche) non sono puramente e semplicemente messe da parte, esse non sarebbero in fondo che degli epifenomeni di una crisi propriamente di civiltà, metafisica. Una crisi della presenza. Volendo suonare paradossali potremmo dire che ciò che unisce questa sequenza di rivolte, ciò che ne costituisce la storicità, sembrerebbe essere il fatto che esse non pongono più il problema di una discontinuità nella storia, quanto di una discontinuità dalla storia, la storia dell’Occidente. La lettura di Ai nostri amici lascia l’impressione tenace che il testo chieda la nostra affinità, il nostro assenso. Non sono avanzate (né potrebbero esserlo) argomentazioni o analisi che giustificherebbero il sorpasso di crisi ontiche con una vera e propria crisi ontologica, e se l’ontalagia (per prendere in prestito il neologismo di Raymond Queneau) che traspira da frasi come “abbiamo perso il mondo” vi sembra ostile o incomprensibile, vorrà dire che avete raggiunto i limiti della vostra capacità di cospirare (di respirare con) – e quindi, probabilmente, non siete davvero un amico. La matrice di un anti-capitalismo romantico è inamovibile, per quanto possa essere eclissata da un agonismo assiomatico (secondo cui la “guerra civile” è inesorabile, e il tentativo di evitarlo allo stesso tempo vano e debilitante). La vera vita, la lotta contro la “civilizzazione dell’alienazione”, la perdita del mondo – ecco le parole d’ordine del Comitato Invisibile. Forse l’allergia alle esortazioni all’autenticità che costellano Ai nostri amici non sono altro che il sintomo della condizione di “Occidentale” (categoria che, se dovessimo credere a una dubbia osservazione degli autori, sarebbe indifferente al colore, p. 15), incapace di lanciarsi nella “guerra” dei “terrestri” contro l’Uomo (p. 15). Queste parole hanno una forte risonanza heideggeriana-di-sinistra, che il riferimento a World war z (p. 20) non fa che accentuare. Gli autori possono anche parlare della “catastrofe che noi siamo” (p. 13), ciò non è che un preludio a una diserzione troppo speditiva. In questo addio rabbioso a secoli di pensiero metafisico, gli autori rischiano di portarsi dietro più macerie umanistiche di quanto non immaginino. La “presenza”, cosa c’è di più cristiano?
6. È un peccato che il termine “vita”, eterno contenitore di pseudo-concretezza e di falsa immediatezza, non sia stato maneggiato in queste pagine con la stessa circospezione dell’infrastruttura quotidiana del tardo capitalismo, dal TAV agli iPad. Senza dubbio non si può fare uso impunemente di questi ultimi, ma neppure attingere a piene mani al serbatoio della filosofia della vita e del vitalismo senza seminare una confusione che nessuno può permettersi oggi. La vita non offre nulla da celebrare, e il calcolo, in quanto tale, niente da condannare. Questa posizione non è che l’altra faccia della reificazione, il suo prodotto e il suo complemento. Ai nostri amici, visto che si appoggia su una teoria insurrezionale della sconfitta è un testo ben più sobrio che L’insurrezione che viene, ed è tanto meglio. Nonostante questo, gli autori continuano a raccontarsi storie su cui devono ben avere dei dubbi in fondo. Ciò che forse non vedono è quanto tutto ciò sia simile a quel radicalismo contemporaneo che aborrono, incapace di suscitare entusiasmo senza la falsa nota dell’esortazione. Oggi i testi più deprimenti sono spesso anche quelli più euforici.
7. Mi sembra necessario sottolineare questa distanza rispetto alle posizioni e alla poetica di Ai nostri amici per meglio trattare la questione centrale del libro, quella dell’organizzazione intesa come percezione comune (p. 7). Non si critica certo un manifesto o un appello, soprattutto quando non è destinato a te; ciononostante si può fare qualcosa dei momenti di assenso e dissenso che suscitano tali affermazioni. Ora, anche se l’essenziale di questa percezione non è condivisa, siamo senza dubbio d’accordo sui termini della questione: che cosa significherebbe il forgiare una percezione comune? Per il Comitato Invisibile, l’organizzazione che mancava alle insurrezioni del 2011 e degli anni seguenti non è quindi un partito, un sindacato o una forza armata ma una percezione (il Comitato non riconoscerebbe volentieri la somiglianza ma su questo punto la distanza non è poi tanto grande rispetto alla traduzione dell’organizzazione in idea che fa Badiou o, su un altro registro, con la cartografia cognitiva di Jameson – due versioni della coscienza di classe senza classe). Una percezione comune, ecco le nozze dell’etica e della strategia. È difficile non sentire l’eco dell’ultimo sconfitto Debord, che scopre attraverso le lenti di Clausewitz la riproduzione cospiratoria dello spettacolo (nei Commenti) e che ne misura i danni causati alla vita e all’ethos (nel Panegirico). Ma, contrariamente a quella di Debord, la negatività di Ai nostri amici è più epidermica. Perché scrivere altrimenti una frase così disarmante come “l’intelligenza strategica viene dal cuore” (p. 7) ? Questo desiderio di una vita altra è più profetico che dialettico. In compenso, le prospettive arche-politiche di una rivolta etica globale rischiano di sommergere ogni considerazione strategica, ogni taratura tattica. “Quello che è in gioco nelle insurrezioni contemporanee è la domanda di sapere che cos’è una forma desiderabile della vita, e non la natura delle istituzioni che la dominano. Ma riconoscerlo implicherebbe immediatamente di riconoscere la nullità etica dell’Occidente” (p. 21). Di sicuro una forma di vita non può essere strappata alle sue istituzioni, a meno di non finire nell’immediatezza vitalistica che è sempre stata la grande tentazione dell’anticapitalismo romantico. E se “l’Occidente” (qualunque cosa esso sia) non è che un grande vuoto dal punto di vista etico, bisognerà premunirsi dal rischio di riattivare un discorso politico e filosofico che prende in prestito non solo grosse parti di una grammatica e un’etica distintamente occidentali, ma che rifiuta in più di sottometterle a una negazione decisa. Opporre la “verità etica” (p. 21) alla democrazia – non è forse anch’esso un concetto “occidentale”? (È ciò che suggerisce, per esempio, una seducente opera di Eduardo Viveiros de Castro, The Inconstancy of the Indian Soul). Ed è precisamente nella misura in cui le insurrezioni attuali non hanno, tranne che di sfuggita, dato luogo a nuove istituzioni che hanno lasciato la vita nuova allo stato del desiderio, ossia, della mancanza.
8. Così quest’ “altra idea della vita” (p. 22), rischia di restare nient’altro che un’idea, della felicità e della buona vita, astratta quanto quella del comunismo. Forse non abbiamo perso il mondo ma ciò che è certo è che abbiamo perso molta dell’economia morale suscettibile di dare presa a un’opposizione etica. Ecco perché stupisce che la questione del come produrre, inventare, fare esperienza di altri modi di vita, riceva relativamente poca attenzione in queste pagine – al di là delle multiple indicazioni di luoghi dove quest’altra vita potrebbe essere faticosamente costruita (nella lotta contro la linea ad alta velocità Torino-Lione, in val di Susa; in quella contro l’Aeroporto del Grand-Ouest, à Notre-Dame-des-Landes, etc.). Troppo rapidi nell’incorporare la negatività generale al loro progetto, Ai nostri amici afferma che la denuncia ricorrente della “corruzione” è rivelatrice di questa svolta etica dell’antagonismo (p.22). Però, come lo ricorda il provocante discorso contro l’etichetta di “indignato” derivato dallo spagnolo indignado (“Egli postula la propria impotenza, in modo da potersi meglio sottrarre a ogni responsabilità circa il corso delle cose; poi la converte in affetto morale, in affetto di superiorità morale. Crede di avere dei diritti, il poveretto.” p. 24), ciò potrebbe essere una sorta di esorcismo un modo di chiamare “noi stessi” fuori dalla decadenza morale e finanziaria del presente, di adottare la postura della semplice vittima.
9. Ma qualcosa di più preciso e più grave si gioca in queste pagine, mentre distillano con acume combattivo ciò che è al cuore della critica insurrezionalista al movimento delle piazze: la critica del feticcio della democrazia. Alcuni passaggi sono di una forza rinvigorente, come quando il Comitato ci ricorda che “popolare” viene da populor, “devastare, distruggere” (p. 23), che un sollevamento è una pienezza di espressione e un nulla di deliberazione. Il disprezzo in cui è tenuto quest’ultimo termine (al quale si sostituisce la comunicazione non-strumentale dell’amicizia, con degli accenti che ricordano Maurice Blanchot) indica l’aspirazione, al di là dell’indeterminazione illusoria della prima persona plurale, a dividere il “noi” tra il distacco antagonista da un parte e un’impasse piccolo-borghese dall’altra. Indubbiamente, nella misura in cui la filosofia spontanea del “movimento delle piazze” è, nei suoi momenti di non-scontro, largamente “democratica”, ciò crea le condizioni per un’altra “guerra civile”, una lotta tra differenti nozioni del popolare. È un peccato che Ai nostri amici decida di castigare Hardt e Negri, o Hessel, o ancora il senso comune politico delle “assemblee”, piuttosto di affrontare le vere strade politiche prese dal riformismo radicale contemporaneo, come Syriza o Podemos. Perché, in fin dei conti, sono questi i suoi veri nemici, visto che impongono una strategia politica, fondata sulla democrazia e la deliberazione, che non può che fare da ostacolo allo sbocciare dell’altra vita, all’irruzione della vita etica. In effetti, dal punto di vista del Comitato, come potrebbe un tale incanalamento del rifiuto in progetto di potere significare altro che un disastro? La piazza si è divisa in due? Da una parte “il crash sul reale del fantasma cibernetico di una cittadinanza universale”, dall’altra “un eccezionale momento di incontri” (p. 25). Il pragmatismo pedante e “micro-burocratico” sia esso trotskista o anarchico contro i partigiani della rivolta etica. La fenomenologia negativa delle assemblee, con la sua scura e vivida ironia, è qui assunta a testimonianza di un’esperienza vissuta di disimpegno e frustrazione.
10. La diagnosi è esistenziale: il feticismo dell’assemblea generale e l’affezione politica dell’indignazione, espresse nel “linguaggio informe della vita separata” (p. 26), vengono dal fatto che un’assemblea non può far emergere altro che ciò che già contiene, e se ciò che essa contiene è la “vita” postmoderna, in serie e mutilata, allora essa produrrà solo impotenza collettiva. E tuttavia, se le piazze sono due cose in una, allora ad ogni parossismo d’isteria democratica pseudo-antagonista rispondono i germogli di una nuova vita, capaci di “abitare persino l’inabitabile” metropoli (p. 26), di dimorare. Questi movimenti e insurrezioni non ottengono le loro vittorie nelle ansie della democrazia diretta ma nell’auto-organizzazione della vita quotidiana. Una volta di più, le conclusioni da tirare sono d’ordine metafisico, come l’indica l’insistenza sull’abitare – che ricorda più l’heideggerianismo di sinistra che le utopie pratiche dell’abitazione di un Lefebvre, il cui libro Vers une architecture de la jouissance è stato da poco pubblicato. Quest’ansiosa coazione a ripetere che è il voto è superata da “un’attenzione inedita per il mondo comune”, che riceve una sorta d’imprimatur filosofico: “un regime di verità, di apertura, di sensibilità verso ciò che è presente.” (p. 27). È interessante vedere come la presa in carico collettiva dei compiti necessari alla riproduzione sociale (ovviamente non tutte, non abbiamo visto i manifestanti occuparsi delle fogne, dell’acqua corrente né delle diverse ramificazioni dello Stato logistico) è trattata qui come il segno materiale di un presente rivoluzionario. Forse c’è una specificità “occidentale” in questo stupore davanti all’auto-organizzazione, ma questo stupore non ha, in fin dei conti, granché di filosofico se ci induce a ignorare che questo “comunismo di movimento” (per riprendere il termine utilizzato da Badiou a proposito dello stesso fenomeno ne Le Réveil de l’Histoire) è politicamente indeterminato. La riproduzione sociale e l’autodifesa sono parte anche dell’agire dei militanti di estrema destra o delle correnti religiose conservatrici (l’abbiamo visto da Maidan a Tahrir) e, a meno di non considerare che sia fonte di emancipazione in sé il fatto riprendersi ciò di cui lo Stato ha fatto monopolio, bisognerà forse riconoscere che né l’etica, né la riproduzione, ne (a fortiori) la “vita”, possono a rendere obsoleto il momento politico, e la deliberazione – che ovviamente non è riducibile a delle assemblee inutili dove si agitano le mani in aria.
11. La verità della democrazia, ci dice il Comitato Invisibile, non è né lo Stato né la legge, ma il governo. Nell’orizzonte politico-metafisico di Ai nostri amici, la democrazia è la “verità” di ogni forma di governo, nella misura in cui l’identità del governante e del governato è il governo “allo stato puro”. Il presente costituirebbe quindi una sorta di apoteosi dell’ordine cibernetico già solidamente teorizzato da Tiqqun. Il fatto che questo “grande movimento di fluidificazione generale” (p. 29) sia condizionato dagli imperativi dell’accumulazione resta su uno sfondo distante, al punto che sospettiamo che a volte ci sia all’opera un destino d’ordine propriamente ontologico e che ogni potenza agente si sia volatilizzata. Invocando il potere più di quanto lo teorizzi, il Comitato solleva comunque una questione estremamente urgente e dolorosamente concreta: come hanno potuto i rivoluzionari, in Egitto, in Tunisia e altrove, essere “fregati” dalle forze politiche dominanti, trasformati in mediatori evanescenti, retroattivamente ridotti a soldatini di piombo per i regolamenti dei conti dentro i corridoi del potere? La risposta è tristemente semplice: esigere una destituzione (del potere in carica) senza avere la forza di organizzarla significa condannare se stessi e il processo di destituzione ad essere manipolati dalle forze organizzate. Ossia, per riprendere l’elegante aforisma del testo, “Un movimento che esige finisce sempre per avere la peggio di fronte a una forza che agisce” (p. 30). In maniera ancora più acuta, il Comitato propone di abbandonare la “finzione” di una dialettica tra potere costituente e costituito, nel quale l’atto popolare della destituzione potrebbe essere assorbito in una dinamica di legittimazione, eludendo in questo modo “l’origine sempre sordida del potere” (p. 31). (potremmo notare qui come l’abbandono di ogni dialettica di questo tipo, e di ogni concezione del potere legittimo annulla tutte le concezioni esistenti della rivoluzione, anche nelle loro versioni anarchiche. Gli autori, per ragioni forse più estetiche o etiche che propriamente politiche, insistono tuttavia a chiamarsi rivoluzionari). La conclusione è senza appello: “Quelli che hanno preso il potere retroproiettano sulla totalità sociale, che ormai controllano, la fonte della propria autorità e così la faranno legittimamente tacere, in suo nome” (p. 31).
12. Abbandonare la dialettica del costituente e del costituito, nella sua ipostasi delle forme contingenti di governo (la Repubblica) equivale quindi a ripensare la rivoluzione come pura destituzione – come ciò che priva il potere del proprio fondamento senza crearne uno nuovo (“potere destitutente” rappresenta in qualche modo l’ultima parola di Agamben sull’ Homo Sacer, il punto d’approdo de L’uso dei corpi, ultimo volume di quest’autore la cui influenza è in queste pagine palpabile). L’insurrezione è qui un grande rivelatore, che rende visibile simultaneamente il vuoto metafisico del potere e il suo attuale radicamento nei vili particolarismi del controllo poliziesco e del privilegio. Gli autori non sembrano trovare paradossale di fatto di legare il movimento heideggeriano della loro anti-storia dell’Occidente con questa conclusione quasi degna di un Durutti: “Tutte le carogne hanno un indirizzo. Destituire il potere, significa riportarlo sulla terra.” (p. 32). Ma la destituzione del potere governante è anche quello del potere popolare. Uno dei corollari di quest’approccio, e non di secondaria importanza, è l’appello “rinunciare alla nostra legittimità” (p. 32). È una sfida acuta, che implicherebbe come minimo una vigilianza consapevole sulla facilità con la quale movimenti che dovrebbero essere anti-sistema riproducono e talvolta rivitalizzano le coordinate stesse del proprio assoggettamento.
13. Ma il Comitato non obbedisce alla sua stessa ingiunzione. Piuttosto, sposta continuamente la sede della legittimità, ossia della verità, dal pratico al metafisico. Da ciò che chiama il suo “altro piano di percezione” (p. 33), afferma che il problema del governo, e delle antropologie negative che implica, non può essere posto che quando un vuoto è stato creato tra gli esseri. Uscire dal paradigma del governo, è entrare in quello “dell’abitare”, un’ontologia relazionale della pienezza nella quale “ciascuno di noi è il luogo di passaggio e di tessitura di una quantità di affetti, allineamenti, storie, significazioni e flussi materiali che ci eccedono. Il mondo non ci circonda, ci attraversa. Ciò che abitiamo ci abita.” (p. 33). L’organizzazione e la strategia riverrebbero quindi, in ultima istanza, al passaggio ad una Gestalt che ci permetta di cessare di vedere cose, soggetti, soggetti e corpi, e cominciare a vivere attraverso forze, potenze e legami: “È grazie alla loro pienezza che le forme di vita compiono la destituzione” (p.33). Da parte di un collettivo dalla critica così caustica, lascia perplessi constatare che il Comitato Invisibile non sembra rendersi conto fino a che punto si accodi così ad una tendenza contemporanea fin troppo diffusa: negare l’autonomia del politico, per meglio accordare questa stessa autonomia a una vita e a un essere politicamente equivoci. Potremmo concluderne che, ben lontano dal rinunciare alla propria legittimità, il Comitato l’ha ipostatizzata, nella vita stessa.
14. Si apre, come gli altri capitoli, con la fotografia di un graffito – proveniente dalla Val Susa e che dice “Il potere è logistico. Blocchiamo tutto” – la sezione dedicata al potere infrastrutturale. Si tratta del cuore strategico del libro, e forse del capitolo che subisce meno l’ipoteca della vita insurrezionale. Mai a corto di grandi declamazioni generalizzanti, il Comitato comincia abbordando gli atti insurrezionali dal 2011, altrettanti assalti contro i simboli del potere difesi dalle “forze dell’ordine” con una ferocità che gli autori credono essere inversamente proporzionale alla loro importanza “il potere non risiede più nelle istituzioni” (p. 35). Esse, infatti, non sarebbero più che delle delle vere e proprie “trappole per rivoluzionari” (p. 35). Al che potremmo far notare che quindi il potere simbolico non è completamente sparito. O, invece, che il carattere “teatrale” del potere è in riflusso da tanto tempo, diciamo anche da secoli. Delle periodizzazioni forti sono indispensabili per far emergere una percezione comune ma la tesi di un passaggio dalle istituzioni alle infrastrutture è parecchio disorientante da un punto di vista storico. Non solo le istituzioni dello Stato sono sempre state dipendenti da un potere infrastrutturale – dai dibattiti sulle basi idrauliche del “dispotismo asiatico” fino alla brillante esplorazione di Robert Linhart delle tragedie logistiche del bolscevismo in Lenine, les paysans e Taylor – ma inoltre, le infrastrutture contemporanee, dalla metropolitana al trasporto intermodale, sono delle istituzioni, saturate di burocrazie, strumenti di misura, agenzie, riti, lobbisti e così di seguito. Non si fanno né si governano da sole. Possiamo senz’altro riconoscere l’importanza della questione delle infrastrutture nelle recenti strategie del potere e dell’opposizione – come anche nei recenti riaggiustamenti dei modi di produzione – senza doverne concludere che il potere istituzionale-rappresentativo non è più che una cortina di fumo. In un passaggio come quello che segue, la logistica, come l’auto-valorizzazione del capitale per i teorici del valore o la polizia per gli anarchici, può diventare un vero feticcio: “Il potere contemporaneo è di natura architettonica e impersonale e non rappresentativa e personale” (p. 35). (Immagino che possiamo quindi scordarci degli indirizzi delle carogne; in fondo contano poco). Le descrizioni particolari smentiscono la narrazione epocale. La localizzazione di un potere puramente cibernetico, senza altri segreti che quello del suo funzionamento, immanente ad apparati come “la pagina bianca di Google”, diventa allora luogo… di decisioni politiche: “Chi determina la configurazione dello spazio, chi governa gli ambienti e le atmosfere, chi amministra le cose, chi gestisce gli accessi – governa gli uomini” (p. 36). Ben detto, ma non c’è nessuna regione di considerare questo potere trascendente rispetto alle istituzioni (lo vediamo, se non altro, seguendo il racconto che propone Donal McKenzie della genesi materiale e giuridica delle transizioni finanziarie ad alta frequenza o algoritmiche). Ciò vale anche per il modo in cui la “governance” contemporanea del capitale produce “zone” al di là della nazione, sottomettendo così anche la nozione stessa di “società” a una brutale fluidificazione (p. 39).
15. Detto ciò, Ai nostri amici effettua una sintesi abile del sentimento che impregna le lotte contemporanee e che si potrebbe designare come l’esigenza di un materialismo politico che prenda l’infrastruttura come campo e obiettivo “Chi vuole intraprendere qualcosa contro il mondo esistente deve partire da questo dato di fatto: la vera struttura del potere è l’organizzazione materiale, tecnologica e fisica di questo mondo” (p. 36). Ma non vedo la necessità, se non per ragioni retoriche, di dichiarare immediatamente dopo “il governo non è più nel governo” (p. 36). Ciò potrebbe essere vero se la questione fosse di dissipare le tenaci illusioni politiche che trascurano la materialità e l’economia politica dello Stato. Ma è impossibile comprendere (e intervenire nelle) le infrastrutture senza misurare quanto l’organizzazione materiale, tecnologica e fisica del mondo richieda anche un vasto arsenale di operazioni istituzionali, e non semplicemente un piccolo numero di operazioni governamentali. Trascurare il fatto che il diritto e la politica sono costitutivi di questo potere infrastrutturale sarebbe una errore strategico madornale. La “costituzione politica” non collima senza resto con la “costituzione materiale”.
16. Ai nostri amici mobilizza il concetto di potere infrastrutturale per rendere conto dello spostamento contemporaneo del dominio dal simbolico all’ambientale, mentre il controllo della polizia è accelerato nella sua pervasività per diventare precisamente il guardiano di un potere che mente, per così dire, su tutto il network. Uno dei pregi, e non è poco, dell’attenzione del Comitato, della sua percezione di questa “rivoluzione logistica” delle arti del dominio, è il suo modo di chiarire le impasse nelle quali entrano molte delle rivolte contemporanee. Come osservano laconicamente: “non si critica un muro, lo si distrugge o lo si tagga (p. 36). È nello scontro con l’omogeneità rotta della metropoli, “deserto e anemia esistenziale” (p. 37), che emergono i luoghi della gioia comune (Gezi, Puerta del Sol, etc.) nei quali possiamo sperimentare il “legame intuitivo tra autorganizzazione e blocco.” (p. 38). Ma il paesaggio del capitale si è trasfigurato anch’esso, visto che la fabbrica, questa prigione-fortezza operaia, è diventata un “sito”, un anello logistico. In qualche pagina lapidaria (pp. 38-39), gli autori provano a riassumere e congedare una larga parte del dibattito marxiano, generalmente cristallizzato intorno al secondo volume del Capitale e nei passaggi sul “general intellect” nel Grundrisse. Sarebbe malvenuto di lanciarsi in questa sede in esercizi filologici ma non è inutile far notare che la solo conclusione politica di tutto questo – a parte quella dell’obsolescenza della teoria del valore – è quella dell’indistinzione tra sfera della produzione e della riproduzione. È un’ironia della dialettica, non colta dagli autori del testo, che i cambiamenti infrastrutturali prodotti come risposta strategica alla lotta di classe – in particolare per frammentare il potere dei lavoratori della logistica e dell’estrazione – dovessero dare luogo ad una condizione di totalità espressiva, dove ogni attacco logistico costituisce un attacco al sistema nel suo insieme.
17. “Attaccare fisicamente questi flussi in un punto qualsiasi significa quindi attaccare politicamente il sistema nella sua totalità” (p. 39). Affermazione incoraggiante, ma poco convincente. Un sistema può essere solo politicamente attaccato nella sua totalità, quando esiste un’intenzione o (preferibilmente e) un effetto totalizzante. Ora, questi sistemi reticolari sono strategicamente concepiti per minimizzare il contagio, e si appoggiano sulla frammentazione del lavoro e la massimizzazione della resilienza, almeno altrettanto che sull’omogeneità delle norme e dell’intermodalità: nulla permette d’affermare che bloccare un flusso significhi bloccarli tutti. Il Comitato ci esorta a percepire ogni tentativo di “bloccare il sistema globale, ogni movimento, ogni rivolta, ogni sollevazione, come un tentativo verticale di arrestare il tempo e di biforcare in una direzione meno fatale” (p. 40). Un’impressionante immagine benjaminiana che sfortunatamente perde in chiarezza esplicativa ciò che guadagna in entusiasmo, perché non abbiamo visto tentativi di bloccare il sistema globale come tale (quale che sia il senso che si possa dare a quest’espressione…), e soprattutto perché una tale visione metafisica di rivolte espressive trascura la questione strategica di come le rivolte logistiche potrebbero diventare effettivamente rivolte contro il sistema. Presupporre che i blocchi siano già antisistemici di per sé significa non solo ignorare la storia del loro utilizzo tattico da parte di movimenti perfettamente “riformisti” (o addirittura reazionari, come negli scioperi dei camionisti in Cile, ai quali il governo Allende aveva risposto con… un sistema cibernetico), ma anche cedere alla fantasia che una tattica possa, in quanto tale, costituire una strategia. Tra l’altro, più il là all’interno del libro, gli autori apportano una netta rettifica a questo passo falso: “il sabotaggio è stato infatti praticato dai riformisti così come dai nazisti” (p. 60).
18. Il capitolo sui blocchi si chiude con delle ingegnose riflessioni sulla questione del sapere. Partendo da una prospettiva molto classica, che attribuisce la debolezza delle lotte all’assenza di prospettive rivoluzionari credibili (e non il contrario), il Comitato postula che il problema presente sia quello di una strategia rivoluzionaria che non abbia come obiettivo solo i rappresentanti del potere ma il “funzionamento generale della macchina sociale” (p. 40), da cui dipendiamo per la nostra sopravvivenza. Qui, la riflessività negativa della lotta (siamo i nostri propri nemici) assume una curvatura materiale (il nostro nemico è il nostro sostentamento) e pone una domanda pratica, sperimentale: come disconnettersi dal potere infrastrutturale senza correre il rischio di una penuria paralizzante? In altri termini, come il sabotaggio può non ritorcersi contro sé stesso? La severità e la sobrietà dell’affermazione seguente sono le benvenute: ”finché non sapremo come fare a meno delle centrali nucleari e il loro smantellamento sarà un business per gli stessi che le vogliono eterne, aspirare all’abolizione dello Stato continuerà a far sorridere; finché la prospettiva di una sollevazione popolare significherà una sicura penuria di cure, di cibo o di energia, non esisterà un deciso movimento di massa” (p. 40). Da lì, l’appello a ritornare all’inchiesta come strumento che unisce strategia, sapere e ricomposizione politica (ed etica). Come lo scrive il Comitato: “non ha senso saper bloccare l’infrastruttura dell’avversario se non sei capace di farla funzionare, in caso di necessità, a tuo vantaggio” (p. 41). Curiosamente, il tono moralista dei riferimenti precedente alla vita buona qui sfuma, rimpiazzato da una visione più attraente di un’altra forma di vita fondata sulla “passione della sperimentazione”, su una “passione tecnica” e sulla “accumulazione di saperi” (p. 40), senza la quale non ci può essere nessun serio ritorno della questione rivoluzionaria. È forse rivelativo delle inversioni che segnano il nostro presente che il passaggio più realista e materialista di questo pamphlet, l’appello ad “aggregare tutta l’intelligenza tecnica in una forza storica e non in un sistema di governo” (p. 41), e a uscire quindi dall’ignoranza profonda delle nostre condizioni materiali, sia anche quello che suona più utopico.
19. Se le infrastrutture materiali ed energetiche della riproduzione del capitale possono essere oggetto di una riappropriazione (almeno parziale), quelle del “capitalismo comunicazionale”, ossia Facebook e Google, non sono invece che il prodotto più dannoso dell’appetito dei dirigenti per la cibernetica. Alcune di queste pagine, consacrate all’idraulica militare e finanziaria di internet, potrebbero essere lette di gusto se non si rivelassero, in fine dei conti, ridondanti, l’eco di una semplice critica di buon senso – critica che non impedisce ovviamente (quasi) nessuno di riprodurre (sé stessi attraverso) questi dispositivi di speculazione e sfruttamento. Immaginare che la miseria della cibernetica sia ciò che la farà crollare davanti alla “presenza”, non è forse cullarsi in un’illusione? Più stimolante, anche se schematica, è la tesi antropologica secondo la quale i social network rivelano il sorpasso della tecnica da parte della tecnologia, definita come “espropriazione degli umani delle loro diverse tecniche costitutive” (p. 52). Nella prospettiva di questo lungo pastiche heideggeriano, se l’ingegnere è l’espropriatore della tecnica per eccellenza, l’hacker incarna il lato “etico (nel senso di ethos) della tecnica. È la figura della sperimentazione come prova vissuta delle implicazioni etiche di una data tecnica. Nonostante i ripetuti appelli ad abbandonare l’Occidente, questa etica della conoscenza suona nettamente illuministica: capire il funzionamento degli apparati che abbiamo intorno, forzare l’apertura della scatola nera, porterebbe a un “immediato accrescimento di potenza” (p. 52). Il comitato presta comunque attenzione a non tirarsi dietro gli assunti regressivi dell’individualismo libertariano e, partendo da una digressione sulle affinità etimologica tra le parole “friend” e “free”, ci viene detto che la libertà dell’hacker è collettiva, transindividuale: “Sono libero perché sono legato” (p. 53). Gli hacker dovranno sacrificare il feticcio della libertà slegata (e della libertà di espressione) se vogliono – ma lo vogliono? Vogliamo che lo vogliano? – “divenire una forza storica” (p. 53).
20. Più andiamo avanti nel testo, più l’appello a una percezione comuna e l’elenco dei miraggi si amplificano. Anche se può sembrare contraddittorio con l’insistente rivendicazione della verità etica, Ai nostri amici non è solo una critica delle ideologia dei movimenti recenti ma anche l’appello a un’altra ideologia. I frutti rari e amari delle impressionanti mobilitazioni in Grecia ci insegnano che “senza un’idea sostanziale di quello che significa una vittoria siamo destinati alla sconfitta” (p. 57). Dopo una digressione azzardata sulle “origini” della politica nella Grecia antica, veniamo al ripudio del paralizzante faccia a faccia tra radicalismo e pacifismo. Né strategica né congiunturale, l’analisi qui è interamente filosofica. La guerra non è “il massacro, ma la logica che presiede al contatto tra potenze eterogenee” (p. 58). Una definizione disincarnata, metafisica, che ha come obiettivo di stabilire l’assurdità del desiderio di escludere la guerra dal socius. Ma se non si parla di massacri, in quantità industriale o anche artigianale, perché non parlare semplicemente di “conflitto” o di “agonismo” – come fanno tanti altri teorici politici? È ancora la ricerca di un brivido extra di autenticità che sta dietro all’evocazione ripetuta della guerra civile? Nonostante la debolezza dello slogan, i ritratti del pacifista e del radicale sono eseguiti con maestria, soprattutto quello del radicale, col suo elogio ideologico della violenza, il suo trascurare la strategia e la sua privatizzazione dell’attivismo come “occasione di valorizzazione personale” (p. 60). (Tutti i lettori avranno senza dubbio potuto riunire una larga selezioni di questi personaggi “radicali” nel proprio teatro mentale). La fenomenologia del “piccolo terrore” che regna negli “ambienti radicali” porta a osservazioni di un realismo quasi doloroso: “Una vertigine prende a posteriori chi ha disertato questi circoli: come ci si può sottomettere a una pressione così mutilante per degli scopi così enigmatici?” (p. 60). Contro la “politica extra-terrestre” del radicale, che ha la pretesa di apportare un’illuminazione dall’alto e dall’esterno, Ai nostri amici gioca di nuovo la carta del “l’attenzione” – tema promettente, anche se problematico, perché dipende da un’immagine assai vaga della “sensibilità” del rivoluzionario, dalla produzione di atti che si situano leggermente “in anticipo” sui movimenti ma la cui pertinenza è decisa dallo stato del movimento stesso. (Per inciso, è strano che autori così attaccati all’idea della guerra civile ricaschino così facilmente nella vulgata di sinistra parlando “del movimento”).
21. “La vita è essenzialmente strategica” (p. 62). Questa dichiarazione non dovrebbe sorprenderci. Arriva in effetti qualche pagina dopo la mobilitazione dell’ingombrante metafora marziale del sistema immunitario e della ricerca di una fusione tra strategia ed etica. Più sorprendente, forse, è il fatto che gli autori cerchino negli archivi della contro-insurrezione contemporanea i mezzi per sviluppare un “concetto civile della guerra” (p. 62). È sicuro che non c’è nulla di male nel voler imparare dal nemico, ma le lunghe citazioni senza commento sembrano un’occasione persa per analizzare fino in fondo (nel solco dei lavori di Laleh Khalili e di altri) il ruolo assolutamente cruciale degli assi di genere e di razza nella sociologia della contro-insurrezione e di chiedersi quindi come queste identità e risorse potrebbero essere neutralizzate o mobilizzate in una politica “civile” della guerra. Presentare “l’epoca” (perché uno dei principali obiettivi di questo libro, come del precedente, è di affermare senza ambiguità che ciò che stiamo vivendo è senz’altro un’epoca) come una corsa tra “la possibilità dell’insurrezione e i partigiani della contro-insurrezione” (p. 65) significa inoltre mettere da parte il carattere quotidiano della riproduzione sociale e della sua logistica, e la guerra di bassa intensità che accompagna l’organizzazione dello sfruttamento e dell’esclusione; significa, in fondo, appoggiarsi in maniera troppo pesante sugli scenari d’insurrezione globale che condiscono i rapporti della CIA e di altre entità del genere – che dopotutto dipendono dalla produzione di tali scenari per presentare come indispensabili sé stessi e i propri complessi industrial-militari. È comunque rincuorante vedere gli autori attenti alla tentazione di trasformare le teorie contro-insurrezionali in teoria insurrezionali. La loro proposta alternativa resta però gnomica, anche se suggestiva: “Abbiamo bisogno di una strategia che non prenda come obbiettivo l’avversario ma la sua strategia e che quindi la ritorca contro essa stessa” (p. 65).
22. Il problema è che questo aforisma, la cui premessa implica una “asimmetria ontologica” tra gli esperti dell’insurrezione e della contro-insurrezione , è basata su di una profonda sovrastima della minaccia che questi ultimi rappresenterebbero per il potere. “Noialtri rivoluzionari siamo allo stesso tempo la posta in gioco e il bersaglio di questa offensiva permanente alla quale ormai si riduce il governo” (p. 67). Una minaccia temporanea, certo, un fastidio permanente, sicuro, ma il bersaglio? C’è da dubitarne parecchio – come c’è da dubitare dell’affermazione ulteriore secondo la quale la contro-rivoluzione globale che ha preso per “pretesto” l’11 settembre sarebbe stata in realtà una risposta politica ai movimento “no-global”, la cui anatomia tuttavia è presentata nel libro come di un movimento della piccola borghesia planetaria, sparita grazie al suo realizzarsi (pp. 93-94). In questa proiezione immaginaria del “noi”, Ai nostri amici rischia di cascare in una delle trappole retoriche di quello stesso settarismo a cui cerca di sfuggire – l’idea che il potere non è altro che una formazione reazionaria contro di noi e la formidabile minaccia che rappresentiamo. Ma la riproduzione della società capitalista è ben meno tortuosa e marziale di così, e le sue violenza, per quanto profonde, sono più dilatate. Trattare tutta la vita sociale come un campo di battaglia può anche essere galvanizzante ma resta un errore. È più interessante – perché meno metafisico e più strategico – l’avvertimento quanto al pericolo di lasciare il governo produrci come soggetti radicali (che sia come “IRA” o come “Black-bloc” per riprendere gli esempi del libro), come anche il ricorso inatteso all’immagine “diffusa” e irriducibilmente plurale (pp. 69-70) che ci trasmette la resistenza palestinese. Ciononostante, il testo torna rapidamente su quel retroterra di legittimità che sarebbe la “vita” dalla quale (per citare una delle frasi più discutibile del libro) “emana l’identificazione del nemico, le strategie e le tattiche”. E quindi la strategia collassa in un cliché “abitare pienamente, ecco quello che si può opporre al paradigma del governo” (p. 69). Detto ciò, la traduzione più demotica di questo passaggio contiene un momento di verità che non è certo trascurabile: “Chi ha dei rapporti di merda non può fare che una politica di merda” (p. 69).
23. Quanto a politica, quindi, l’uomo abita. Ma dove? In un “locale” che ripudia ogni “localismo” – il Comitato critica implacabilmente e giustamente questa sempreverde tentazione –, nella vita quotidiana dei territori in lotta che tirano la propria consistenza dalle lotte stesse. Con disinvoltura saremmo tentati di vederci – riferendoci alla pratica guevarista teorizzata da Régis Debray – un foquismo senza partito, senza esercito, senza giungla. Più che localismo, localizzazione quindi, questa attività di cartografia cognitiva che consiste nel “seguire le connessioni di una sala della borsa fino all’ultima delle sue fibre ottiche” (pp. 79-80) che corona la questione politica del blocco e della contro-logistica. Quando prende come bersaglio le ideologie della sinistra contemporanea, il Comitato mira spesso giusto e la sua presa di distanza dal modo in cui le “lotte locali” sono spesso usate a conferma di un comunitarismo e di un comunismo soggiacenti (interpretazione di cui possiamo dire che il Comitato non si sia completamente liberato) fa centro. Ma la strada proposta per evitare queste trappole ideologiche è di un’astrazione estrema che si pretende di un’estrema concretezza: “la vita vivente” (p. 80), “l’esperienza” delle relazioni, delle amicizie, delle vicinanze e delle distanze. Possiamo fidarci fino a questo punto dell’esperienza? Non è una fantasia paralizzante di pensare che tutte le nostre esperienze debbano essere portate nella lotta, che tutta la vita è “in comune” – fantasia che può diventare noiosa o sinistra quando queste esperienze comuni vengono elevate al rango di istituzioni, rituali, strutture? (E come potrebbe esserne altrimenti, a meno di pensare che la politica possa essere radicalmente de-strumentalizzata, de-reificata per diventare un flusso ininterrotto d’immediatezze?).
24. Per quanto ciò possa repellere gli autori, c’è un’istituzione che si promuove nel libro, quella della comune. Non una forma di governo, non un corpo politico ma un’istituzione, definita dagli autori stessi come “il patto di affrontare insieme il mondo” (p. 83) e da un punto di vista più ontologico come “una qualità del legame e una maniera d’essere nel mondo” (p. 84). I riferimenti impliciti sono qui numerosi: non solo al 1871 ma anche a Huey P. Newton, Gwangju, Gustav Laundauer. La grammatica spaziale utilizzata è impressionante: la comune è “un certo livello di condivisione inscritto territorialmente” (p. 84). La guerra continua contro l’astrazione quantitativa e calcolatrice: “Con la sua sola esistenza rompe la suddivisione ragionata dello spazio” e “si pensa innanzitutto come rottura concreta, situata, con l’ordine globale del mondo” (p. 84). L’ombra della totalità espressiva aleggia ancora su questo passaggio, il cui presupposto metafisico è che una rottura radicata è anche planetaria. Il che è curioso se pensiamo al fatto che il globale, il planetario, è il prodotto dell’astrazione, della scienza, del capitale e del colonialismo. Abitare il globale, ecco ciò che sembra in contraddizione. (E la comune potrebbe anche essere vista come un’astrazione di forme di comunalità irriducibili tra di loro, che potrebbero esser rappresentate come universali solo dal cuore stesso dell’astrazione). La soluzione risiederebbe in un federalismo eterodosso: la comune deve allo stesso tempo essere saldamente legata a una realtà territoriale eterogenea rispetto al sistema e tessere legami e solidarietà con altre realtà locali, altrimenti si trasformerebbe in enclave sterile e assediata o si perderebbe in un erranza senza meta. La comune qui non è quindi, chiaramente, prendersi carico del comune, nuova forma giuridica di appropriazione, per quanto egualitaria: è “una forma di vita comune”, una relazione comune a “ciò che la traversa senza che possa mai appropriarsene”, le res communes, il “mondo” stesso. È anche un tentativo di abolire i bisogni nati dalla privazione del mondo (come lo indica l’antropologia universale dagli accenti rousseauiani degli autori) a beneficio di una profusione dei mezzi. In questo orizzonte gioiosamente opposto a ogni materialismo storico, la produzione non è più che un sotto-prodotto del “desiderio di vita comune”. Ribaltando lo slogan cinese, potremmo dire: “la produzione dopo!”. La “fecondità”, che costituisce ciò che organizza la comune al di là dell’economia e dello scambio, viene prima. È ciò che permette al Comitato di dire con entusiasmo “possiamo organizzarci e (…) questa potenza è fondamentalmente gioiosa” (p. 91). La vita comune, in quanto vita della comune, replica ancora una volta la struttura espressive che attraversano Ai nostri amici: “In ogni dettaglio dell’esistenza ne va dell’intera forma di vita” (p. 90). (Che ci si perdoni il trovare questa vita senza sosta propizia alla claustrofobia e al superegoismo).
25. Al momento della conclusione strategica, come tanti testi di sinistra, Ai nostri amici si fa vago e allusivo. (sarebbe un interessante esercizio di iconoclastia militante di ritagliare gli ultimi paragrafi di tutti i componimenti anarchici e marxisti. Un’antologia di tali paragrafi sarebbe di certo impossibile da digerire). In assenza di un bersaglio determinato, è ancora una volta verso la concretezza della “vita”, del “dove siamo” che si rivolge il testo, verso la promessa empirica delle inchieste, delle cospirazioni e delle consistenze locali, verso le alleanze come questione generale che prende qui l’interessante forma della traduzione. Quando si pone la questione di costruire una forza che non sia un’organizzazione, riveniamo di nuovo alle astrazioni, calorose e concrete certo, ma che restano astrazioni – il cui valore politico è, d’altra parte, difficilmente valutabile in maniera univoca: la crescita della “potenza”, come sito della “disciplina” e della “gioia”; le diverse proporzioni dello “spirito”, della “forza” e della “ricchezza”, la cui gestione prudente deve permettere di evitare disproporzioni fra l’avanguardia armata, la setta dei teorici e l’impresa alternativa (p. 98). La felicità è più o meno l’ultima parola del libro e, come tutte le verità etiche che non sono legate a delle forme di vita, anch’essa non può che lasciarci inappagati o suonare un po’ vuota, a meno di diventare lo schermo su cui proiettare lo spirito, la forza e la ricchezza delle nostre lotte locali. Lo scivolamento nel registro morale e astratto, in una retorica che non potrebbe mai essere veramente impiegata tra amici, non è un problema che ha solo il Comitato Invisibile. È proprio alla nostra condizione – una condizione le cui tante trappole e fantasie ideologiche sono rintracciate dal libro con una severità perspicace. Forse è inevitabile che un discorso così incoraggiante abbia bisogno di un punto di appoggio. Non sorprende che esso si trovi in una sorta di vitalismo. Se la nostra sicurezza non è tirata fuori dalle contraddizioni della struttura, dalla logica di ciò che ci domina, dove altro prenderla se non nell’esperienza vissuta e nella sensibilità? Gli autori farebbero bene a prestare attenzione alla risposta dialettica alla tetra frase adorniana di Franco Fortini: “Non c’è vita vera se non nella falsa”. Detto altrimenti, non c’è vita che sia vera in sé, perché, come l’aveva già osservato Lukacs ne La teoria del romanzo, la nozione della vita quale dovrebbe essere, cancella la vita stessa.
(*) Alberto Toscano è docente in Critical Theory alla Goldsmiths, University of London. Autore, con Jeff Kinkle, di Cartographies of the Absolute (Zero Books, 2015), e di Fanaticism: On the Uses of an Idea (Verso, 2010). È il curatore di The Italian List for Seagull Books e fa parte del comitato editoriale della rivista Historical Materialism (sito interne: http://www.historicalmaterialism.org).
Testo originale pubblicato su http://www.metamute.org/editorial/articles/burning-dwelling-thinking
(traduzione italiana a cura della redazione di infoaut, riprodotto per gentile concessione dell’autore)
-
Ogni teoria della rivoluzione è un bilancio delle sue sconfitte. Ecco cosa traspare delle prime pagine di Ai nostri amici, e distingue questo libro, nonostante la continuità di stile e obiettivi, da L’insurrezione che viene. Se in quest’ultimo, per parafrasare Il 18 brumaio, la fraseologia anticipava profeticamente il contenuto, ora è il contenuto a sorpassare la fraseologia. L’insurrezione è arrivata ed è stata sconfitta. E nonostante ciò, continua a venire. Ma l’ordine delle priorità è mutato, la poesia di un avvenire imminente fa sempre più spazio alla prosa del passato recente. Siamo stati vinti. Ma siamo ovunque. La stabilità è morta. Il capitalismo si sta disgregando. E tuttavia si riproduce – come catastrofe permanente.
-
La tendenza non è tanto quella di una lenta impazienza, piuttosto il suo contrario, una pazienza che si affretta, la distillazione di un orizzonte planetario nell’azione in situ, liberata da ogni appuntamento con la storia, da ogni incontro provvidenziale con la traiettoria del capitalismo. Una teoria della rivoluzione dovrebbe contemporaneamente ritrarre la congiuntura, sondare la tendenza di fondo, dare un nome ai nemici, raccogliere gli amici. “Chi sono i nostri nemici? Chi sono i nostri amici?” – queste sono le prime righe del primo volume delle Opere scelte di Mao Zedong. Sin dal titolo, questa domanda “classica” risuona in tutto il libro, Ai nostri amici. Ma è esattamente attraverso questo “noi”, ciò che il linguista Roman Jakobson chiama efficacemente commutatore (shifter) – un elemento del discorso il cui referente non può essere stabilito che a partire dal contesto del messaggio – che questo appello si rivela meno univoco di quanto possa sembrare in prima battuta.
-
Ciò non è tanto il frutto dell’anonimato imperfetto degli autori. Prendere misura della contro-rivoluzione esige uno sforzo di riflessività che relega in secondo piano la supremazia dei nemici, per preferire un esame delle debolezze delle “nostre” forze. L’impressione iniziale è quindi quella di un’auto-critica particolarmente benvenuta. Ma uno scarto decisivo si allarga tra il “noi” che ha fallito e il “noi” che ha scritto. L’automatismo politico della crisi, per esempio – associato qui, come ci si può aspettare, al facile immaginario d’un marxismo apocalittico – non poteva certo essere attribuito alla precedente professione di fede comunista del Comitato. Uno dei leimotivs più caustici de L’insurrezione che viene era l’idea che ciò che “ci” blocca sia la resilienza ostinata della “Sinistra”, intesa come un unico habitus di militanza condiviso tanto dai leninisti che dai social-democratici, gli anarchici e gli “indignados”. Allo stesso modo, quando attaccano tutto il repertorio dell’antagonismo consensuale, dell’human mic all’agitare le mani in aria in segno di approvazione, non sembrerebbe che gli autori, per parafrasare il poema di Fortini “Traducendo Brecht”, iscrivano i propri nomi nella lista dei nemici. E forse non potrebbero farlo, senza disturbare la retorica della secessione e dell’autenticità che impregna il loro testo.
-
Visto il considerevole talento del Comitato per l’intervento polemico e gli exploit devastanti di Kulturkritik, è un peccato che un po’ di autocontrollo non sia esercitato anche in materia di stile, anch’esso un affare politico. Il congedo finale, in versi, che sembra quasi presentare delle scuse per la vivace analisi che lo precede, ne è un esempio lampante. Per non parlare di dichiarazioni fastidiosamente pompose come “Il nostro margine d’azione è infinito. La vita storica ci tende le braccia” (p. 17). “Noi” non siamo certo dappertutto a cospirare, checché ne dicano speranzosamente gli autori. È con un eccesso di fiducia – e in contraddizione con la sua analisi della nostra epoca come colpita da un’indicibile degradazione metafisica e antropologica – che Ai nostri amici crede di vedere la saggezza popolare del momento condensarsi nel detto argentino ¡Que se vayan todos!. Questo è vero ma solo nella misura in cui il disprezzo per chi ci governa è anche una proprietà della destra, che lo maneggia con molta più destrezza del Partito dell’Uguaglianza. Allo stesso modo è una forzatura proiettare su Occupy Wall Street – un movimento le cui incursioni nel campo della rivoluzione della vita quotidiana si sono dimostrate relativamente timide – il “disgusto” per la vita di oggi. Non sarebbe più utile, al di là delle epifanie esistenziali che potrebbero coglierci all’interno dei nostri gruppi in fusione, misurare quanto i sollevamenti recenti hanno poco « rivoluzionato » le abitudini e le menti? Aderire a un partito comunista ai tempi di Stalin dava luogo senza dubbio a dei cambiamenti interiori incomparabili con quelli suscitati dalla partecipazione alle sollevazioni di oggi le quali, nel bene come nel male, richiedono di gran lunga meno de- e ri-soggettivazione.
-
Per farla finita con l’eredità delle filosofie della storia e le illusioni progressiste, Ai nostri amici ci intima di rifiutare d’interpellare la crisi economica. L’idea sottogiacente non è però quella di un nominalismo familiare nel quale la “crisi” non è più che un’astrazione illegittima proiettata sulla molteplicità reale della vita sociale. Non solo si afferma enfaticamente che gli eventi che hanno avuto luogo dal 2007 sono appartenenti a una stessa “sequenza”, “un’unica ondata mondiale di sollevazioni che comunicano impercettibilmente fra loro” (p. 6 – NdT. Tutte le citazioni sono riprese dall’edizione italiana disponibile su http://ainostriamici.noblogs.org/); l’insurrezione stessa diventa qui una sorta di totalità espressiva: ogni sollevazione individuale ha “immediatamente qualcosa di mondiale” (p. 6). Dalla Libia all’Ucraina, dalla Tunisia a Wall Street, da Notre-Dame-des-Landes a Oakland, il Comitato Invisibile si mostra estremamente inclusivo per quanto riguarda i siti dell’antagonismo contemporaneo, di ciò che cerca di far apparire come un unico (anche se non ancora unificato) processo rivoluzionario. Ma questo insieme d’insurrezioni non è l’espressione e nemmeno la risposta a una crisi capitalistica. In realtà, il discorso dominante sulla crisi, con la sua evocazione di un processo ingovernabile, non sarebbe altro che un’astuzia di governo. Ecco perché, in ultima analisi “Non c’è una “crisi” da cui bisognerebbe uscire. C’è una guerra che abbiamo bisogno di vincere” (p. 7). L’assenza di “punti” di crisi, l’esperienza quotidiana di una crisi senza fine – allo stesso tempo imposta e smentita dal potere -, è trasmutata in queste pagine in un orizzonte di negazione totale. Se le crisi (finanziarie, politiche) non sono puramente e semplicemente messe da parte, esse non sarebbero in fondo che degli epifenomeni di una crisi propriamente di civiltà, metafisica. Una crisi della presenza. Volendo suonare paradossali potremmo dire che ciò che unisce questa sequenza di rivolte, ciò che ne costituisce la storicità, sembrerebbe essere il fatto che esse non pongono più il problema di una discontinuità nella storia, quanto di una discontinuità dalla storia, la storia dell’Occidente. La lettura di Ai nostri amici lascia l’impressione tenace che il testo chieda la nostra affinità, il nostro assenso. Non sono avanzate (né potrebbero esserlo) argomentazioni o analisi che giustificherebbero il sorpasso di crisi ontiche con una vera e propria crisi ontologica, e se l’ontalagia (per prendere in prestito il neologismo di Raymond Queneau) che traspira da frasi come “abbiamo perso il mondo” vi sembra ostile o incomprensibile, vorrà dire che avete raggiunto i limiti della vostra capacità di cospirare (di respirare con) – e quindi, probabilmente, non siete davvero un amico. La matrice di un anti-capitalismo romantico è inamovibile, per quanto possa essere eclissata da un agonismo assiomatico (secondo cui la “guerra civile” è inesorabile, e il tentativo di evitarlo allo stesso tempo vano e debilitante). La vera vita, la lotta contro la “civilizzazione dell’alienazione”, la perdita del mondo – ecco le parole d’ordine del Comitato Invisibile. Forse l’allergia alle esortazioni all’autenticità che costellano Ai nostri amici non sono altro che il sintomo della condizione di “Occidentale” (categoria che, se dovessimo credere a una dubbia osservazione degli autori, sarebbe indifferente al colore, p. 15), incapace di lanciarsi nella “guerra” dei “terrestri” contro l’Uomo (p. 15). Queste parole hanno una forte risonanza heideggeriana-di-sinistra, che il riferimento a World war z (p. 20) non fa che accentuare. Gli autori possono anche parlare della “catastrofe che noi siamo” (p. 13), ciò non è che un preludio a una diserzione troppo speditiva. In questo addio rabbioso a secoli di pensiero metafisico, gli autori rischiano di portarsi dietro più macerie umanistiche di quanto non immaginino. La “presenza”, cosa c’è di più cristiano?
-
È un peccato che il termine “vita”, eterno contenitore di pseudo-concretezza e di falsa immediatezza, non sia stato maneggiato in queste pagine con la stessa circospezione dell’infrastruttura quotidiana del tardo capitalismo, dal TAV agli iPad. Senza dubbio non si può fare uso impunemente di questi ultimi, ma neppure attingere a piene mani al serbatoio della filosofia della vita e del vitalismo senza seminare una confusione che nessuno può permettersi oggi. La vita non offre nulla da celebrare, e il calcolo, in quanto tale, niente da condannare. Questa posizione non è che l’altra faccia della reificazione, il suo prodotto e il suo complemento. Ai nostri amici, visto che si appoggia su una teoria insurrezionale della sconfitta è un testo ben più sobrio che L’insurrezione che viene, ed è tanto meglio. Nonostante questo, gli autori continuano a raccontarsi storie su cui devono ben avere dei dubbi in fondo. Ciò che forse non vedono è quanto tutto ciò sia simile a quel radicalismo contemporaneo che aborrono, incapace di suscitare entusiasmo senza la falsa nota dell’esortazione. Oggi i testi più deprimenti sono spesso anche quelli più euforici.
-
Mi sembra necessario sottolineare questa distanza rispetto alle posizioni e alla poetica di Ai nostri amici per meglio trattare la questione centrale del libro, quella dell’organizzazione intesa come percezione comune (p. 7). Non si critica certo un manifesto o un appello, soprattutto quando non è destinato a te; ciononostante si può fare qualcosa dei momenti di assenso e dissenso che suscitano tali affermazioni. Ora, anche se l’essenziale di questa percezione non è condivisa, siamo senza dubbio d’accordo sui termini della questione: che cosa significherebbe il forgiare una percezione comune? Per il Comitato Invisibile, l’organizzazione che mancava alle insurrezioni del 2011 e degli anni seguenti non è quindi un partito, un sindacato o una forza armata ma una percezione (il Comitato non riconoscerebbe volentieri la somiglianza ma su questo punto la distanza non è poi tanto grande rispetto alla traduzione dell’organizzazione in idea che fa Badiou o, su un altro registro, con la cartografia cognitiva di Jameson – due versioni della coscienza di classe senza classe). Una percezione comune, ecco le nozze dell’etica e della strategia. È difficile non sentire l’eco dell’ultimo sconfitto Debord, che scopre attraverso le lenti di Clausewitz la riproduzione cospiratoria dello spettacolo (nei Commenti) e che misura i danni causati alla vita e all’ethos (nel Panegirico). Ma, contrariamente a quella di Debord, la negatività di Ai nostri amici è più epidermica. Perché scrivere altrimenti una frase così disarmante come “l’intelligenza strategica viene dal cuore” (p. 7) ? Questo desiderio di una vita altra è più profetico che dialettico. In compenso, le prospettive archipolitiche di una rivolta etica globale rischiano di sommergere ogni considerazione strategica, ogni taratura tattica. “Quello che è in gioco nelle insurrezioni contemporanee è la domanda di sapere che cos’è una forma desiderabile della vita, e non la natura delle istituzioni che la dominano. Ma riconoscerlo implicherebbe immediatamente di riconoscere la nullità etica dell’Occidente” (p. 21). Di sicuro una forma di vita non può essere strappata alle sue istituzioni, a meno di non finire nell’immediatezza vitalistica che è sempre stata la grande tentazione dell’anticapitalismo romantico. E se “l’Occidente” (qualunque cosa esso sia) non è che un grande vuoto dal punto di vista etico, bisognerà premunirsi dal rischio di riattivare un discorso politico e filosofico che prende in prestito non solo grosse parti di una grammatica e un’etica distintamente occidentali, ma che rifiuta in più di sottometterle a una negazione decisa. Opporre la “verità etica” (p. 21) alla democrazia – non è forse anch’esso un concetto “occidentale”? (È ciò che suggerisce, per esempio, una seducente opera di Eduardo Viveiros de Castro, The Inconstancy of the Indian Soul). Ed è precisamente nella misura in cui le insurrezioni attuali non hanno, tranne che di sfuggita, dato luogo a nuove istituzioni che hanno lasciato la vita nuova allo stato del desiderio, ossia, della mancanza.
-
Così quest’ “altra idea della vita” (p. 22), rischia di restare nient’altro che un’idea, della felicità e della buona vita, astratta quanto quella del comunismo. Forse non abbiamo perso il mondo ma ciò che è certo che abbiamo perso molta dell’economia morale suscettibile di dare presa a un’opposizione etica. Ecco perché stupisce che la questione del come produrre, inventare, fare esperienza di altri modi di vita, riceva relativamente poca attenzione in queste pagine – al di là delle multiple indicazioni di luoghi dove quest’altra vita potrebbe essere faticosamente costruita (nella lotta contro la linea ad alta velocità Torino-Lione, in val di Susa; in quella contro l’Aeroporto del Grand-Ouest, à Notre-Dame-des-Landes, etc.). Troppo rapidi nell’incorporare la negatività generale al loro progetto, Ai nostri amici afferma che la denuncia ricorrente della “corruzione” è rivelatrice di questa svolta etica dell’antagonismo (p.22). Però, come lo ricorda il provocante discorso contro l’etichetta di “indignato” derivato dallo spagnolo indignado (“Egli postula la propria impotenza, in modo da potersi meglio sottrarre a ogni responsabilità circa il corso delle cose; poi la converte in affetto morale, in affetto di superiorità morale. Crede di avere dei diritti, il poveretto.” p. 24), ciò potrebbe essere una sorta di esorcismo un modo di chiamare “noi stessi” fuori dalla decadenza morale e finanziaria del presente, di adottare la postura della semplice vittima.
-
Ma qualcosa di più preciso e più grave si gioca in queste pagine, mentre distillano con acume combattivo ciò che è al cuore della critica insurrezionalista al movimento delle piazze: la critica del feticcio della democrazia. Alcuni passaggi sono di una forza rinvigorente, come quando il Comitato ci ricorda che “popolare” viene da populor, “devastare, distruggere” (p. 23), che un sollevamento è una pienezza di espressione e un nulla di deliberazione. Il disprezzo in cui è tenuto quest’ultimo termine (al quale si sostituisce la comunicazione non-strumentale dell’amicizia, con degli accenti che ricordano Maurice Blanchot) indica l’aspirazione, al di là dell’indeterminazione illusoria della prima persona plurale, a dividere il “noi” tra il distacco antagonista da un parte e un’impasse piccolo-borghese dall’altra. Indubbiamente, nella misura in cui la filosofia spontanea del “movimento delle piazze” è, nei suoi momenti di non-scontro, largamente “democratica”, ciò crea le condizioni per un’altra “guerra civile”, una lotta tra differenti nozioni del popolare. È un peccato che Ai nostri amici decida di castigare Hardt e Negri, o Hessel, o ancora il senso comune politico delle “assemblee”, piuttosto di affrontare le vere strade politiche del riformismo radicale contemporaneo, come Syriza o Podemos. Perché, in fin dei conti, sono questi i suoi veri nemici, visto che impongono una strategia politica, fondata sulla democrazia e la deliberazione, che non può che fare da ostacolo allo sbocciare dell’altra vita, all’irruzione della vita etica. In effetti, dal punto di vista del Comitato, come potrebbe un tale incanalamento del rifiuto in progetto di potere significare altro che un disastro? La piazza si è divisa in due? Da una parte “il crash sul reale del fantasma cibernetico di una cittadinanza universale”, dall’altra “un eccezionale momento di incontri” (p. 25). Il pragmatismo pedante e “micro-burocratico” sia esso trotskista o anarchico contro i partigiani della rivolta etica. La fenomenologia negativa delle assemblee, con la sua scura e vivida ironia, è qui assunta a testimonianza di un’esperienza vissuta di disimpegno e frustrazione.
-
La diagnosi è esistenziale: il feticismo dell’assemblea generale e l’affezione politica dell’indignazione, espresse nel “linguaggio informe della vita separata” (p. 26), vengono dal fatto che un’assemblea non può far emergere altro che ciò che già contiene, e se ciò che essa contiene è la “vita” postmoderna, in serie e mutilata, allora essa produrrà solo impotenza collettiva. E tuttavia, se le piazze sono due cose in una, allora ad ogni parossismo d’isteria democratica pseudo-antagonista rispondono i germogli di una nuova vita, capaci di “abitare persino l’inabitabile” metropoli (p. 26), di dimorare. Questi movimenti e insurrezioni non ottengono le loro vittorie nelle ansie della democrazia diretta ma nell’auto-organizzazione della vita quotidiana. Una volta di più, le conclusioni da tirare sono d’ordine metafisico, come l’indica l’insistenza sull’abitare – che ricorda più l’heideggerianismo di sinistra che le utopie pratiche dell’abitazione di un Lefebvre, il cui libro Vers une architecture de la jouissance è stato da poco pubblicato. Quest’ansiosa coazione a ripetere che è il voto è superata da “un’attenzione inedita per il mondo comune”, che riceve una sorta d’imprimatur filosofico: “un regime di verità, di apertura, di sensibilità verso ciò che è presente.” (p. 27). È interessante vedere come la presa in carico collettiva dei compiti necessari alla riproduzione sociale (ovviamente non tutte, non abbiamo visto i manifestanti occuparsi delle fogne, dell’acqua corrente né delle diverse ramificazioni dello Stato logistico) è trattata qui come il segno materiale di un presente rivoluzionario. Forse c’è una specificità “occidentale” in questo stupore davanti all’auto-organizzazione, ma questo stupore non ha, in fin dei conti, granché di filosofico se ci induce a ignorare che questo “comunismo di movimento” (per riprendere il termine utilizzato da Badiou a proposito dello stesso fenomeno ne Le Réveil de l’Histoire) è politicamente indeterminato. La riproduzione sociale e l’autodifesa sono parte anche dell’agire dei militanti di estrema destra o delle correnti religiose conservatrici (l’abbiamo visto da Maidan a Tahrir) e, a meno di non considerare che sia fonte di emancipazione in sé il fatto riprendersi ciò di cui lo Stato ha fatto monopolio, bisognerà forse riconoscere che né l’etica, né la riproduzione, ne (a fortiori) la “vita”, possono a rendere obsoleto il momento politico, e la deliberazione – che ovviamente non è riducibile a delle assemblee inutili dove si agitano le mani in aria.
-
La verità della democrazia, ci dice il Comitato Invisibile, non è né lo Stato né la legge, ma il governo. Nell’orizzonte politico-metafisico di Ai nostri amici, la democrazia è la “verità” di ogni forma di governo, nella misura in cui l’identità del governante e del governato è il governo “allo stato puro”. Il presente costituirebbe quindi una sorta di apoteosi dell’ordine cibernetico già solidamente teorizzato da Tiqqun. Il fatto che questo “grande movimento di fluidificazione generale” (p. 29) sia condizionato dagli imperativi dell’accumulazione resta su uno sfondo distante, al punto che sospettiamo che a volte ci sia all’opera un destino d’ordine propriamente ontologico e che ogni potenza agente si sia volatilizzata. Invocando il potere più di quanto lo teorizzi, il Comitato solleva comunque una questione estremamente urgente e dolorosamente concreta: come hanno potuto i rivoluzionari, in Egitto, in Tunisia e altrove, essere “fregati” dalle forze politiche dominanti, trasformati in mediatori evanescenti, retroattivamente ridotti a soldatini di piombo per i regolamenti dei conti dentro i corridoi del potere? La risposta è tristemente semplice: esigere una destituzione (del potere in carica) senza avere la forza di organizzarla significa condannare se stessi e il processo di destituzione ad essere manipolati dalle forze organizzate. Ossia, per riprendere l’elegante aforisma del testo, “Un movimento che esige finisce sempre per avere la peggio di fronte a una forza che agisce” (p. 30). In maniera ancora più acuta, il Comitato propone di abbandonare la “finzione” di una dialettica tra potere costituente e costituito, nel quale l’atto popolare della destituzione potrebbe essere assorbito in una dinamica di legittimazione, eludendo in questo modo “l’origine sempre sordida del potere” (p. 31). (potremmo notare qui come l’abbandono di ogni dialettica di questo tipo, e di ogni concezione del potere legittimo annulla tutte le concezioni esistenti della rivoluzione, anche nelle loro versioni anarchiche. Gli autori, per ragioni forse più estetiche o etiche che propriamente politiche, insistono tuttavia a chiamarsi rivoluzionari). La conclusione è senza appello: “Quelli che hanno preso il potere retroproiettano sulla totalità sociale, che ormai controllano, la fonte della propria autorità e così la faranno legittimamente tacere, in suo nome” (p. 31)
-
Abbandonare la dialettica del costituente e del costituito, nella sua ipostasi delle forme contingenti di governo (la Repubblica) equivale quindi a ripensare la rivoluzione come pura destituzione – come ciò che priva il potere del proprio fondamento senza crearne uno nuovo (“potere destitutente” rappresenta in qualche modo l’ultima parola di Agamben sull’ Homo Sacer, il punto d’approdo de L’uso dei corpi, ultimo volume di quest’autore la cui influenza è in queste pagine palpabile). L’insurrezione è qui un grande rivelatore, che rende visibile simultaneamente il vuoto metafisico del potere e il suo attuale radicamento nei vili particolarismi del controllo poliziesco e del privilegio. Gli autori non sembrano trovare paradossale di fatto di legare il movimento heideggeriano della loro anti-storia dell’Occidente con questa conclusione quasi degna di un Durutti: “Tutte le carogne hanno un indirizzo. Destituire il potere, significa riportarlo sulla terra.” (p. 32). Ma la destituzione del potere governante è anche quello del potere popolare. Uno dei corollari di quest’approccio, e non di secondaria importanza, è l’appello “rinunciare alla nostra legittimità” (p. 32). È una sfida acuta, che implicherebbe come minimo una veglia consapevole sulla facilità con la quale movimenti che dovrebbero essere anti-sistema riproducono e talvolta rivitalizzano le coordinate stesse del proprio assoggettamento.
-
Ma il Comitato non obbedisce alla sua stessa ingiunzione. Piuttosto, sposta continuamente la sede della legittimità, ossia della verità, dal pratico al metafisico. Da ciò che chiama il suo “altro piano di percezione” (p. 33), afferma che il problema del governo, e delle antropologie negative che implica, non può essere posto che quando un vuoto è stato creato tra gli esseri. Uscire dal paradigma del governo, è entrare in quello “dell’abitare”, un’ontologia relazionale della pienezza nella quale “ciascuno di noi è il luogo di passaggio e di tessitura di una quantità di affetti, allineamenti, storie, significazioni e flussi materiali che ci eccedono. Il mondo non ci circonda, ci attraversa. Ciò che abitiamo ci abita.” (p. 33). L’organizzazione e la strategia riverrebbero quindi, in ultima istanza, al passaggio ad una Gestalt che ci permetta di cessare di vedere cose, soggetti, soggetti e corpi, e cominciare a vivere attraverso forze, potenze e legami: “È grazie alla loro pienezza che le forme di vita compiono la destituzione” (p.33). Da parte di un collettivo dalla critica così caustica, lascia perplessi constatare che il Comitato Invisibile non sembra rendersi conto fino a che punto si accodi così ad una tendenza contemporanea fin troppo diffusa: negare l’autonomia del politico, per meglio accordare questa stessa autonomia a una vita e a un essere politicamente equivoci. Potremmo concluderne che, ben lontano dal rinunciare alla propria legittimità, il Comitato l’ha ipostatizzata, nella vita stessa.
-
Si apre, come gli altri capitoli, con la fotografia di un graffito – proveniente dalla Val Susa e che dice “Il potere è logistico. Blocchiamo tutto” – la sezione dedicata al potere infrastrutturale. Si tratta del cuore strategico del libro, e forse del capitolo che subisce meno l’ipoteca della vita insurrezionale. Mai a corto di grandi declamazioni generalizzanti, il Comitato comincia abbordando gli atti insurrezionali dal 2011, altrettanti assalti contro i simboli del potere difesi dalle “forze dell’ordine” con una ferocità che gli autori credono essere inversamente proporzionale alla loro importanza “il potere non risiede più nelle istituzioni” (p. 35). Esse, infatti, non sarebbero più che delle delle vere e proprie “trappole per rivoluzionari” (p. 35). Al che potremmo far notare che quindi il potere simbolico non è completamente sparito. O, invece, che il carattere “teatrale” del potere è in riflusso da tanto tempo, diciamo anche da secoli. Delle periodizzazioni forti sono indispensabili per far emergere una percezione comune ma la tesi di un passaggio dalle istituzioni alle infrastrutture è parecchio disorientante da un punto di vista storico. Non solo le istituzioni dello Stato sono sempre state dipendenti da un potere infrastrutturale – dai dibattiti sulle basi idrauliche del “dispotismo asiatico” fino alla brillante esplorazione di Robert Linhart delle tragedie logistiche del bolscevismo in Lenine, les paysans e Taylor – ma inoltre, le infrastrutture contemporanee, dalla metropolitana al trasporto intermodale, sono delle istituzioni, saturate di burocrazie, strumenti di misura, agenzie, riti, lobbisti e così di seguito. Non si fanno né si governano da sole. Possiamo senz’altro riconoscere l’importanza della questione delle infrastrutture nelle recenti strategie del potere e dell’opposizione – come anche nei recenti riaggiustamenti dei modi di produzione – senza doverne concludere che il potere istituzionale-rappresentativo non è più che una cortina di fumo. In un passaggio come quello che segue, la logistica, come l’auto-valorizzazione del capitale per i teorici del valore o la polizia per gli anarchici, può diventare un vero feticcio: “Il potere contemporaneo è di natura architettonica e impersonale e non rappresentativa e personale” (p. 35). (Immagino che possiamo quindi scordarci degli indirizzi delle carogne; in fondo contano poco). Le descrizioni particolari smentiscono la narrazione epocale. La localizzazione di un potere puramente cibernetico, senza altri segreti che quello del suo funzionamento, immanente ad apparati come “la pagina bianca di Google”, diventa allora luogo… di decisioni politiche: “Chi determina la configurazione dello spazio, chi governa gli ambienti e le atmosfere, chi amministra le cose, chi gestisce gli accessi – governa gli uomini” (p. 36). Ben detto, ma non c’è nessuna regione di considerare questo potere trascendente rispetto alle istituzioni (lo vediamo, se non altro, seguendo il racconto che propone Donal McKenzie della genesi materiale e giuridica delle transizioni finanziarie ad alta frequenza o algoritmiche). Ciò vale anche per il modo in cui la “governance” contemporanea del capitale produce “zone” al di là della nazione, sottomettendo così anche la nozione stessa di “società” a una brutale fluidificazione (p. 39).
-
Detto ciò, Ai nostri amici effettua una sintesi abile del sentimento che impregna le lotte contemporanee e che si potrebbe designare come l’esigenza di un materialismo politico che prenda l’infrastruttura come campo e obiettivo “Chi vuole intraprendere qualcosa contro il mondo esistente deve partire da questo dato di fatto: la vera struttura del potere è l’organizzazione materiale, tecnologica e fisica di questo mondo” (p. 36). Ma non vedo la necessità, se non per ragioni retoriche, di dichiarare immediatamente dopo “il governo non è più nel governo” (p. 36). Ciò potrebbe essere vero se la questione fosse di dissipare le tenaci illusioni politiche che trascurano la materialità e l’economia politica dello Stato. Ma è impossibile comprendere (e intervenire nelle) le infrastrutture senza misurare quanto l’organizzazione materiale, tecnologica e fisica del mondo richieda anche un vasto arsenale di operazioni istituzionali, e non semplicemente un piccolo numero di operazioni governamentali. Trascurare il fatto che il diritto e la politica sono costitutivi di questo potere infrastrutturale sarebbe una errore strategico madornale. La “costituzione politica” non collima senza resto con la “costituzione materiale”.
-
Ai nostri amici mobilizza il concetto di potere infrastrutturale per rendere conto dello spostamento contemporaneo del dominio dal simbolico all’ambientale, mentre il controllo della polizia è accelerato nella sua pervasività per diventare precisamente il guardiano di un potere che mente, per così dire, su tutto il network. Uno dei pregi, e non è poco, dell’attenzione del Comitato, della sua percezione di questa “rivoluzione logistica” delle arti del dominio, è il suo modo di chiarire le impasse nelle quali entrano molte delle rivolte contemporanee. Come osservano laconicamente: “non si critica un muro, lo si distrugge o lo si tagga (p. 36). È nello scontro con l’omogeneità rotta della metropoli, “deserto e anemia esistenziale” (p. 37), che emergono i luoghi della gioia comune (Gezi, Puerta del Sol, etc.) nei quali possiamo sperimentare il “legame intuitivo tra autorganizzazione e blocco.” (p. 38). Ma il paesaggio del capitale si è trasfigurato anch’esso, visto che la fabbrica, questa prigione-fortezza operaia, è diventata un “sito”, un anello logistico. In qualche pagina lapidaria (pp. 38-39), gli autori provano a riassumere e congedare una larga parte del dibattito marxiano, generalmente cristallizzato intorno al secondo volume del Capitale e nei passaggi sul “general intellect” nel Grundrisse. Sarebbe malvenuto di lanciarsi in questa sede in esercizi filologici ma non è inutile far notare che la solo conclusione politica di tutto questo – a parte quella dell’obsolescenza della teoria del valore – è quella dell’indistinzione tra sfera della produzione e della riproduzione. È un’ironia della dialettica, non colta dagli autori del testo, che i cambiamenti infrastrutturali prodotti come risposta strategica alla lotta di classe – in particolare per frammentare il potere dei lavoratori della logistica e dell’estrazione – dovessero dare luogo ad una condizione di totalità espressiva, dove ogni attacco logistico costituisce un attacco al sistema nel suo insieme.
-
“Attaccare fisicamente questi flussi in un punto qualsiasi significa quindi attaccare politicamente il sistema nella sua totalità” (p. 39). Affermazione incoraggiante, ma poco convincente. Un sistema può essere solo politicamente attaccato nella sua totalità, quando esiste un’intenzione o (preferibilmente e) un effetto totalizzante. Ora, questi sistemi reticolari sono strategicamente concepiti per minimizzare il contagio, e si appoggiano sulla frammentazione del lavoro e la massimizzazione della resilienza, almeno altrettanto che sull’omogeneità delle norme e dell’intermodalità: nulla permette d’affermare che bloccare un flusso significhi bloccarli tutti. Il Comitato ci esorta a percepire ogni tentativo di “bloccare il sistema globale, ogni movimento, ogni rivolta, ogni sollevazione, come un tentativo verticale di arrestare il tempo e di biforcare in una direzione meno fatale” (p. 40). Un’impressionante immagine benjaminiana che sfortunatamente perde in chiarezza esplicativa ciò che guadagna in entusiasmo, perché non abbiamo visto tentativi di bloccare il sistema globale come tale (quale che sia il senso che si possa dare a quest’espressione…), e soprattutto perché una tale visione metafisica di rivolte espressive trascura la questione strategica di come le rivolte logistiche potrebbero diventare effettivamente rivolte contro il sistema. Presupporre che i blocchi siano già antisistemici di per sé significa non solo ignorare la storia del loro utilizzo tattico da parte di movimenti perfettamente “riformisti” (o addirittura reazionari, come negli scioperi dei camionisti in Cile, ai quali il governo Allende aveva risposto con… un sistema cibernetico), ma anche cedere alla fantasia che una tattica possa, in quanto tale, costituire una strategia. Tra l’altro, più il là all’interno del libro, gli autori apportano una netta rettifica a questo passo falso: “il sabotaggio è stato infatti praticato dai riformisti così come dai nazisti” (p. 60).
-
Il capitolo sui blocchi si chiude con delle ingegnose riflessioni sulla questione del sapere. Partendo da una prospettiva molto classica, che attribuisce la debolezza delle lotte all’assenza di prospettive rivoluzionari credibili (e non il contrario), il Comitato postula che il problema presente sia quello di una strategia rivoluzionaria che non abbia come obiettivo solo i rappresentanti del potere ma il “funzionamento generale della macchina sociale” (p. 40), da cui dipendiamo per la nostra sopravvivenza. Qui, la riflessività negativa della lotta (siamo i nostri propri nemici) assume una curvatura materiale (il nostro nemico è il nostro sostentamento) e pone una domanda pratica, sperimentale: come disconnettersi dal potere infrastrutturale senza correre il rischio di una penuria paralizzante? In altri termini, come il sabotaggio può non ritorcersi contro sé stesso? La severità e la sobrietà dell’affermazione seguente sono le benvenute: ”finché non sapremo come fare a meno delle centrali nucleari e il loro smantellamento sarà un business per gli stessi che le vogliono eterne, aspirare all’abolizione dello Stato continuerà a far sorridere; finché la prospettiva di una sollevazione popolare significherà una sicura penuria di cure, di cibo o di energia, non esisterà un deciso movimento di massa” (p. 40). Da lì, l’appello a ritornare all’inchiesta come strumento che unisce strategia, sapere e ricomposizione politica (ed etica). Come lo scrive il Comitato: “non ha senso saper bloccare l’infrastruttura dell’avversario se non sei capace di farla funzionare, in caso di necessità, a tuo vantaggio” (p. 41). Curiosamente, il tono moralista dei riferimenti precedente alla vita buona qui sfuma, rimpiazzato da una visione più attraente di un’altra forma di vita fondata sulla “passione della sperimentazione”, su una “passione tecnica” e sulla “accumulazione di saperi” (p. 40), senza la quale non ci può essere nessun serio ritorno della questione rivoluzionaria. È forse rivelativo delle inversioni che segnano il nostro presente che il passaggio più realista e materialista di questo pamphlet, l’appello ad “aggregare tutta l’intelligenza tecnica in una forza storica e non in un sistema di governo” (p. 41), e a uscire quindi dall’ignoranza profonda delle nostre condizioni materiali, sia anche quello che suona più utopico.
-
Se le infrastrutture materiali ed energetiche della riproduzione del capitale possono essere oggetto di una riappropriazione (almeno parziale), quelle del “capitalismo comunicazionale”, ossia Facebook e Google, non sono invece che il prodotto più dannoso dell’appetito dei dirigenti per la cibernetica. Alcune di queste pagine, consacrate all’idraulica militare e finanziaria di internet, potrebbero essere lette di gusto se non si rivelassero, in fine dei conti, ridondanti, l’eco di una semplice critica di buon senso – critica che non impedisce ovviamente (quasi) nessuno di riprodurre (sé stessi attraverso) questi dispositivi di speculazione e sfruttamento. Immaginare che la miseria della cibernetica sia ciò che la farà crollare davanti alla “presenza”, non è forse cullarsi in un’illusione? Più stimolante, anche se schematica, è la tesi antropologica secondo la quale i social network rivelano il sorpasso della tecnica da parte della tecnologia, definita come “espropriazione degli umani delle loro diverse tecniche costitutive” (p. 52). Nella prospettiva di questo lungo pastiche heideggeriano, se l’ingegnere è l’espropriatore della tecnica per eccellenza, l’hacker incarna il lato “etico (nel senso di ethos) della tecnica. È la figura della sperimentazione come prova vissuta delle implicazioni etiche di una data tecnica. Nonostante i ripetuti appelli ad abbandonare l’Occidente, questa etica della conoscenza suona nettamente illuministica: capire il funzionamento degli apparati che abbiamo intorno, forzare l’apertura della scatola nera, porterebbe a un “immediato accrescimento di potenza” (p. 52). Il comitato presta comunque attenzione a non tirarsi dietro gli assunti regressivi dell’individualismo libertariano e, partendo da una digressione sulle affinità etimologica tra le parole “friend” e “free”, ci viene detto che la libertà dell’hacker è collettiva, transindividuale: “Sono libero perché sono legato” (p. 53). Gli hacker dovranno sacrificare il feticcio della libertà slegata (e della libertà di espressione) se vogliono – ma lo vogliono? Vogliamo che lo vogliano? – “divenire una forza storica” (p. 53).
-
Più andiamo avanti nel testo, più l’appello a una percezione comuna e l’elenco dei miraggi si amplificano. Anche se può sembrare contraddittorio con l’insistente rivendicazione della verità etica, Ai nostri amici non è solo una critica delle ideologia dei movimenti recenti ma anche l’appello a un’altra ideologia. I frutti rari e amari delle impressionanti mobilitazioni in Grecia ci insegnano che “senza un’idea sostanziale di quello che significa una vittoria siamo destinati alla sconfitta” (p. 57). Dopo una digressione azzardata sulle “origini” della politica nella Grecia antica, veniamo al ripudio del paralizzante faccia a faccia tra radicalismo e pacifismo. Né strategica né congiunturale, l’analisi qui è interamente filosofica. La guerra non è “il massacro, ma la logica che presiede al contatto tra potenze eterogenee” (p. 58). Una definizione disincarnata, metafisica, che ha come obiettivo di stabilire l’assurdità del desiderio di escludere la guerra dal socius. Ma se non si parla di massacri, in quantità industriale o anche artigianale, perché non parlare semplicemente di “conflitto” o di “agonismo” – come fanno tanti altri teorici politici? È ancora la ricerca di un brivido extra di autenticità che sta dietro all’evocazione ripetuta della guerra civile? Nonostante la debolezza dello slogan, i ritratti del pacifista e del radicale sono eseguiti con maestria, soprattutto quello del radicale, col suo elogio ideologico della violenza, il suo trascurare la strategia e la sua privatizzazione dell’attivismo come “occasione di valorizzazione personale” (p. 60). (Tutti i lettori avranno senza dubbio potuto riunire una larga selezioni di questi personaggi “radicali” nel proprio teatro mentale). La fenomenologia del “piccolo terrore” che regna negli “ambienti radicali” porta a osservazioni di un realismo quasi doloroso: “Una vertigine prende a posteriori chi ha disertato questi circoli: come ci si può sottomettere a una pressione così mutilante per degli scopi così enigmatici?” (p. 60). Contro la “politica extra-terrestre” del radicale, che ha la pretesa di apportare un’illuminazione dall’alto e dall’esterno, Ai nostri amici gioca di nuovo la carta del “l’attenzione” – tema promettente, anche se problematico, perché dipende da un’immagine assai vaga della “sensibilità” del rivoluzionario, dalla produzione di atti che si situano leggermente “in anticipo” sui movimenti ma la cui pertinenza è decisa dallo stato del movimento stesso. (Per inciso, è strano che autori così attaccati all’idea della guerra civile ricaschino così facilmente nella vulgata di sinistra parlando “del movimento”).
-
“La vita è essenzialmente strategica” (p. 62). Questa dichiarazione non dovrebbe sorprenderci. Arriva in effetti qualche pagina dopo la mobilitazione dell’ingombrante metafora marziale del sistema immunitario e della ricerca di una fusione tra strategia ed etica. Più sorprendente, forse, è il fatto che gli autori cerchino negli archivi della contro-insurrezione contemporanea i mezzi per sviluppare un “concetto civile della guerra” (p. 62). È sicuro che non c’è nulla di male nel voler imparare dal nemico, ma le lunghe citazioni senza commento sembrano un’occasione persa per analizzare fino in fondo (nel solco dei lavori di Laleh Khalili e di altri) il ruolo assolutamente cruciale degli assi di genere e di razza nella sociologia della contro-insurrezione e di chiedersi quindi come queste identità e risorse potrebbero essere neutralizzate o mobilizzate in una politica “civile” della guerra. Presentare “l’epoca” (perché uno dei principali obiettivi di questo libro, come del precedente, è di affermare senza ambiguità che ciò che stiamo vivendo è senz’altro un’epoca) come una corsa tra “la possibilità dell’insurrezione e i partigiani della contro-insurrezione” (p. 65) significa inoltre mettere da parte il carattere quotidiano della riproduzione sociale e della sua logistica, e la guerra di bassa intensità che accompagna l’organizzazione dello sfruttamento e dell’esclusione; significa, in fondo, appoggiarsi in maniera troppo pesante sugli scenari d’insurrezione globale che condiscono i rapporti della CIA e di altre entità del genere – che dopotutto dipendono dalla produzione di tali scenari per presentare come indispensabili sé stessi e i propri complessi industrial-militari. È comunque rincuorante vedere gli autori attenti alla tentazione di trasformare le teorie contro-insurrezionali in teoria insurrezionali. La loro proposta alternativa resta però gnomica, anche se suggestiva: “Abbiamo bisogno di una strategia che non prenda come obbiettivo l’avversario ma la sua strategia e che quindi la ritorca contro essa stessa” (p. 65).
-
Il problema è che questo aforisma, la cui premessa implica una “asimmetria ontologica” tra gli esperti dell’insurrezione e della contro-insurrezione , è basata su di una profonda sovrastima della minaccia che questi ultimi rappresenterebbero per il potere. “Noialtri rivoluzionari siamo allo stesso tempo la posta in gioco e il bersaglio di questa offensiva permanente alla quale ormai si riduce il governo” (p. 67). Una minaccia temporanea, certo, un fastidio permanente, sicuro, ma il bersaglio? C’è da dubitarne parecchio – come c’è da dubitare dell’affermazione ulteriore secondo la quale la contro-rivoluzione globale che ha preso per “pretesto” l’11 settembre sarebbe stata in realtà una risposta politica ai movimento “no-global”, la cui anatomia tuttavia è presentata nel libro come di un movimento della piccola borghesia planetaria, sparita grazie al suo realizzarsi (pp. 93-94). In questa proiezione immaginaria del “noi”, Ai nostri amici rischia di cascare in una delle trappole retoriche di quello stesso settarismo a cui cerca di sfuggire – l’idea che il potere non è altro che una formazione reazionaria contro di noi e la formidabile minaccia che rappresentiamo. Ma la riproduzione della società capitalista è ben meno tortuosa e marziale di così, e le sue violenza, per quanto profonde, sono più dilatate. Trattare tutta la vita sociale come un campo di battaglia può anche essere galvanizzante ma resta un errore. È più interessante – perché meno metafisico e più strategico – l’avvertimento quanto al pericolo di lasciare il governo produrci come soggetti radicali (che sia come “IRA” o come “Black-bloc” per riprendere gli esempi del libro), come anche il ricorso inatteso all’immagine “diffusa” e irriducibilmente plurale (pp. 69-70) che ci trasmette la resistenza palestinese. Ciononostante, il testo torna rapidamente su quel retroterra di legittimità che sarebbe la “vita” dalla quale (per citare una delle frasi più discutibile del libro) “emana l’identificazione del nemico, le strategie e le tattiche”. E quindi la strategia collassa in un cliché “abitare pienamente, ecco quello che si può opporre al paradigma del governo” (p. 69). Detto ciò, la traduzione più demotica di questo passaggio contiene un momento di verità che non è certo trascurabile: “Chi ha dei rapporti di merda non può fare che una politica di merda” (p. 69).
-
Quanto a politica, quindi, l’uomo abita. Ma dove? In un “locale” che ripudia ogni “localismo” – il Comitato critica implacabilmente e giustamente questa sempreverde tentazione –, nella vita quotidiana dei territori in lotta che tirano la propria consistenza dalle lotte stesse. Con disinvoltura saremmo tentati di vederci – riferendoci alla pratica guevarista teorizzata da Régis Debray – un foquismo senza partito, senza esercito, senza giungla. Più che localismo, localizzazione quindi, questa attività di cartografia cognitiva che consiste nel “seguire le connessioni di una sala della borsa fino all’ultima delle sue fibre ottiche” (pp. 79-80) che corona la questione politica del blocco e della contro-logistica. Quando prende come bersaglio le ideologie della sinistra contemporanea, il Comitato mira spesso giusto e la sua presa di distanza dal modo in cui le “lotte locali” sono spesso usate a conferma di un comunitarismo e di un comunismo soggiacenti (interpretazione di cui possiamo dire che il Comitato non si sia completamente liberato) fa centro. Ma la strada proposta per evitare queste trappole ideologiche è di un’astrazione estrema che si pretende di un’estrema concretezza: “la vita vivente” (p. 80), “l’esperienza” delle relazioni, delle amicizie, delle vicinanze e delle distanze. Possiamo fidarci fino a questo punto dell’esperienza? Non è una fantasia paralizzante di pensare che tutte le nostre esperienze debbano essere portate nella lotta, che tutta la vita è “in comune” – fantasia che può diventare noiosa o sinistra quando queste esperienze comuni vengono elevate al rango di istituzioni, rituali, strutture? (E come potrebbe esserne altrimenti, a meno di pensare che la politica possa essere radicalmente de-strumentalizzata, de-reificata per diventare un flusso ininterrotto d’immediatezze?)
-
Per quanto ciò possa repellere gli autori, c’è un’istituzione che si promuove nel libro, quella della comune. Non una forma di governo, non un corpo politico ma un’istituzione, definita dagli autori stessi come “il patto di affrontare insieme il mondo” (p. 83) e da un punto di vista più ontologico come “una qualità del legame e una maniera d’essere nel mondo” (p. 84). I riferimenti impliciti sono qui numerosi: non solo al 1871 ma anche a Huey P. Newton, Gwangju, Gustav Laundauer. La grammatica spaziale utilizzata è impressionante: la comune è “un certo livello di condivisione inscritto territorialmente” (p. 84). La guerra continua contro l’astrazione quantitativa e calcolatrice: “Con la sua sola esistenza rompe la suddivisione ragionata dello spazio” e “si pensa innanzitutto come rottura concreta, situata, con l’ordine globale del mondo” (p. 84). L’ombra della totalità espressiva aleggia ancora su questo passaggio, il cui presupposto metafisico è che una rottura radicata è anche planetaria. Il che è curioso se pensiamo al fatto che il globale, il planetario, è il prodotto dell’astrazione, della scienza, del capitale e del colonialismo. Abitare il globale, ecco ciò che sembra in contraddizione. (E la comune potrebbe anche essere vista come un’astrazione di forme di comunalità irriducibili tra di loro, che potrebbero esser rappresentate come universali solo dal cuore stesso dell’astrazione). La soluzione risiederebbe in un federalismo eterodosso: la comune deve allo stesso tempo essere saldamente legata a una realtà territoriale eterogenea rispetto al sistema e tessere legami e solidarietà con altre realtà locali, altrimenti si trasformerebbe in enclave sterile e assediata o si perderebbe in un erranza senza meta. La comune qui non è quindi, chiaramente, prendersi carico del comune, nuova forma giuridica di appropriazione, per quanto egualitaria: è “una forma di vita comune”, una relazione comune a “ciò che la traversa senza che possa mai appropriarsene”, le res communes, il “mondo” stesso. È anche un tentativo di abolire i bisogni nati dalla privazione del mondo (come lo indica l’antropologia universale dagli accenti rousseauiani degli autori) a beneficio di una profusione dei mezzi. In questo orizzonte gioiosamente opposto a ogni materialismo storico, la produzione non è più che un sotto-prodotto del “desiderio di vita comune”. Ribaltando lo slogan cinese, potremmo dire: “la produzione dopo!”. La “fecondità”, che costituisce ciò che organizza la comune al di là dell’economia e dello scambio, viene prima. È ciò che permette al Comitato di dire con entusiasmo “possiamo organizzarci e (…) questa potenza è fondamentalmente gioiosa” (p. 91). La vita comune, in quanto vita della comune, replica ancora una volta la struttura espressive che attraversano Ai nostri amici: “In ogni dettaglio dell’esistenza ne va dell’intera forma di vita” (p. 90). (Che ci si perdoni il trovare questa vita senza sosta propizia alla claustrofobia e al superegoismo).
-
Al momento della conclusione strategica, come tanti testi di sinistra, Ai nostri amici si fa vago e allusivo. (sarebbe un interessante esercizio di iconoclastia militante di ritagliare gli ultimi paragrafi di tutti i componimenti anarchici e marxisti. Un’antologia di tali paragrafi sarebbe di certo impossibile da digerire). In assenza di un bersaglio determinato, è ancora una volta verso la concretezza della “vita”, del “dove siamo” che si rivolge il testo, verso la promessa empirica delle inchieste, delle cospirazioni e delle consistenze locali, verso le alleanze come questione generale che prende qui l’interessante forma della traduzione. Quando si pone la questione di costruire una forza che non sia un’organizzazione, riveniamo di nuovo alle astrazioni, calorose e concrete certo, ma che restano astrazioni – il cui valore politico è, d’altra parte, difficilmente valutabile in maniera univoca: la crescita della “potenza”, come sito della “disciplina” e della “gioia”; le diverse proporzioni dello “spirito”, della “forza” e della “ricchezza”, la cui gestione prudente deve permettere di evitare disproporzioni fra l’avanguardia armata, la setta dei teorici e l’impresa alternativa (p. 98). La felicità è più o meno l’ultima parola del libro e, come tutte le verità etiche che non sono legate a delle forme di vita, anch’essa non può che lasciarci inappagati o suonare un po’ vuota, a meno di diventare lo schermo su cui proiettare lo spirito, la forza e la ricchezza delle nostre lotte locali. Lo scivolamento nel registro morale e astratto, in una retorica che non potrebbe mai essere veramente impiegata tra amici, non è un problema che ha solo il Comitato Invisibile. È proprio alla nostra condizione – una condizione le cui tante trappole e fantasie ideologiche sono rintracciate dal libro con una severità perspicace. Forse è inevitabile che un discorso così incoraggiante abbia bisogno di un punto di appoggio. Non sorprende che esso si trovi in una sorta di vitalismo. Se la nostra sicurezza non è tirata fuori dalle contraddizioni della struttura, dalla logica di ciò che ci domina, dove altro prenderla se non nell’esperienza vissuta e nella sensibilità? Gli autori farebbero bene a prestare attenzione alla risposta dialettica alla tetra frase adorniana di Franco Fortini: “Non c’è vita vera se non nella falsa”. Detto altrimenti, non c’è vita che sia vera in sé, perché, come l’aveva già osservato Lukacs ne La teoria del romanzo, la nozione della vita quale dovrebbe essere, cancella la vita stessa.
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.